Imparare il balenese
Si tratta contemporaneamente di uno dei sogni più antichi e di uno dei progetti più avveniristici. Capire gli animali, traducendone il linguaggio. Che poi vorrebbe dire far breccia nel loro pensiero, calandosi negli altri universi che ci gravitano attorno. In breve, compiere una rivoluzione dello stesso livello di quella galileiana. La possibilità sembra essere più che mai alla nostra portata grazie alle risorse che l’intelligenza artificiale ci mette a disposizione. E i primi animali con cui potremo forse dedicarci a una sconvolgente chiacchierata saranno le balene. A raccontarcelo è il biologo e documentarista inglese Tom Mustill in Come parlare il balenese, edito da Il Saggiatore con la traduzione di Camilla Pieretti. Il suo interesse per la comunicazione con gli altri animali nasce dall’avventura che vive nel 2015 nella baia di Monterrey, in California, quando, al rientro da un’escursione in kayak insieme a un’amica, viene sfiorato da una gigantesca megattera che erompe dall’acqua con uno spaventoso balzo. Qualcuno è del parere che quel gesto sia stato una forma di comunicazione. Ma, se è così, cosa avrà cercato di dirgli, rischiando di ucciderlo, quell’animale che pesa il triplo di un bus a due piani ed è tre volte più grande di un T-rex? Il libro è il resoconto dei tentativi di capire chi siano le balene, creature che abbiamo immaginato per millenni come mostruose – ci si serviva della loro immagine per riempire gli spazi vuoti sulle carte geografiche – e soprattutto silenziose. Per utilizzarle poi, fino ad epoche molto recenti, come fonti di preziose materie prime, a partire da quell’olio che, in qualità di combustibile, aveva il pregio di non far fumo e di essere subito pronto per l’uso. In questo modo siamo arrivati a sterminare almeno tre milioni di esemplari, eliminando il 90% di alcune popolazioni. È solo dagli anni Settanta, quando abbiamo cominciato a studiarli, che i cetacei hanno rivelato di essere animali diversissimi da quello che si immaginava. Di questi mammiferi che 50 milioni di anni fa sono andati a vivere in mare, si è scoperta la complessità e la bellezza del loro canto, con un successo (discografico!) che ha aperto la porta dell’empatia.
Si è compresa la loro propensione ad aiutare individui di altre specie, sia esseri umani che altri cetacei (il cosiddetto mutualismo, di cui recano traccia le culture indigene australiane). Soprattutto si è capito che ai cetacei piace comunicare. E alcune specie, come il capodoglio, sembra proprio che abbiano un corpo fatto apposta per questo scopo. L’udito è il senso su cui si fonda la loro esistenza. Vivendo sott’acqua, le parti esterne delle orecchie si sono appiattite, per cui il suono si incanala nell’orecchio interno tramite particolari strutture adipose poste nelle lunghe mascelle. Le onde sonore passano attraverso la sostanza gelatinosa fino all’orecchio interno, da cui vengono inviate al cervello che “le trasforma in immagini tridimensionali degli oggetti circostanti, rilevandone durezza, forma e intensità”.
I capodogli, in pratica, vedono con l’udito. E non c’è da sorprendersene, visto che trascorrono gran parte della vita nel buio degli abissi oceanici. Ma ascoltare non sembra sufficiente. I capodogli (e con loro i delfini) adorano chiacchierare. Possiamo dire che parlano continuamente per tenersi in contatto tra loro, per cacciare, per orientarsi, per accoppiarsi e per proteggersi. Grandi parlatori, i capodogli, che però emettono suoni tenendo bocca e naso chiusi. Il loro segreto è l’aria. Di fatto, quando questa attraversa le labbra foniche, poste sotto la parte terminale della singola narice situata sul lato anteriore della testa (lo sfiatatoio), queste vibrano l’una contro l’altra e il suono procede dal muso alla fine del cranio, che ha la funzione di un enorme amplificatore. In questo punto si trova un organo, lo spermaceti, che serve a trasmettere e forse a concentrare le onde sonore (il nome nasce dall’errore dei balenieri che pensavano che la sostanza collosa che lì si secerne fosse lo sperma del capodoglio, quello usato poi come combustibile e lubrificante).
Dopo aver colpito il cranio, che ha la forma di una parabola, le onde sonore “rimbalzano e tornano indietro, tremolando, nella parte inferiore dell’enorme testa dell’animale, attraverso il melone”, ovvero una serie di lenti che modificano la vibrazione concentrandola e trasformandola in una successione di “clic potentissimi e perfettamente controllati”. L’intensità dei suoni è straordinaria: può raggiungere i 230 decibel, superiore al rumore di un jet. La varietà di clic prodotta dai capodogli è sorprendente. Ci sono i clic di ecolocalizzazione, i “clic lenti e veloci, ronzii, barriti, stridii e code”, cioè “una sequenza di clic, che vengono mandati a raffica in più direzioni”, con una logica che ricorda quella del linguaggio Morse. Ma non si pensi che le balene parlino tutte la stessa lingua. Ogni branco, composto da una quindicina di esemplari – perlopiù femmine e cuccioli, mentre i maschi vanno e vengono tra branchi diversi – costituisce un “clan vocale”, cioè presenta “dialetti” e abitudini diverse rispetto agli altri branchi. I clan tendono a non interagire tra loro, vivono come tribù diverse. Ma al loro interno avviene una continua trasmissione di informazioni e di conoscenze.
Se il corpo delle balene è fatto per comunicare, viene inevitabile chiedersi che cosa dicano, e quindi, anche, che cosa effettivamente pensino. Sia chiaro, per ora non c’è nessuna risposta, ma, dallo studio del cervello dei cetacei emergono dettagli che fanno supporre di essere di fronte a creature dotate di una certa intelligenza. Lo dimostrano le sue dimensioni (anche se queste da sole non sono prove sufficienti per sostenere che abbiano particolari capacità cognitive); la presenza, nei capodogli e nei delfini, di una neocorteccia più estesa di quella umana; la quantità di neuroni, 10,5 miliardi nelle pseudo-orche contro i 15 miliardi nell’uomo e i 6,2 miliardi dello scimpanzè; la disponibilità di neuroni da poco scoperti, i neuroni VEN, che servono ad attuare collegamenti rapidi quando si parla di altri, attivando empatia – la teoria della mente – e intelligenza sociale. In definitiva, si deve ammettere che le balene sono in possesso di “sistemi neurali formidabili”. A tal punto che diventa lecito chiedersi se possano anche pensare come noi.
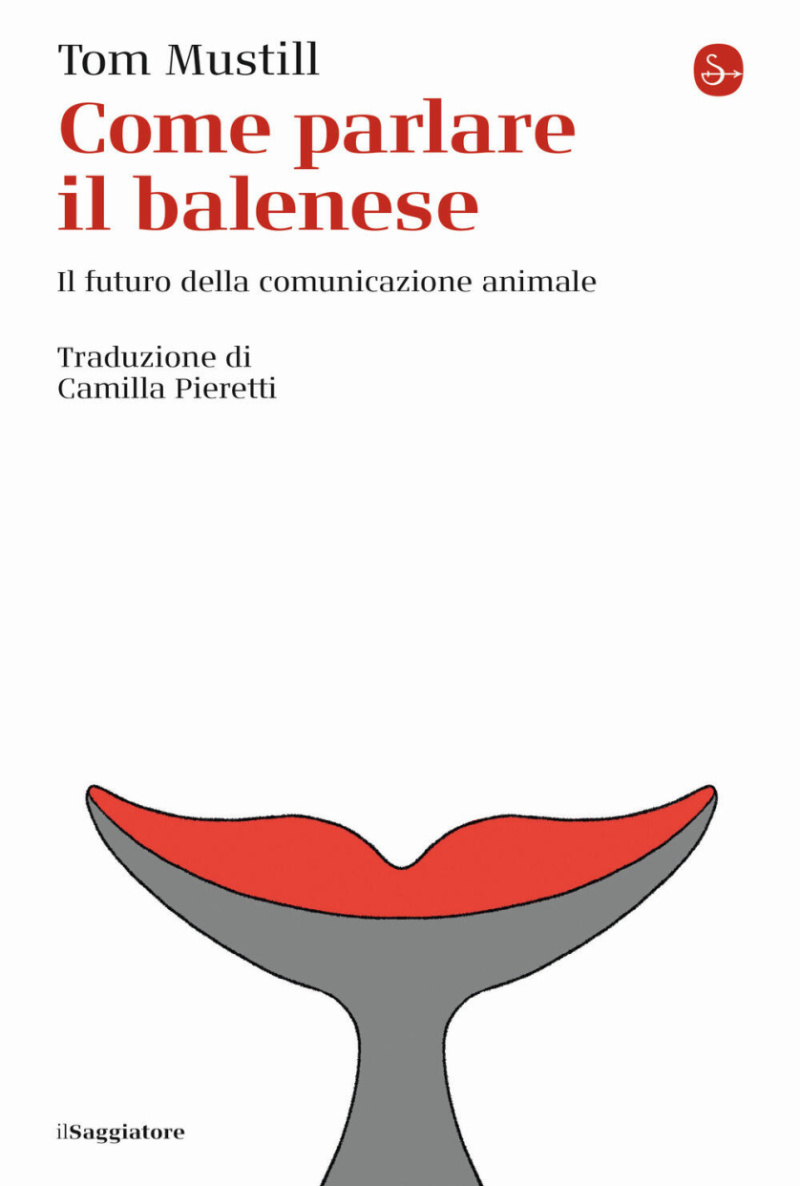
Però la comunicazione attraverso quelli che alle nostre orecchie – quando li percepiamo, visto che possediamo un range uditivo decisamente ridotto – risultano “solo” suoni e una ipotetica attività di pensiero non sembrano sufficienti per affermare con certezza che i cetacei dispongano di un vero e proprio linguaggio. Come mai? Secondo Mustill, questa è l’ultima frontiera dietro a cui si trincera chi afferma la nostra superiorità sugli altri viventi. Il linguaggio, secondo una lunga tradizione che rimonta ad Aristotele, deve rimanere un affare squisitamente umano. Ma è proprio su questo versante che i cetacei sembrano aver rotto le linee difensive dei sapiens. Gli studi sui delfini, in particolare, ci mettono a tu per tu con una specie che, oltre a saper programmare azioni in anticipo, a costruire strumenti, a seguire le indicazioni, a riconoscersi allo specchio (ad avere comportamenti autoreferenziali comunemente intesi come segnale di autocoscienza), possiede indubbie capacità linguistiche.
Basti dire che i delfini possiedono non solo un lessico, ma anche la capacità di usare la sintassi e di dedurre significati dai simboli. Ogni esemplare, inoltre, ha il suo “fischio identificativo”, ovvero un’etichetta vocale che funziona come un nome. E diffusa è la capacità di imitare altre specie, per esempio replicando i canti delle megattere. Che dire? Forse quello che ci impedisce di comprenderli siamo noi stessi? Forse facciamo fatica ad accettare che i cetacei parlino? Superate le diffidenze, rinunciando alle presunzioni antropocentriche e alle altrettanto pericolose tendenze all’antropodiniego (cioè al rifiuto di un comportamento animale che sembra simile a quello umano), potremmo arrivare ad ammettere che sì, gli animali – a questo punto non solo i cetacei – possiedano un linguaggio? E, ammesso che lo si accetti, si potrebbe cominciare a pensare alla possibilità di stabilire un contatto con quel linguaggio? Potremo arrivare a dire, come si immagina Mustill, “Io umano, tu delfino”? Potremo parlare il balenese?
Un aiuto ci arriva dalle macchine. Negli ultimi anni gli strumenti della tecnologia hanno trasformato le nostre capacità di percepire gli animali. Abbiamo strumenti per ascoltarli, per fotografarli, per riprenderli in ogni istante della loro vita. Sono nati centri di ricerca internazionali che dispongono apparecchiature nei mari, tra gli alberi delle foreste, nell’aria. La quantità di informazioni che andiamo accumulando sugli animali, su quello che fanno, su come comunicano tra loro e con noi, si va moltiplicando. Il problema diventa la “lettura” del materiale. Per affrontarla, si lavora sul riconoscimento dei pattern. Avvalendoci cioè di uno dei punti di forza della nostra specie, che sa “interpretare i segni del mondo che ci circonda, identificare e condividere tendenze, e così facendo, riesce a sopravvivere”, si va alla ricerca di forme e comportamenti ripetuti. Ed è da questa azione condotta sul cumulo di informazioni che discende l’ulteriore possibilità. I macchinari usati per registrare possono infatti a loro volta imparare, grazie all’intelligenza artificiale (IA). E gli algoritmi, organizzati in “reti neurali artificiali”, ispirati alle reti di neuroni dei cervelli animali, consentono l’“apprendimento profondo”.
In altre parole, grazie all’IA sarà possibile capire, districarsi all’interno della ridda di suoni e immagini registrati dai ricercatori e decifrare i linguaggi animali, a partire proprio da quello delle balene. Alcuni esperti informatici – giovani menti geniali della Silicon Valley come Aza Raskin e Brit Selvitelle – hanno pensato di sfruttare la potenza della tecnologia che alimenta Google Traduttore per applicarla alle comunicazioni animali. In che modo? “Mappando tutti i vocalizzi emessi da una certa specie fino a creare una galassia di versi e poi confrontare i pattern così riscontrati con quelli di altre specie”. Nonostante la mole di dati – esito dell’attività di un numero crescente di strumenti informatici che hanno reso paragonabile quanto sta avvenendo all’esplosione cambriana, cioè al momento in cui, 540 milioni di anni fa, hanno incominciato a comparire forme di vita complesse – fino a pochi anni fa era evidente un problema. Tutti i progetti, spiega Mustill, “lavoravano su frammenti”.
Cercare di capire cosa stia dicendo una balena avendo a disposizione minuti o ore di audio senza però riuscire a comprendere con chi stia parlando o cosa stia facendo, “è come cercare di decifrare parte di un copione strappato in mille pezzi, con i nomi dei personaggi oscurati”. Ed è a questo punto, siamo nel 2019, che, ad Harvard, entra in gioco il CETI (Cetacean Translation Initiative), un “progetto colossale”, il quale, mettendo insieme “specialisti di robotica marina, cetologhi, maghi dell’IA, esperti di linguistica e di crittografia e specialisti dei dati” appartenenti a un pool di prestigiose università, con il sostegno di Twitter, Google Research e il finanziamento di TED Audacious, della National Geographic Society e di Amazon Web Service, si propone, come ha affermato chi lo presiede, il biologo marino David Gruber, di “imparare a comunicare con una balena in modo da potersi scambiare idee ed esperienze”, entro il 2026. L’oggetto di studio è una ristretta popolazione di capodogli al largo dell’isola di Dominica, ai Caraibi, che, dopo essere stata marcata in modo da poter monitorare i singoli esemplari, viene costantemente ascoltata attraverso una serie di stazioni poste sui fondali del mare e in superficie, andando a formare un “social network” con cui “ricostruire le storie delle loro vite e ricollegarvi i diversi vocalizzi”. I big data saranno poi passati al vaglio dell’IA. E da qui si spera di poter finalmente estrarre il balenese.
Parlare agli animali, parlare con gli animali, farebbe cadere l’ultima parete che ci divide da loro. Sarebbe da un lato la conclusione di un percorso iniziato con Darwin e l’inizio di un’epoca nuova, in cui la nostra specie dovrà mettere definitivamente da parte l’idea della propria superiorità sul vivente. In questi termini andare alla ricerca del balenese diventa il mezzo più eversivo possibile per agganciare il mondo animale, per renderlo davvero contiguo al nostro. Chi potrebbe continuare a ignorare o a maltrattare (ma anche a mangiare?) una creatura con cui è riuscito a scambiare parole d’intesa? Con cui ha avviato una relazione fondata sul linguaggio e dunque, almeno dalla nostra prospettiva specifica, su quanto di più profondo si può immaginare? È forse questa la strada per frenare l’estinzione delle altre creature che stiamo portando a termine nella più completa indifferenza?







