Joséphine, un reportage d’amore
Rolin è uno scrittore prolifico, molto amato e premiato in Francia e, per inspiegabili ragioni editoriali, quasi non tradotto in Italia, se si escludono il volume appena pubblicato da Quodlibet e Il recinto, uscito per Barbès nel 2008. Joséphine arriva a colmare in parte questo vuoto, restituendo al pubblico l’abilità e la sensibilità elettrica di un autore ancora tutto da scoprire (editori italiani permettendo). Cresciuto tra la Bretagna, il Congo e il Senegal, Rolin è un reporter abile nel restituire la complessità di realtà sociali marginali, svantaggiate, antagoniste, siano esse quelle dei portuali e dei clandestini raccontate nell’epopea working class di Terminal Frigo, siano quelle del popolo che anima il boulevard Ney della periferia nord di Parigi di Il recinto, o come in L’Organization, romanzo in cui rievoca l’esperienza giovanile nella Sinistra Proletaria, vincitore nel 1996 del Prix Médicis, o ancora l’umanità incontrata nell’odissea di La ligne de front, che descrive le sue peripezie attraverso le contraddizioni e la vitalità dell’Africa Meridionale (premio Albert Londres per il reportage). Il racconto del mondo e quello del privato si intrecciano nel corso di una trentina tra romanzi, racconti e non-fiction, accanto al lavoro giornalistico per testate quali Libération, Le Figaro e Le Monde.
Scrittore e giornalista, come molte tra le voci migliori che hanno saputo raccontare la realtà rimanendo aderenti a essa, Rolin compone una lettera, scritta a un anno dalla morte della protagonista, alla quale affida il compito di restituire al lettore quella parentesi luminosa che è stata la sua breve e bruciante relazione con la donna che dà il titolo al romanzo. Senza scomodare Dickens, Zola o London, siamo piuttosto dalle parti di Kapuściński, Terzani, Fallaci o, più recentemente, di William T. Vollmann, forse l’autore che per ambizione e attitudine incarna meglio l’epitome dello scrittore-reportagista, elevandone la funzione a iperbolico tentativo di abbracciare e restituire la realtà tutta attraverso un inarrestabile flusso di parole.
Talvolta, la scrittura si fa negromanzia. Trafficare con i misteri della vita e della morte e cercare di superarne i limiti esige un costo, anche quando lo si fa attraverso una storia. Rolin, giornalista di fama internazionale, viaggiatore e scrittore, in questa breve confessione cerca di restituire alla vita Joséphine, giovane donna amata e perduta a trentadue anni per un’overdose di eroina. Con la stessa purezza disarmante della protagonista, il racconto procede per sistole e diastole, ricomponendo i frammenti di un amor fou rievocato attraverso la forma classica della confessione, un breve arco narrativo in cui una scrittura dritta, priva di orpelli, illumina memorie ancora palpitanti
Nel corso delle pagine, l’autore dichiara la propria colpa nel non aver saputo capire l’entità del dolore nel quale la donna amata si è persa, fino a giungere a una tragica e prematura fine. Ma non ci sono colpi di scena, tutto è scritto nel copione di mille altre vicende di amori tossici. Eppure, Rolin riesce a restituire l’incanto dello sguardo innamorato, il desiderio e la ferocia che alimentano la tensione verso l’autodistruzione che lega i due amanti, entrambi consumatori di eroina: l’uno, sempre in grado di riemergere dalla dipendenza grazie al lavoro giornalistico che lo àncora alla vita, l’altra, in balìa della depressione e dei propri inferni, alla ricerca di quell’attenzione e quell’amore che soli sembrano poter riparare, e dissimulando al contempo una disperazione assoluta, alimentata anche dagli effetti della dipendenza.
Si diceva della scrittura come negromanzia, e certo Joséphine è il tentativo di restituire alla vita chi della vita è stata così colma da venirne esondata. Come un Orfeo, Rolin scende negli inferi sapendo che la sua Euridice non può tornare, e tuttavia, nello spazio racchiuso tra le pagine, gli è concesso di rivivere quella stagione d’amore brevissima e irripetibile, e tanto basta a dare senso a un tentativo che si sa, non può che essere destinato a fallire. Quale sia il pegno da pagare per non poter accettare l’oblio, la letteratura e il cinema lo hanno raccontato con innumerevoli varianti dello stesso archetipo, dove i revenants sono (quasi) sempre solo i simulacri di chi è stato, e (quasi) sempre sono destinati a causare catastrofi nelle vite di chi ha la sfortuna di invocarli, che si tratti della donna che visse due volte di Vertigo di Hitchcock o il clone di carne artificiale e bit di Black Mirror (nell’episodio Torna da me, del 2013), che sia la Ligeia di Poe o l’inconsapevole sosia di Il gabbiano di Sandor Marai.
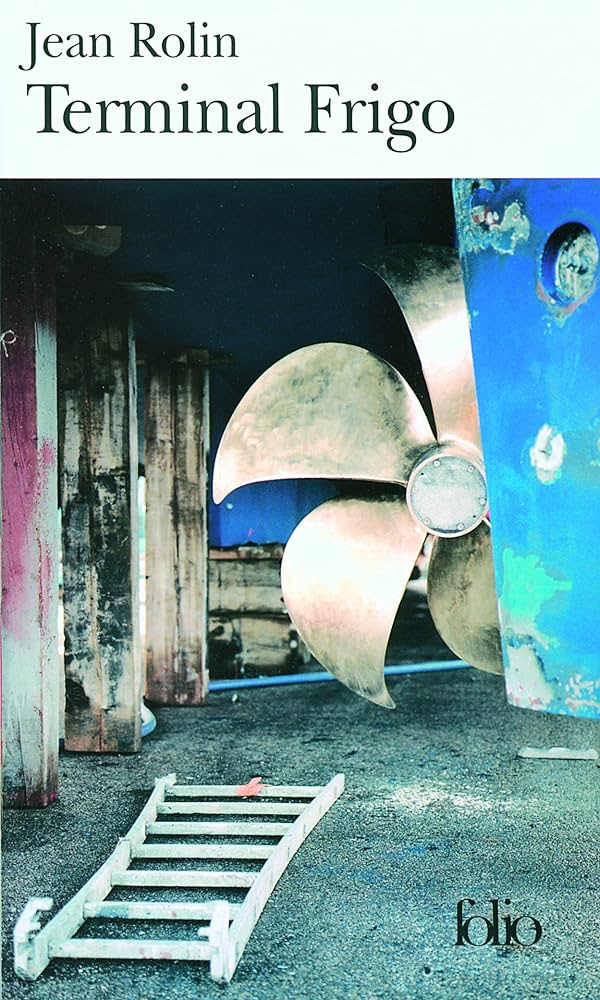
L’autore è condannato a perdere di nuovo l’amata, ancora e ancora, e la fantasmagoria non può che rinnovare il ciclo di apparizione e scomparsa, impedendo che la fine si compia una volta per tutte. Quasi per una maledizione, Joséphine non sarà l’unica donna amata e perduta da Rolin: in maniera dolorosamente profetica, il libro si lega idealmente a Savannah, del 2015, nel quale l’autore ripercorre il viaggio fatto nel sud degli Stati Uniti insieme all’amica Kate Barry sulle orme della scrittrice Flannery O’Connor; Berry, morta suicida nel 2013, è una fotografa di talento con la quale realizza nel 2012 il volume Dinard: Essai d'autobiographie immobilière, figlia di Jane Birkin e sorella di Charlotte Gainsbourg. Ma questa è un’altra storia, anche questa d’amore e di morte.
Mi sono chiesta, una volta chiusa l’ultima pagina del libro, se la donna ritratta in copertina fosse anche la donna raccontata nelle pagine dall’autore. Lo scatto è leggermente mosso, coglie una giovane donna che si trova di fronte all’obiettivo in un istante di passaggio, tanto che il suo sguardo è rivolto in basso e le sue labbra sono schiuse, come per pronunciare una parola o come se stesse già parlando. Si tratta, in realtà, della foto di un autore anonimo, che ricorda un po’ certe atmosfere alla Nan Goldin, e se per un attimo ho supposto potesse trattarsi proprio della protagonista raccontata dallo scrittore francese, è perché l’operazione perseguita nelle ottantanove pagine dell’edizione italiana è così riuscita da avermi indotta nell’ingenua fantasia di trovarmi di fronte davvero alla donna evocata dall’autore. Potere della letteratura, che fa vacillare le più solide convinzioni: dichiaro apertamente di non far parte di quel pubblico di lettori avidi di memoir ed entusiasti dell’autofiction, né posso ascrivermi tra le fila di chi ritiene che la componente biografica di una storia costituisca un valore aggiunto. Ma il romanzo di Rolin riesce a evitare i cliché e i cronachismi, restituendo alla categoria dell’universale la vicenda dei due amanti. Data la dichiarata aderenza rispetto alle vicende reali, si aprirebbe qui la mortale disputa attorno a ciò che è o non è romanzo, a ciò che è o non è il realismo. Proprio perché costruito riportando in pagina i momenti di una vicenda documentabile e documentaria, è certo un romanzo a tutti gli effetti, frutto del processo di montaggio, ellissi e invenzione della memoria, filtrato attraverso la sensibilità dell’autheur. Il romanzo di Rolin allora possiede quel carattere di autenticità letteraria tale da compiere il salto acrobatico che permette alla materia spuria della vita privata, una materia disorganizzata e informe, di trasformarsi in letteratura, acquisendo quel grado di verità che nella realtà stessa è inafferrabile e che si rivela a noi solo attraverso il tradimento perpetrato dall’atto creativo. Siamo di fronte a una scrittura mimetica, che prende la forma del flusso di coscienza, nutrendosi di dettagli infraordinari e intermittenze di vita accaduta. “Il realismo non è la storia di un rispecchiamento piatto e subalterno, ma di uno svelamento impossibile”, scrive Walter Siti in Il realismo è l’impossibile (Nottetempo, 2013), e Rolin tenta proprio la strada solo apparentemente lineare di arrivare all’Assoluto partendo dal minuscolo, un dentifricio rosa che rendeva più bianchi i suoi denti, la giacca di canguro, i “paris-brest” che sono l’unico cibo di cui la donna si nutre negli ultimi giorni, l’elenco dei luoghi che fanno da sfondo alle vicende – La Rochelle, Dinard, Saint-Martin-de-Ré, Parigi, Vans, Meudon per visitare la casa di Céline, Arles, Fos, Beauduc, Saint- Nazaire, il porto di La Pallice – e tutto quello che tra questi trascurabili frammenti di realtà non viene raccontato, tutto quello che della vita l’autore tace ma rende immaginabile, e che per il lettore, magicamente, delinea un mondo coerente e tangibile. Citando ancora Siti, “Il realismo oppone la realtà alla Realtà; lo scrittore realista è una scimmia della natura ma anche uno stolto demiurgo che cerca di mimare una Creazione che non conosce; se non temessi di apparire ridicolo, parlerei di realismo gnostico.” Nel conflitto tra la realtà e il tentativo di ricostruirla secondo il proprio desiderio, Rolin si pone come un demiurgo fin troppo umano, la cui ambizione non può che apparire da subito disperata e, anche per questo, così comprensibile, così capace di generare compassione. Non possiamo che accompagnarlo nell’Ade, almeno per poggiargli una mano sulla spalla e dire che sì, aveva proprio ragione e quel viaggio andava fatto, quelle pagine scritte, perché una volta conosciuta Joséphine sarebbe stato impossibile “non innamorarsi perdutamente di lei”.







