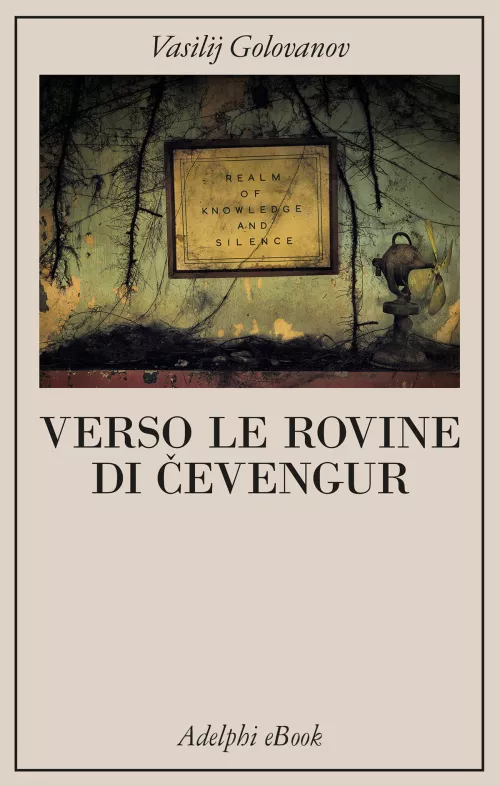Luoghi comuni sulla Russia
Nel novero dei generi letterari, il racconto di viaggio è forse l'unico ad avvicinarsi al compimento della celebre formulazione retorica dell'ut pictura poesis, non tanto per la sua peculiare tendenza ad articolarsi per descrizioni, quanto perché il rimando di tali descrizioni a una realtà esperibile (il viaggio) ne trasferisce sul piano spaziale l'elemento temporale che sta alla base di qualsiasi narrazione. Ovviamente tale formulazione funziona a pieno regime qualora il racconto si muova seguendo un criterio di oggettività per così dire responsabile – le descrizioni, puntuali ed esaustive, di terre e popoli lontani osservati con i propri occhi tipiche della tradizione anglosassone – ma quando i luoghi descritti si fanno metafora di una condizione esistenziale, spirituale o politica che dir si voglia, l'avvicendamento della temporalità del racconto con la dimensione spaziale della realtà fenomenica assume un carattere di complessità tale da smuovere la terra stessa sulla quale lo scrittore si è messo in cammino.
Si pensi ai famosi Racconti di un pellegrino russo quale esempio di una analoga situazione, laddove, a una descrizione di viaggi (con ogni probabilità del tutto immaginari) attraverso l'immensità degli spazi della Russia, corrisponde l'approssimarsi a un ordine temporale di natura superiore, idealmente rappresentato da un centro metafisico che sarebbe, secondo i dettami della teoria esicastica che sostiene l'ideologia del racconto, la meta di qualsiasi pellegrinaggio verso l'ascesi spirituale.
La spasmodica ricerca di lenimento a un disagio esistenziale, che riflette il senso di smarrimento nel quale la Russia è sprofondata dopo il tramonto dell'utopia sovietica, è il tema che anima i pellegrinaggi riportati in Verso le rovine di Čevengur di Vasilij Golovanov (Adelphi, 2023), raccolta di racconti di viaggio meritevole di approfondimento pur a fronte delle sue vistose carenze formali e della banalità dei suoi contenuti; è in effetti da simili operazioni editoriali che si può ricavare una lezione circa il problematico rapporto intrattenuto dall'Occidente con la cultura russa, la cui natura è stata analizzata da Luigi Zoja, su queste stesse pagine, in un articolo puntuale ma che ci sembra trascuri un punto della questione ai nostri occhi assai importante, cioè a dire il problema delle modalità di ricezione della suddetta cultura in Occidente. Dato per supposto che l'inquietudine descritta da Golovanov trovi una sponda nel senso di smarrimento che attanaglia anche la nostra civiltà e che essa si possa assumere quale metro di giudizio per misurare la nostra perdita del centro (per usare un'espressione cara a Ernesto De Martino ripresa da Hans Sedlmyr) quel che colpisce, a una prima osservazione del testo, è il profluvio di luoghi comuni sulla Russia utilizzati dall'autore quali formule caricate di significato salvifico – luoghi comuni che, agli occhi del lettore appassionato di letteratura russa, subito richiamano alla mente un universo familiare. La steppa sconfinata e la piccola izba, l'ingenua sapienza contadina e la tendenza verso l'Assoluto, le armate a cavallo e l'odore di incenso, nulla manca in questo arsenale semantico per evocare il mondo dei romanzi di Tolstoj e di Dostoevskij, del cinema di Pudovkin e di Tarkovskij, del teatro e dei racconti di Čechov, della lirica di Puškin e di Blok. Una teoria di forme talmente riconoscibili da indurre il sospetto di una precisa volontà nel soddisfare le aspettative del pubblico occidentale, abituato a rapportarsi con l'alterità secondo canoni stereotipi. Inutile dunque vagheggiare circa affinità spirituali basate su archetipici bisogni, quando il nostro rapporto – mediato dal luogo comune – con la Russia ci appare storicamente verificabile; più utile e produttivo sarebbe invece sforzarsi di identificare quei meccanismi che, attraverso il luogo comune, orientano il gusto dei lettori verso la ricezione ideologica di manufatti culturali provenienti da paesi lontani. Nel caso di Golovanov, l'approccio marcatamente estetico al genere letterario in questione ci spinge a una valutazione più attenta della sua piaggeria, per non dire delle sue intenzioni.
Il viaggio come tensione verso un'origine inafferrabile, l'elogio del nomadismo quale stile di vita raccordato con un ritmo temporale propriamente umano, la scelta del vagabondaggio come antidoto allo sradicamento esistenziale, il bisogno di perdersi per ritrovarsi: il massiccio utilizzo da parte di Golovanov di questi futili cliché sembra voler riproporre il feticcio romantico del viaggio quale nostalgia di infinito e ritorno alle origini, articolato all'interno di una cornice narrativa viziata dalla presenza opprimente di un simbolismo iniziatico. In quest'ottica trova una spiegazione il ricorrente artificio retorico della nostalgia dei bei tempi andati che, nel corso della narrazione, si appoggia a una pletora di citazioni, più o meno esplicite, di autori quali Eliade, Guénon e Tolkien, a suggello di un orientamento decisamente retrivo nel considerare il concetto di tradizione culturale.
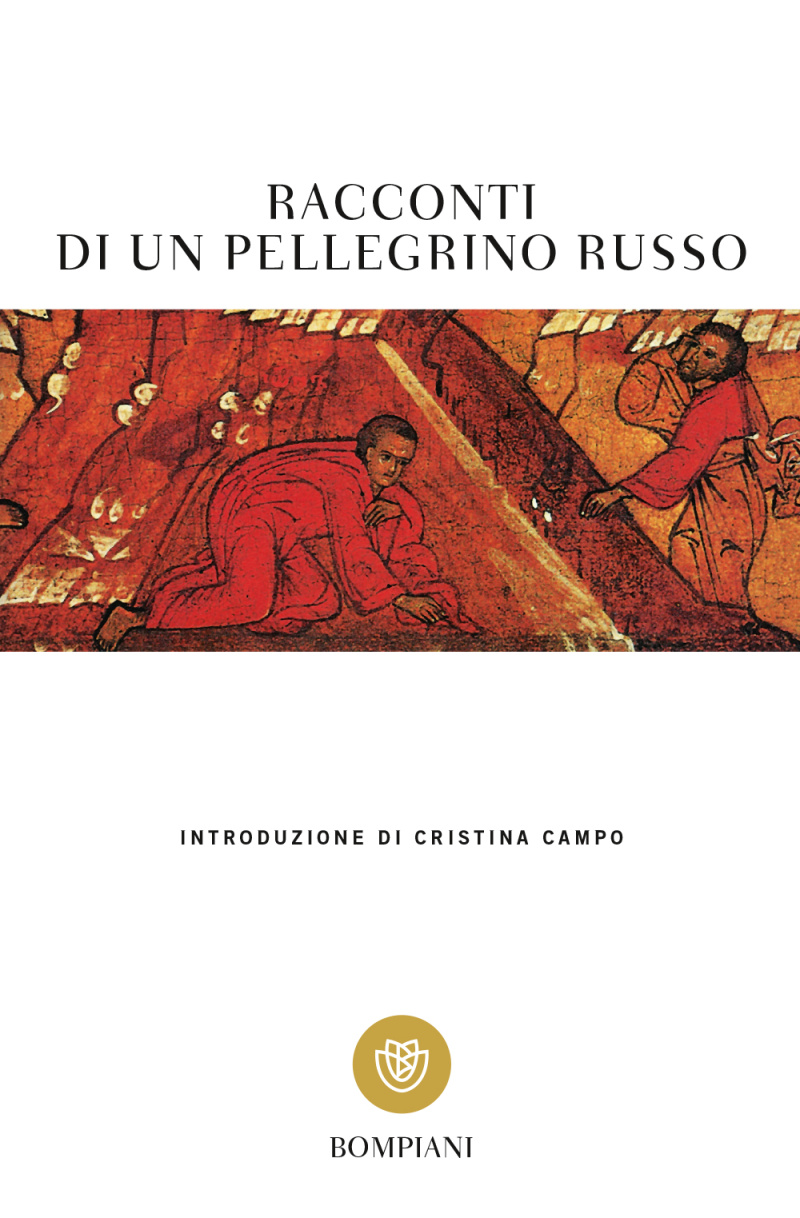
L'idea del viaggio come riscoperta delle radici mitiche della nazione si accompagna qui a uno dei più vieti luoghi comuni sulla Russia, quel meccanismo cioè che opera nel presentarne l'immensità dello spazio quale fattore determinante di una peculiarità del tempo, cui corrisponde una vera e propria filosofia della storia: nascosto tra le ombre di questo meccanismo, una sorta di genius loci è posto a garanzia del lento trascorrere del tempo delle steppe asiatiche – tempo infinito e, di conseguenza, saturo di possibilità, se confrontato con l'angustia del tempo europeo, civilizzato e scandito sul ritmo sterile e impersonale dell'efficienza e della produttività.
Che il tempo russo sia più lento e, di conseguenza, più umano del nostro è, con ogni evidenza, un vuoto stereotipo; è vero però il fatto che esso possiede una qualità specifica nel contesto più generale della cultura religiosa greco-ortodossa. Per stare al luogo comune, il tempo dell'Ortodossia trova nell'immutabile ripetizione del rito un andamento ciclico, al netto dell'idea cristiana di progresso lineare verso la seconda parusia; nella prospettiva storica, esso presenta uno spiccato carattere di spazialità, la cui origine si può far risalire, con ogni probabilità, all'influenza dell'antica filosofia stoica che, nel considerare il tempo come intervallo che accompagna il movimento del cosmo, sostituiva l'idea di durata con quella di distanza. Questa natura per così dire geometrica del tempo sancisce la finitezza dello spazio, pur nell'eterna ripetizione di un moto circolare. Non l'estensione dello spazio a determinare la qualità del tempo, ma piuttosto una qualità spaziale del tempo stesso: un dispositivo simbolico altamente efficace in grado di significare un ordine cosmico che ruota intorno al mistero dell'incarnazione di Cristo, ciclicamente rifondato dal rituale.
Ora, la pretesa relazione simbolica tra l'immensità dello spazio e una specificità storica plasmata dal destino, può forse funzionare a livello retorico ma, miticamente parlando, non svolge quel compito che ogni simbolo efficace è chiamato ad assolvere, cioè quello di produrre valore sociale; piuttosto, essa ripete parole vuote, identificabili con il silenzio del simbolismo funerario di bachofeniana memoria. Per citare Pavel Florenskij: "La comune idea che ci si fa del simbolo, come qualcosa di autosufficiente, anche se in parte condizionato, di vero, è radicalmente falsa, perché il simbolo o è più o è meno di ciò. Se il simbolo, in quanto conforme allo scopo, raggiunge lo scopo, esso è realmente indivisibile dallo scopo – dalla realtà superiore che esso rivela; se esso invece non rivela una realtà, ciò significa che non ha raggiunto lo scopo e pertanto in esso non è possibile ravvisare un'organizzazione conforme a uno scopo, una forma, e significa che, mancando questa, non è un simbolo, non è uno strumento dello spirito, bensì mero materiale sensibile." (Le porte regali, Adelphi 2012). Fuor di metafora, riprendiamo De Martino e definiamo questa assenza di forma, questa non conformità del simbolo al suo scopo, quale espressione di un simbolismo mitico-rituale storicamente inefficace, poiché incapace di rifondare una realtà, e dunque passibile di pericolose derive psicopatologiche. Oppure limitiamoci a osservare che l'elezione del luogo comune a simbolo salvifico è, spesso e volentieri, un'operazione puramente ideologica, e torniamo con i piedi ben piantati per terra.
C'è davvero un'ideologia dietro al libro di Golovanov? Le sue divagazioni sulla steppa russa quale metafora di una redenzione del tempo corrotto, sul recupero della tradizione popolare quale motore di rinnovamento spirituale, sulla ricerca di un'origine mitica quale antidoto all'angoscia del divenire, sono determinati da una precisa volontà di opposizione attiva alla modernità e alle sue contraddizioni? O non è forse il nostro giudizio, viziato dall'attualità, a voler individuare a tutti i costi un'intenzione quantomeno sospetta dietro alla banalità di simili discorsi? Difficile a dirsi: l'esiguità dei dati biografici dello scrittore riportati nell'edizione e reperibili in rete, e la conseguente impossibilità di valutare la sua storia personale nel contesto in cui l'opera è stata prodotta, non permettono di stabilirlo con certezza. Contribuisce alla difficoltà di messa a fuoco l'ambiguità di fondo che percorre tutto il libro, laddove alle suddette divagazioni si somma una scelta di numi tutelari quali Chlebnikov, Bakunin e Platonov (figure ispiratrici dei racconti più lunghi della raccolta) che pare suggerire un anelito verso l'utopia che contraddice radicalmente gli elementi reazionari che allignano nel testo. Ci limiteremo dunque a un'ultima serie di considerazioni, ricavate dalla lettura e da una serie di indagini che ne sono seguite, per azzardare una valutazione nel merito.
Grande fu la confusione sotto il cielo nell'apocalisse dell'epoca sovietica, quando un'intera generazione di intellettuali russi visse la riscoperta di libri e di autori affossati dalla censura dei decenni precedenti, e cavalcò l'entusiasmo di un tempo rinnovato e gravido di speranze circa un futuro migliore – speranze disattese da quello che, nell'attuale congiuntura storica, sempre più ci appare come un ritorno a un passato segnato dalla brutalità autocratica e supportato dal rilancio di un sentimento religioso oscurantista. In quest'ottica ci sembra coerente il riferimento di Golovanov a Čevengur, capolavoro di Andrej Platonov sul tradimento dell'utopia socialista operato dai bolscevichi, romanzo percorso da un afflato messianico e che si muove seguendo il paradosso del materialismo storico chiamato a riscattare l'umanità dai suoi mali universali. Ma, se Golovanov si rifà a Platonov, perché al termine del suo racconto sugli sgangherati vagabondaggi alla ricerca della leggendaria città di Čevengur – luogo letterario in cui si è tentata la realizzazione di un comunismo dal carattere cosmico – si conclude con un'improvvisa verticalizzazione del racconto supportata da un'estemporanea citazione di La scala del Paradiso di Giovanni Climaco (testo capitale della tradizione mistica ortodossa) subito seguita, peraltro, dall'inquietante scoperta di un sito di lancio missilistico abbandonato e sperduto nella steppa, testimonianza di un'apocalisse scampata ma pur sempre incombente? In altre parole, perché l'utopia si è fatta misticismo, dove il termine dell'ascesi viene a coincidere con l'indizio di una minaccia costante alla sopravvivenza dell'umanità?
Forse la risposta andrebbe cercata nella storia dei primordi dell'avanguardia artistica russa, in quei simbolisti che, alla fine del XIX secolo, presentirono l'avvento di tempi nuovi e che scelsero deliberatamente di rifugiarsi in un estetismo strutturato per luoghi comuni, di fronte alle incipienti avvisaglie di apocalittici stravolgimenti; in particolare, pensiamo agli ultimi rappresentanti di questa scuola che, a partire dall'utilizzo del simbolo estetico come strumento espressivo, finirono per avvicinarsi sempre di più a quel rinascimento della tradizione iconica quale forma storica di una realtà sovrasensibile incarnata, del quale Pavel Florenskij è stato il più importante promotore e che il regime sovietico soffocò con un vigore degno degli obiettivi imprescindibili.
Ma forse anche questa non è altro che una suggestione, un prodotto di quel riflesso condizionato con il quale le nostre menti, imbevute di razionalismo, reagiscono di fronte alla Russia che spiega se stessa, quando i luoghi comuni concernenti la sua storia drammatica, la sua arte sublime e la sua profondità spirituale si impongono alla coscienza dell'Occidente secolarizzato.