Matsutake / Anna Tsing e il fungo della fine del mondo
Un fungo ingovernabile
Quando si pensa a Hiroshima viene subito in mente l’immagine del funghetto che si erge verso il cielo, emblema del cosiddetto sublime atomico. Tuttavia pochi sanno che a Hiroshima, dopo la catastrofe, la prima forma di vita a spuntare tra le macerie è stato un fungo matsutake. Ad agosto comincia del resto la sua stagione di maturazione. Lo stesso è accaduto a Fukushima nel 2011. Questo fungo infatti non è conosciuto solo per il suo odore pungente (per alcuni un puzzo insopportabile), per essere una prelibatezza della cucina giapponese o per assorbire il cesio e i radionuclidi, ma anche per crescere – esclusivamente e spontaneamente – sui suoli degradati dall’azione umana. Poco importa che si tratti di catastrofi nucleari o della lava delle eruzioni vulcaniche come in Oregon, che è diventato un importante esportatore di funghi sin dal 1986, quando quelli europei erano contaminati da Chernobyl.

Ogni tentativo di coltivare il matsutake è fallito; cresce dove e quando vuole lui, anche sui terreni in cui le attività agricole e industriali hanno causato mutamenti irreversibili. È il fungo della crisi del capitalismo, che rimette in gioco vecchi modelli biologici, ecologici e antropologici. A suggerirlo è l’antropologa Anna Lowenhaupt Tsing in The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins (Princeton University Press 2015, tradotto in francese nel 2017, edizione qui citata).
416 pagine, sette anni di ricerche sul campo (2004-2011): cosa avrà mai da dire Tsing su un singolo fungo? E perché questa lettura – articolata in tanti brevi capitoli come un grappolo di funghi – dovrebbe interessare chi, come me, di funghi ne ha colti pochi e non è neanche certo di aver mai assaggiato il matsutake in questione?
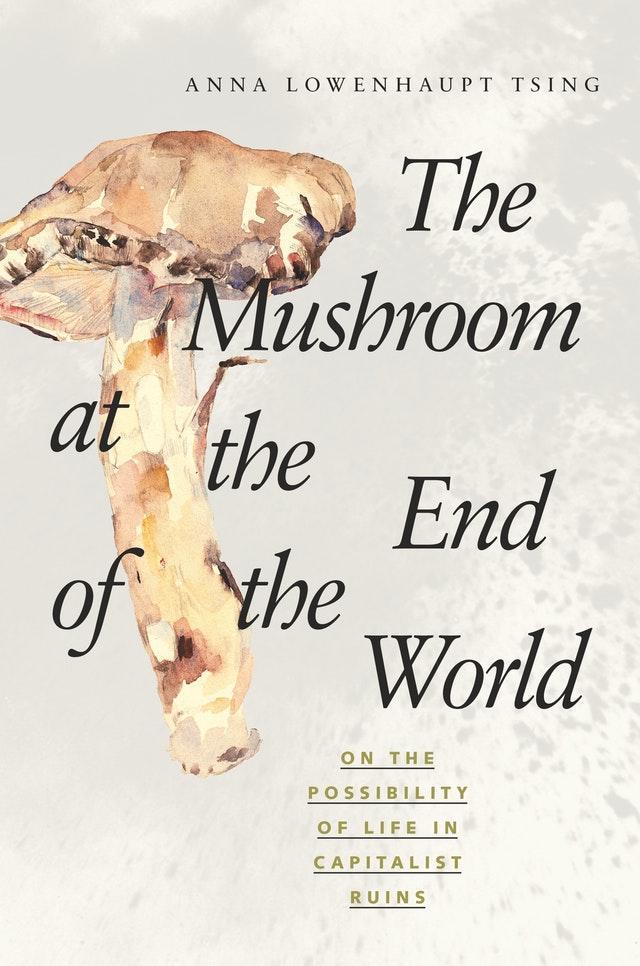
La vita dei funghi è certo prodigiosa. Riprendendo le ricerche del micologo Alan Rayner, Tsing ci ricorda che, se il corpo umano raggiunge presto una forma determinata, i funghi continuano a crescere e a cambiare forma lungo l’arco della loro vita, a seconda dell’ambiente e degli incontri. Potenzialmente immortali, non muoiono di vecchiaia. Ora, se gli appassionati di micologia troveranno pane per i loro denti, The Mushroom at the End of the World – uno degli studi più influenti finora usciti sull’Antropocene – ci aiuta anzitutto a orientarci nel mondo.
Al riguardo, Tsing ha già diretto l’AURA (Aarhus University Research on the Anthropocene), un programma di ricerca trans-disciplinare sui paesaggi “human-disturbed” e sulla vita che si genera sulle rovine della modernizzazione. Ha coinvolto biologi, antropologi, storici dell’ambiente e di science studies, geografi e climatologi, al di là della divisione sclerotizzata tra scienze della vita e scienze umane, tra mondo e rappresentazione del mondo. Chi vuole saperne di più avrà presto a disposizione uno strumento prezioso: Feral Atlas. The More-Than-Human Anthropocene, curato assieme a Jennifer Deger, Alder Keleman e Feifei Zhou (Stanford University Press 2020).

Fabbricare mondi
Per immergerci nel cuore del problema basta seguire il ciclo di produzione del matsutake, raccolto nelle foreste dell’Oregon da immigrati del Sud-est asiatico e poi importato in Giappone da dove è scomparso negli anni settanta a causa di vent’anni di urbanizzazione: i combustibili fossili prendono il posto della legna e del carbone, le foreste rurali sono abbandonate dalle aziende agricole e dai contadini che si trasferiscono in città, l’agricoltura intensiva s’impone come nuovo modello e così via.
Quella del matsutake è insomma una storia che coinvolge diversi continenti (altre coltivazioni sono in Cina e in Finlandia). Una connessione globale già trattata da Tsing in un libro sulla distruzione delle foreste pluviali dell’Indonesia negli anni 1980-90 e sulla salvaguardia dell’ambiente promossa da popoli indigeni, associazioni e vari attivisti (Friction. An Ethnography of Global Connection, 2005, un terreno di studio già esplorato nel precedente In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place, 1994).

Più che ai conflitti Tsing s’interessa alle connessioni globali che investono le cause ambientali. E non c’è matsutake senza i tentativi di coltivazione, la raccolta, la messa in commercio, la filiera con i suoi intermediari, un complesso sistema di dono e contro-dono che si sottrae alla logica della merce e costituisce la spina dorsale di quel sistema mercantile ora in rovina. E non c’è matsutake senza la comunità di rifugiati dell’Indocina (Laos e Cambogia) che, nelle foreste dell’Oregon, lavora a fianco di veterani bianchi della guerra del Vietnam, Latinos e indiani d’America. Nessun inganno, nessun melting pot: qui come altrove negli Stati Uniti le comunità vivono gomito a gomito senza alcuna conoscenza – e curiosità – dell’altro.
Nel corso degli anni, la comunità asiatica di raccoglitori si è evoluta: fino alla Seconda guerra mondiale i giapponesi immigrati abbracciavano lo stile di vita americano pur mantenendo una sensibilità giapponese. La guerra mette in moto un processo di assimilazione forzata, indotta dall’educazione pubblica e da politiche di discriminazione positiva, che coinvolgono direttamente la famiglia dell’autrice. La lingua giapponese non è più studiata e viene dismessa o vista con sospetto l’alleanza biculturale. Ogni giapponesità è abbandonata, coltivata tutt’al più come hobby. Diversa la situazione attuale, all’epoca del multiculturalismo liberale: l’accoglienza dei raccoglitori, immigrati del Sud-est asiatico, dipende da un solo fattore: l’amore per la libertà promossa dalla democrazia americana.

Infatti se tra queste comunità e quelle dei bianchi ci sono a volte delle tensioni, a unirli è l’anti-comunismo, il valore della vita all’aperto, l’assenza di padroni e il fatto di non essere impiegati da alcuna impresa. Vivono nelle pieghe del sistema capitalistico, o meglio dipendono globalmente dalle sue fluttuazioni ma si sottraggono alla sua organizzazione, nel bene come nel male (non hanno stipendio né vantaggi sociali). Vendono i funghi che trovano e, non essendo coltivabili, vivono nella precarietà.
La precarietà è uno dei modi in cui, secondo Tsing, si declinano le rovine del capitalismo: “cosa ne è della vita”, si chiede, “quando mancano le promesse di stabilità” (p. 32)? La precarietà “designa la condizione in cui ci ritroviamo vulnerabili agli altri”, in “un mondo senza teleologia” (p. 56) che infrange i sogni legati alla modernizzazione e al progresso. Ma per quanto queste ultime due nozioni siano obsolete, crediamo che l’economia cresca, le scienze progrediscano, le nostre vite migliorino, “gli umani si fabbrichino attraverso il progresso” (p. 57). Ma “fabbricare mondi non è riservato agli umani” (p. 58), per questo è necessario rivolgersi a modi di fare mondo o a modi di esistenza che non sono solo quelli dell’umano, che si è storicamente prodigato a imporre il suo modello di vita a tutti gli altri. Solo così possiamo imparare, come suggerisce Tsing, a guardare intorno a noi piuttosto che davanti a noi.

Ecologie della perturbazione
“Cosa fare quando il vostro mondo comincia a collassare? Io vado a spasso e, se ho fortuna, trovo dei funghi” (p. 31): così si legge nel prologo di The Mushroom at the End of the World. Accennavo prima alle esplosioni nucleari e alle eruzioni vulcaniche, ma le rovine su cui cresce il matsutake sono così estese da coincidere con il nostro paesaggio. Noi viviamo già in mezzo alle rovine, che non sono al di qua o al di là del nostro orizzonte; non mostrano un tempo remoto, non sono appannaggio dell’archeologia ma parlano del – e al – nostro presente.
Tsing rigetta così le soluzioni tecnologiche alla crisi ecologica, quelle del capitalismo verde o della geo-ingegneria, che vagheggiano un controllo del cambiamento climatico e degli effetti nefasti dell’Antropocene, come se avessero accesso alla stanza dei bottoni del pianeta Terra. Oppure le soluzioni eco-moderniste che millantano un “buon Antropocene” secondo il quale basta un’implementazione di tecnologia e di capitale, ovvero di ciò che ha precisamente causato il problema.
Il matsutake invece ci mostra quanta vita può esserci in queste rovine, che non coincidono col regno dell’abbandono, dell’inorganico o della morte. Realizzare che ci troviamo già alla fine del mondo costituisce una chance per agire – e all’azione vuole spingerci Tsing, come dimostra la mancanza di ogni condiscendenza verso l’apocalissi e la sua estetizzazione.
Secondo Tsing, il problema non è nella perturbazione degli ecosistemi. In Giappone “le persone e gli alberi sono coinvolti in storie irreversibili di perturbazione. Ma alcuni tipi di perturbazione sono stati seguiti da ricrescite che, nel frattempo, hanno favorito vite multiple. Le foreste rurali di pino cembro sono state dei piccoli vortici di stabilità e convivenza. Ma sono state spesso scatenate da grandi cataclismi come la deforestazione che ha accompagnato l’industrializzazione nazionale” (pp. 282-283). È contro-intuitivo, ma a volte bisogna perturbare per ripristinare. Alcuni ecosistemi non sopravvivono senza l’azione dell’uomo, decisiva quanto l’azione dei non-umani. I matsutake crescono sulle rovine grazie ai danni provocati dagli umani i quali, paradossalmente, sono incapaci di coltivarlo.

Più che la perturbazione, nociva è la piantagione o quella che Tsing chiama, su suggerimento di Donna Haraway (sua collega all’università della California Santa Cruz), Piantagionocene. Assieme al fungo atomico e al matsutake, Tsing contempla anche i funghi patogeni che proliferano in modo incontrollato nelle monocolture, ad esempio in quella di banane, causando malattie a piante e animali. È uno degli effetti della piantagione, un modello di produzione ad alto impatto ecologico che risale al XVI secolo, in cui si coltiva una sola specie di pianta – ad esempio la canna da zucchero – eliminando altre forme di vita, e che anticipa l’agricoltura industriale. Come ha ben riassunto Isabelle Stengers nell’introduzione a The Mushroom at the End of the World: “Piantate delle canne da zucchero (che si riproducono identiche per clonazione) in una terra lontana, dove non incontreranno piante affini o insetti familiari; da questa terra avrete precedentemente cacciato o sterminato gli abitanti e vi avrete messo a lavorare degli schiavi, ignari della memoria del luogo in cui sono trapiantati almeno quanto la canna da zucchero” (p. 15). In questa agricoltura hors sol l’alienazione vale tanto per i prodotti coltivati che per i lavoratori.
Siamo agli antipodi della foresta di matsutake, che è multi-specifica, si nutre di contaminazione ed è indifferente all’economia industriale. Rispetto alla biologia del XX secolo, “ora realizziamo che i corpi della maggior parte degli organismi sono paesaggi multispecie. Nessun organismo può diventare se stesso senza l’assistenza di altre specie” (Aura’s openings, More than Human. AURA Working Papers, vol. 1, 2015, p. 46). Il matsutake contribuisce infatti alla vita vegetale nel suo complesso, rendendosi indispensabile per la crescita degli alberi in terre ostili o povere di nutrienti. Una storia del genere non merita di essere raccontata?

Pensare come funghi
Tsing non si limita a ricostruire vita, morte e miracoli del matsutake, ma c’invita invece a pensare con i funghi, ovvero a ricomporre il mondo assieme ai non-umani. A considerare da vicino quelle narrazioni e quelle visioni in cui l’umano e il non-umano s’intrecciano. A prendere sul serio l’art of noticing, l’arte della descrizione, rispetto agli approcci quantitativi e alle modellizzazioni verso cui si orientano le scienze sociali, le scienze della vita e in parte le scienze umane.
Abbiamo bisogno di un nuovo sguardo e di una nuova parola, per questo il contributo degli artisti è decisivo quanto quello degli scienziati. Un punto di The Mushroom at the End of the World che Frédérique Aït-Touati ha colto appieno: “la narrazione non è il mezzo per diffondere un sapere stabilizzato, [ma] partecipa alla costruzione di questo sapere essendo una ‘pratica di conoscenza’ e, così facendo, registra nella sua stessa forma l’evoluzione del rapporto con la Terra, i suoi esseri viventi e i suoi paesaggi”. Insomma, “le storie della Terra hanno cambiato di natura e di scala: non scriviamo più storie per raccontare la creazione o il corso del mondo, ma per scongiurarne la fine. È al momento in cui il mondo che abbiamo conosciuto sembra sfuggirci di mano che si moltiplicano i tentativi di coglierlo” (Récits de la Terre, in “Critique”, 860-861, 2019, pp. 5-16).
Come vivere tra le rovine? Per rispondere Tsing non si affida alle teorie di qualche grande scienziato, non filosofa sui massimi sistemi, non offre soluzioni tecniche per governare cambiamenti che sfuggono al nostro controllo. Si limita invece a ripercorrere ad ampio raggio la storia, le vicende e le alterne fortune di una singola specie di fungo. Ci rende così partecipi delle storie non umane che racconta. Pratica l’arte di “raccontare storie in cui gli esseri umani non sono al centro, ma in cui non svolgono neanche il ruolo di intrusi contro i quali la ‘natura’ dovrebbe essere protetta” (Stengers, p. 18).
“Siamo tutti compost, non postumani”, esclama Haraway (Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero 2019, p. 146). Tsing sembra farle eco invitandoci a fabbricare mondi sulle rovine del capitalismo. Come? Pensando – e agendo – con e persino come un fungo matsutake.







