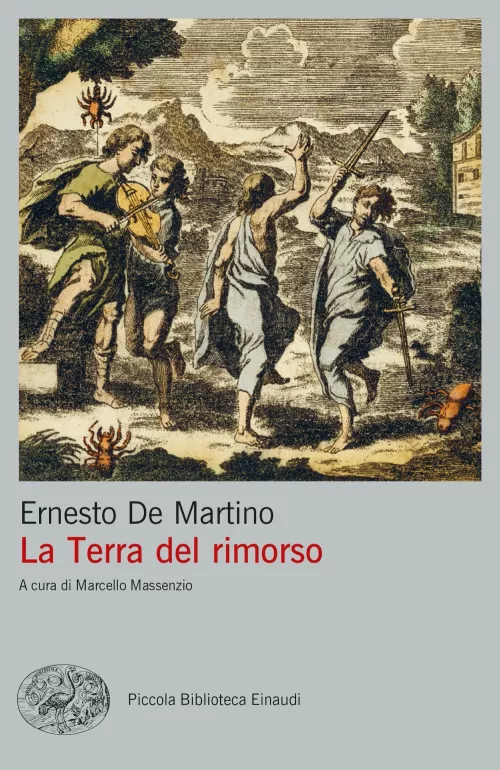De Martino, ritorno alla terra del rimorso
La triplice domanda posta da Lévi-Strauss in Tristes tropiques: Qu’est-on venu faire ici? Dans quel espoir? À quelle fin? è citata giustamente da Marcello Massenzio nel suo saggio introduttivo alla ristampa di La terra del rimorso, un classico lavoro di Ernesto De Martino pubblicato nel 1961 e ora riproposto da Einaudi nella sua Piccola Biblioteca, con un ricco apparato critico. La ribellione al gelido spirito compilativo imposto dal positivismo, che educava ad affrontare la realtà con spirito dominante e coloniale, trova in questi due libri un grimaldello mentale che rimescola le carte, i soggetti con l’oggetto, la civiltà e gli esclusi, i non completamente uomini, i selvaggi, gli incolti, gli ingenui seguaci di ogni credenza e di ogni stregoneria. Siamo nel cuore di una vera rivoluzione culturale che trasforma l’antropologia in etnologia, scardinando convinzioni e certezze secolari.
Naturalmente ogni rivoluzione ha dei precedenti, e se posso aggiungerne uno a quelli proposti dai curatori farei un esempio letterario, perché anche i letterati e gli artisti fanno parte di questa rivoluzione. Rileggendo De Martino ho ripensato a L’Afrique fantôme di Michel Leiris, che con grande scandalo si era cimentato come letterato-etnografo scrivendo il suo diario al seguito della famosa spedizione africana guidata da Marcel Griaule (celebre autore del Dio d’acqua, del 1948). L’io che osserva il mondo non è una macchina compilativa, ma un soggetto con una certa cultura e una certa vita che si trova come immerso nel suo stesso passato. L’osservatore è lì insieme all’osservato, e le loro vite si confondono. Leiris si confonde al punto di desiderare ardentemente le ragazze africane, che sconvolgono il suo mondo onirico e forse anche le sue certezze. Diciamo pure: le certezze un po’ sbilenche che poteva avere un giovane surrealista. Sovrapporre un certo metodo di studio (asettica compilazione di modelli) alla politica predatoria dei conquistatori: questo il motivo vero dello scandalo.
Avvicinarsi agli indigeni come ci si avvicina all’altro, dove l’altro è come noi, in un altro posto della storia, e ha una sua sapienza e una sua vita, e entrambe fanno parte di noi. Il colonialismo e la scienza classificatoria e razzista sono l’altra faccia della medaglia svelata da Leiris, che porterà anche altrove, fino in America centrale, le sue inquietanti domande, tra stregoni e spiriti incomprensibili. Se c’è uno scontro è uno scontro che avviene in noi stessi. L’eco dello scandalo seguito alla pubblicazione di L’Afrique fantôme avrà visibili ripercussioni nel mondo dell’arte degli anni ’30: basti pensare all’uso di sculture e immagini africane nella produzione di Picasso. Un’iconografia che affascinò anche Freud, cooptabile anche lui in questa complessa rivoluzione etnologia. Un altro etno-pittore (chiedo scusa per la definizione buona soltanto per l’occasione) è naturalmente Gauguin. Della spedizione etnografica nel Salento diretta e narrata da De Martino fanno parte specialisti di discipline diverse: la presenza di Giovanni Jervis, che in appendice scrive interessanti Considerazioni neuropsichiatriche sul tarantismo, giustifica in pieno la suscitata presenza di Freud con i suoi totem e feticci inquietanti.
Profonda la meditazione freudiana di De Martino, incentrata soprattutto sulla monografia Al di là del principio di piacere, individuando nel famoso gioco del rocchetto, nel suo evidente carattere simbolico (sparizione-apparizione della madre-rocchetto), una chiara congiunzione con il simbolismo mistico-rituale della vita religiosa. Scrive Massenzio: “Anche l’interesse per la psicoanalisi freudiana accomuna i percorsi di Lévi-Strauss e di De Martino: il tema della ripetizione della crisi iniziale in funzione della sua risoluzione mediata dalle procedure rituali è ben presente nell’opera dell’antropologo francese.” Si tratta in pratica del valore terapeutico, che unisce riti magici e procedura analitica, sciamani e analisti. Cito almeno un titolo fondamentale: L’efficacité symbolique, in Antropologie Structurale. La potenza di questa multidisciplinarietà (storia delle religioni, antropologia culturale, psicologia, etno-musicologia) unisce i due studiosi che aprono la strada a una delle più grandi rivoluzioni culturali del 900.
Massenzio dice più precisamente: le strade dell’autore di Tristes tropiques e quella dell’autore di Il mondo magico procedono parallele. Sullo spessore letterario di entrambi, indiscutibilmente notevole, sarebbe necessaria una riflessione approfondita ma forse è più importante isolare il sentimento (non so come chiamarlo) che li unisce, di sicuro inscrivibile nel senso di colpa. Il rimorso di cui parla Lévi-Strauss è rimorso per le atrocità e le cancellazioni etniche del colonialismo occidentale. Anche se il rimorso del titolo di De Martino significa “morso di nuovo” il sentimento, il senso di colpa, è comune a entrambi i pensatori. Molto probabilmente la guerra in Indocina e quella che inizia in Algeria, e l’enorme scontro politico che ne segue, in Francia ma non solo, hanno un peso nell’intonazione grave delle numerose considerazioni dei due grandi etnologi.
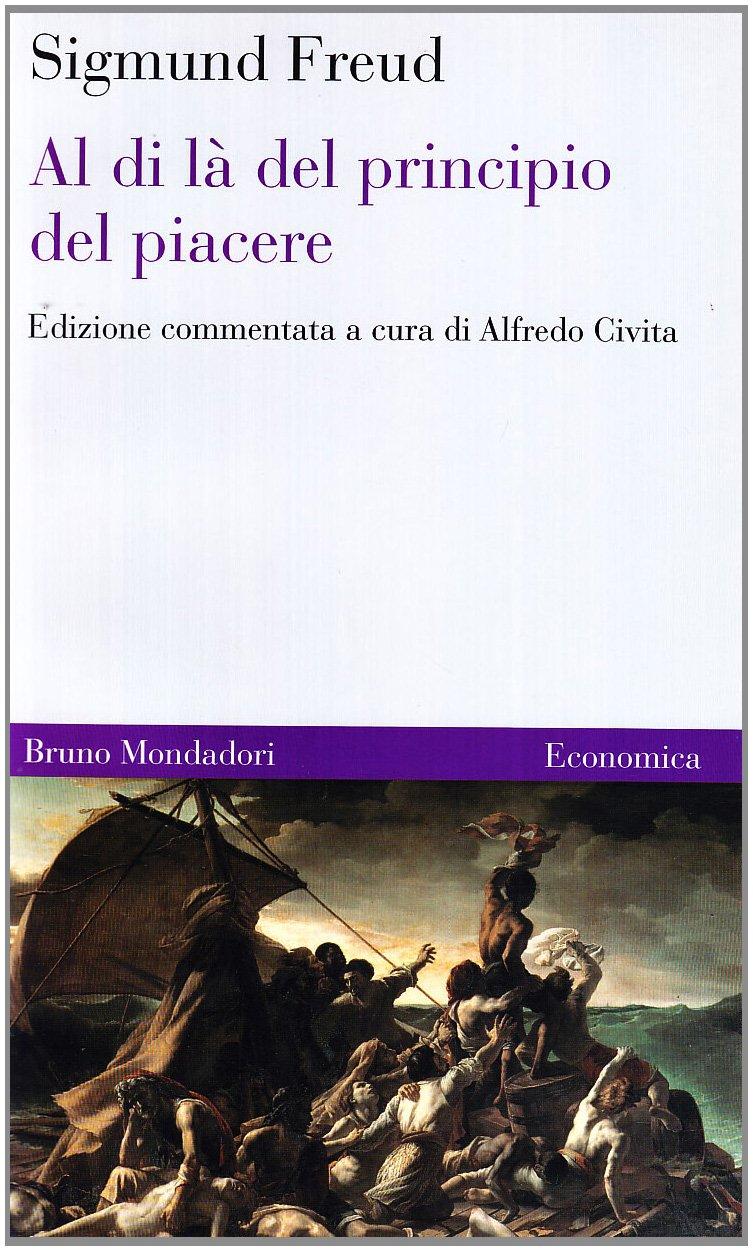
Il peso del contesto socio-politico è essenziale per capire anche la specifica diatriba italiana suscitata dalla pubblicazione de La terra del rimorso, che fa i conti con un grande pensatore ora quasi scomparso dall’orizzonte culturale italiano: Antonio Gramsci, con la sua “quistione meridionale”. Gli intellettuali italiani staliniani o appena post-staliniani attaccarono violentemente il libro accusandolo di populismo. L’intervento di Fabio Dei, che introduce il volume con Marcello Massenzio, approfondisce questo conflitto e osserva giustamente che entrambi gli studiosi incontreranno il vasto pubblico dei non specialisti soltanto dopo il 1968, divenendo insoliti Mâitres à penser dei movimenti di protesta. Si potrebbe pensare che, paradossalmente, una gran parte di questi lettori potrebbero invece risultarci oggi abbastanza populisti.
La cultura del popolo, superestetizzata e edulcorata (procedimenti sconosciuti ai maestri dei quali ci occupiamo) porta a curiose mescolanze, soprattutto con il maoismo. Basti ricordare il triste proliferare dei gruppi mao-stalinisti come “Servire il popolo”. Né De Martino né Gramsci possono essere appiattiti (e diminuiti) in una prospettiva così superficiale. Si percorrono strade più sottili, che porteranno a risultati importanti anche in campi limitrofi: pensiamo al lavoro degli storici, da Foucault a Ginzburg, o a letterati anomali come Chatwin, che in fondo si pone le stesse domande di Lévi-Strauss, per giungere fino a Ghosh, che ho recensito qui recentemente, in perfetta sintonia con il rimorso dei due grandi maestri.
A distanza di tanti anni cosa resta di quei roboanti dibattiti? Cosa significa adesso un libro come La terra del rimorso? Prima di tutto resta un impianto metodologico che di populista non ha proprio niente. Direi che oggi il valore scientifico di questo lavoro emerge in tutta la sua nettezza, e resta una lettura affascinante. De Martino, che aveva già viaggiato e studiato molto il meridione, sa benissimo che sui tarantati e sui loro riti misterici già da tempo numerose stratificazioni religiose e culturali si erano sovrapposte al fenomeno realmente osservabile. Dal suo ambiente agreste, con la presenza di fonti fresche e energetiche, fasce colorate, musica ossessiva, corde a cui appendersi stremati mimando la cattura del ragno nella sua tela, il rito resiste in una chiesa e in poche abitazioni del Salento. De Martino e la sua équipe non si limitano a osservare e fotografare queste cerimonie per così dire ufficiali, seguono i tarantati (principalmente donne, peraltro meno esposte degli uomini al morso reale del ragno) nelle loro abitazioni, ricostruiscono una sorta di albero genealogico di quella che qualcuno potrebbe chiamare patologia. Un rito così antico, originato chissà in quale punto del medio evo, cosa significava esattamente? Era un complicato rito contro il malocchio? E le convulsioni? E le guarigioni (o remissioni) dall’avvelenamento? Quasi mai era sufficiente un morso, ci voleva sempre il rimorso, dopo un anno, ma anche dopo molti anni.
Per chi non avesse letto il libro, un’informazione preliminare: la tarantola è soltanto un equivoco, non la reale responsabile del famoso morso. Il ragno responsabile di tanti deliri e allucinazioni era molto meno vistoso della tarantola, ma apparteneva alla grande famiglia delle vedove nere: il latrodectus. Pochissimi dei tarantati, morsi e rimorsi, erano entrati in contatto con il veleno del ragno. I tarantati (sarebbe meglio dire: le tarantate) imitano i sintomi dell’avvelenamento. E il primo morso ha un forte valore simbolico: “pizzicata alla finestra a mezzogiorno”, “pizzicata dopo la morte del padre”. Una recita psichica? Uno psicodramma? La rappresentazione di un trauma? Di pulsioni rimosse o inconfessabili? Franco Scataglini scrive in un suo memorabile verso “vero da l’esse finto”, e proprio di questo si tratta. Voglio trascrivere una citazione proposta da De Martino, che ha scavato tra i documenti reperibili tracce più antiche possibili della cerimonia originaria. Si tratta di un medico erudito leccese che scriveva nel 1741: “La camera da letto destinata al ballo dei tarantati sogliono adornare con rami verdeggianti cui adattano numerosi nastri e seriche fasce di sgargianti colori.
Un consimile drappeggio dispongono su tutta la camera; e talora apprestano un tino, o una sorta di caldaia molto capace, colma d’acqua, e addobbata con pampini di vite e con verdi fronde di altri alberi; ovvero fanno sgorgare leggiadre fonticelle di limpida acqua, atte a sollevare lo spirito, e presso di queste i tarantati eseguono la danza, palesando di trarre da esse il massimo diletto. Quei drappi, quelle fronde e quei rivoli artificiali essi vanno contemplando, e si bagnano mani e capo al fonte: tolgono anche dal tino madidi fasci di pampini e se ne cospargono il corpo, oppure, quando il recipiente sia abbastanza capace, vi si immergono dentro, e così più facilmente sopportano la fatica della danza.” Ma il rito sicuramente nasceva nei boschi, è il bosco che viene simbolizzato con rami e pampini nelle case. All’aperto lo scenario è ancora più coinvolgente: “all’ombra di un albero, presso un laghetto o un ruscello, si abbandonano al ballo con massimo diletto, mentre frotte di giovani in cerca di piaceri e di scherzi vi si danno convegno, ai quali son mescolati non pochi che ormai volgono alla vecchiaia, e che, contemplando con seria curiosità quelle melodiche follie, par che esortino con tacito ammonimento la gioventù…”
Ormai il mondo magico, in occidente, è definitivamente tramontato, e non restano neppure dei cocci da rimettere insieme. Si diffondono fenomeni (le sette sataniche, ma non solo quelle) di chiara competenza psichiatrica o giudiziaria, senza alcun passato che non sia cattivo cinema o cattiva tivù. Gli ultimi scampoli di quei mondi, intravisti negli anni ’50 del secolo scorso da De Martino, sono uno sguardo dall’orlo di un pozzo profondo secoli. Uno sguardo così prezioso da essere documentato anche da vari fotografi, sempre coinvolti nelle spedizioni di De Martino. È giusto ricordarne almeno uno, davvero straordinario: Arturo Zavattini. Voglio condividere una delle tante domande che mi sono fatto leggendo questo libro. In fondo è la stessa domanda di Lévi-Strauss citata all’inizio: Qu’est-on venu faire ici? Che implica non solo il coinvolgimento personale dello studioso, ma anche una voce narrante.
Il fenomeno dell’odierno narratore che si trasforma in io ipertrofico è in qualche modo assimilabile alla nobile domanda di Lévi-Strauss? Non c’è una risposta stabile. Dipende da quello che “io” porta con sé. Se porta una cultura importante, imponente rispetto a quella dei tarantati, ma la porta con sé come materia accumulata da altri lungo secoli scivolati altrove, e semplicemente si pone in ascolto dell’altro e della sua storia, dei suoi mali e delle sue cure, allora la risposta diventa sì, e il discorso si fa davvero intrigante.