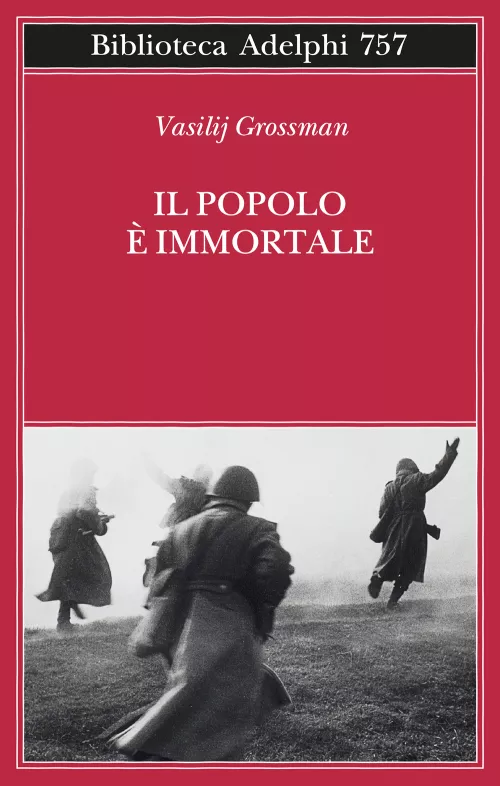L’Odissea di Vasilij Grossman: l’inizio della guerra
È una persona coerente. Lo si dice per fare un complimento, e lo è. Non è un voltagabbana, un quaquaraqua, insomma. Coerente, cioè fedele a un’idea. L’idea. Idealismo quando si trasforma in motore della storia. Ideologia, quando tutto si cristallizza in certezza che si può soltanto divulgare con generosità. Ha sposato un’idea e gli è restato fedele. Che uomo! Che donna! In questo spero non troppo ridicolo gioco di parole si nasconde qualcosa di irrisolto, in tantissimi della mia generazione ma forse anche in quelle successive, ammalate di coazione a ripetere. Perché a un certo punto la Storia ti travolge insieme ai tuoi ideali. Scende una diversa realtà. È la crisi. È la guerra.
Le manifestazioni per la pace scompaiono, come sono scomparse nel nulla a ridosso della prima guerra mondiale, le idee e gli ideali si trasformano in una sorta di amuleto da portare con sé, ma lentamente l’odio e la paura non lasciano posto ad altro. I preziosi romanzi di Vasilij Grossman raccontano il viaggio dentro l’assurdo della guerra, portando con sé convinzioni che inevitabilmente verranno messe alla prova dalla violenza della storia. Il viaggio non è soltanto un lungo, infernale spostamento geografico, che Grossman ha vissuto in prima persona, da Stalingrado a Berlino, ma è soprattutto un’esperienza intellettuale. Quel che ha reso Grossman politicamente insopportabile, e quindi censurato dalla sinistra post-sovietica europea fino e oltre la caduta del muro di Berlino, è il presentarsi alla guerra come convinto comunista. Paradossale ma non incomprensibile che un marxista convinto decreterà in modo inconfutabile il fallimento del marxismo-leninismo.
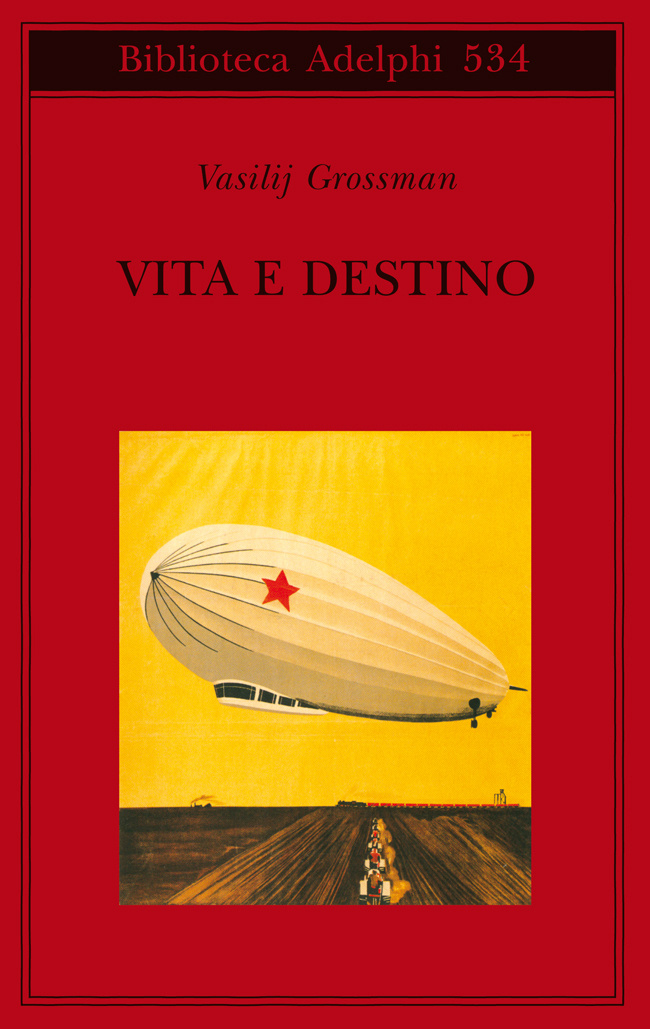
Non più giovanissimo e poco in forma, Grossman indossa la divisa dell’Armata Rossa, scrive corrispondenze per i giornali dell’epoca. Ma lui, pur essendo un chimico industriale è in realtà uno scrittore, e oltre ogni convinzione ideologica si trova ad essere coerente con altre parole, e la prima è: verità. L’ossessione della verità. Nel senso classico del termine: vitam inpendere vero. Bisogna ricordare le sue ultime corrispondenze da Berlino appena conquistata dall’Armata Rossa. Intervista le ragazze tedesche violentate ripetutamente e in gruppo da soldati sovietici. Possiamo immaginare che accoglienza hanno avuto in patria questi articoli. L’altra parola chiave di tutta l’opera di Grossman è: compassione. Per tutti, per i bambini straziati dalle bombe, per gli ebrei sterminati e che negli articoli non può definire “ebrei”: deve scrivere “russi”. Anche i tedeschi suscitano la sua compassione, proprio tutti. Nei testi scritti a caldo dal fronte non mancavano espressioni di odio per gli invasori, espunte però già nelle prime edizioni in forma di libro.
![]()
Un sentimento legato al suo rapporto di fondo con la natura e con tutte le sue creature, alberi e animali, fiori e cielo. Il marxista Grossman, naturalmente laicissimo all’inizio della sua avventura, è del tutto indifferente alle sue origini ebraiche. E questo è un altro percorso che inizia, dentro le sue radici e nella storia di un popolo in ombra. Lo mette a fuoco contemplando le enormi fosse comuni. Ma come entra il romanzo, la letteratura, in un inferno concretissimo come una guerra? Ecco, le idee di Grossman verranno modificate dalla Storia, che entrerà senza maschere nella sua prosa, ma i libri che scrive non sono di cronaca: sono letteratura, quella vera, forte, capace di parlarci quando tutti i coetanei dell’autore sono scomparsi da decenni insieme a lui. La sua opera, che oggi leggiamo finalmente per intero, raggiunge uno dei punti più alti e inquietanti della letteratura del ‘900. Il popolo è immortale, appena stampato da Adelphi nella bellissima traduzione di Claudia Zonghetti (che ha dedicato anni di lavoro alla traduzione di Grossman trovando subito la chiave giusta per renderlo nella nostra lingua, il tono, credo lo spirito stesso dell’autore) è il racconto dell’inizio della guerra. Mentre Vita e destino, il suo capolavoro, scomparirà per decenni cancellato dalla censura staliniana (condivisa con convinzione, e ben oltre lo stalinismo, dai nostri intellettuali) questo libro è stato pubblicato (e scritto) a puntate nella rivista Krasnaja zvezda (Stella rossa).

Naturalmente, pur disponendo di uno stile già maturo, scrivere per una rivista non è la stessa cosa che scrivere un libro. È un libro che ha già un pubblico (trecentomila copie, la tiratura della rivista), e questo porta a concessioni inconsapevoli alle attese dei lettori. Ma seguire per intero l’Odissea di questo scrittore ci permette di ascoltare il trascorrere del tempo, la spietatezza della verità che disegna noi mentre cerchiamo di disegnarla. Il popolo, parola che oggi suscita quasi soltanto timori, è in Grossman un insieme di individui, e tutti insieme fanno irruzione nel romanzo. Anche un vecchio che guarda dalla finestrella di una misera isba è una storia. Chi è questo popolo? Cosa lo spinge con tanta disperata determinazione contro il nemico? Le donne diventano operaie e soldati, gli artigiani diventano artiglieri, se c’è da andare all’attacco si va perché anche morire va bene. Corretta l’interpretazione di Hitler sulle ragioni della sconfitta di Stalingrado: mai si sarebbe aspettato una reazione emotiva così totale da parte di tutti i russi. Ma come? Questi slavi ubriaconi? Questi schiavi da generazioni? Nessun manuale di storia può mostrarci e tanto meno spiegare il fenomeno. Grossman si sente investito da questo compito. Uomini e donne si battono contro un esercito invasore, avrebbero fatto lo stesso sotto la bandiera di uno zar qualsiasi, o di qualunque tiranno avesse messo il destino al loro comando.
Il destino è parola dura e cupa, essenziale nella lingua e nella mentalità russe. Non combattono per lo zar: ogni russo si sente attaccato personalmente nel poco che ha. Stalin, ex alleato di Hitler, ha soltanto messo in pericolo il paese, ha facilitato l’invasione nazista, non merita nessuna medaglia storica. Era il folle dittatore di un popolo che non aveva (e non ha) mai conosciuto alcuna forma di convivenza democratica, che di questa parola non sapeva proprio niente. Gli eroi del romanzo non sono soldati di carriera. Sergej Aleksandrovič Bogarëv, vicecapo della direzione politica al fronte addetto al lavoro tra le file nemiche, era un insegnate di marxismo. Lui interroga i prigionieri tedeschi, legge la loro corrispondenza. È stupito dalla pochezza dei loro ragionamenti, dalla loro viltà individuale. Tra centinaia soltanto due gli sono sembrati sinceramente disgustati da Hitler che li aveva condotti a quel punto. Ma non si deve pensare a personalità dominate da un fanatismo cieco, a un odio totale verso il nemico: i combattenti di Grossman non sono mai così. Neppure l’ironia è scomparsa tra le file sovietiche.

Una sorta di filastrocca diffusa tra i soldati diceva: tedeschi vigliacchi ma soldati coi fiocchi. “Avanzano spalla a spalla, un muro lungo non meno di un chilometro… A quattrocento metri di distanza c’è la seconda fila identica, e poi viene la terza. Tutti in mezzo al grano alto, tutti con il mitra imbracciato… I nostri sparano e loro niente, avanzano imperterriti. Pazzesco. Non strillano, non rispondono al fuoco e niente fa pensare che siano ubriachi: alcuni cadono a terra tra il grano come birilli, ma gli altri niente, tirano dritto. Uno spettacolo, credetemi!” Siamo nell’estate del 1941, la guerra va male, per i sovietici, si stanno ritirando. Impossibile, come sempre, cercare di riassumere la densa, scorrevole narrazione di Grossman. Capita spesso di voler tornare alle pagine già lette e riascoltare le sue descrizioni. “La città bruciava. Un fumo ricciuto, rosso e pieno di scintille si levava verso l’alto, sul mercato aleggiava un bagliore color mattone scuro. Migliaia di luci bianche, arancioni, giallo chiaro, rosso ribes e bluastre formavano un enorme cappello soffice sulla città, mentre le chiome degli alberi si raggrinzavano e sbiadivano. Piccioni, corvi e cornacchie vagavano nel caldo dell’aria: anche le loro case erano andate a fuoco. Arroventato da quel calore tremendo, il ferro dei tetti rifulgeva; per quello stesso calore la lamiera scricchiolava e mandava strani suoni, mentre dalle finestre piene di fiori usciva prepotente il fumo – bianco latte, nero come la morte, rosa o grigio cenere. (…) E nel nero del fumo da cui giungeva il ronzio lamentoso degli aerei nazisti annegavano le stelle.”
Dovunque morte, a decine e decine di migliaia, Shtetl ucraini cancellati, enormi fosse comuni piene di ebrei, bambini, giovani e donne. Tra queste la mamma di Grossman. Seguiamo la ritirata con il comandante di battaglione Babadzan’jan, ascoltiamo l’incredibile dialogo dei suoi uomini: “Senti ma secondo te, dopo la guerra, la Germania la lasciamo in piedi o la radiamo al suolo?” chiedeva una voce pacata e assorta. “E chi lo sa” rispondeva un’altra, “Vedremo lì per lì.” Se ne fregano degli ordini di Stalin, i suoi diktat sono lettera morta: ci si ritira perché i comandanti dell’Armata sono stati eliminati da lui negli anni trenta, e l’esercito è in condizioni pietose. I tre milioni di morti tra i russi (cito dall’intensa post-fazione di Robert Chandler e Julija Volochova) in questa prima fase della guerra pesano anche sulla coscienza del dittatore sovietico. Il destino di Babadzan’jan è assai curioso. Personaggio realmente esistente morirà nella narrazione di Grossman mentre, attraversando mille battaglie, il vero Babadzan’jan riuscirà a sopravvivere. Quando i due si incontreranno Babadzan’jan se ne lamenterà amichevolmente: “Lei mi ha ammazzato, però!” Credo che la risposta di Grossman valga come risposta anche ai teorici della letteratura che si occupano del suo rapporto con la storia: “come l’ho ammazzata la resuscito”.