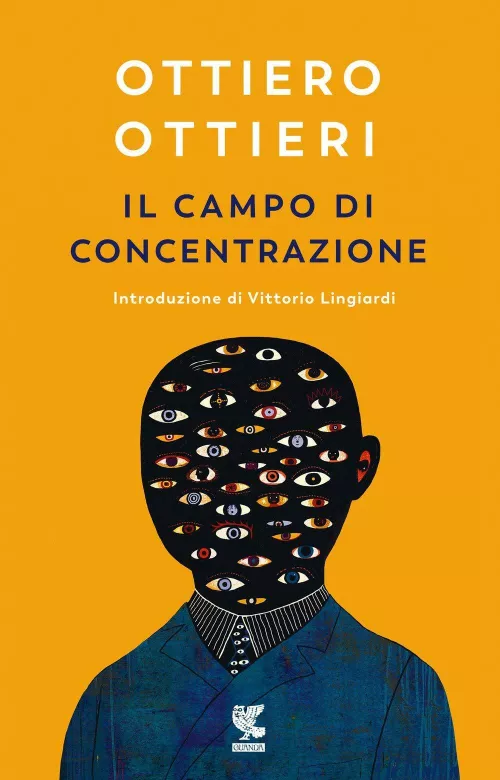Ottiero Ottieri / Assalto alla psiche
Immaginiamo un supermercato in cui sia esplosa una bomba e tutti i prodotti siano stati sbalzati dai loro ordinati scaffali e proiettati ovunque e mescolati in una completa follia merceologica. Come prima dell’esplosione c’è tutto, ma la fruibilità dei prodotti, diciamo, è diventata estremamente complessa se non impossibile. Deve essere così che appare la realtà a chi varca la porta di una clinica psichiatrica da paziente. Se poi questo paziente è un sofisticato scrittore che decide di scrivere di quell’esperienza in presa diretta durante tutto il lungo ricovero, la dolorosa farraginosità della malattia mentale diventa necessariamente la semantica del suo scritto. Leggi e sbatti materialmente contro il suo senso di soffocamento, di sperdimento, di annientamento nel “niente” della nevrosi depressiva, malattia che nel 1970 spinse Ottiero Ottieri, a quarantasei anni, a scegliere il ricovero volontario per un anno in una clinica svizzera per uscire dal dramma di una depressione che non si risolveva. Da quell’esperienza nacque Il campo di concentrazione, pubblicato da Bompiani nel 1972 (Premio Selezione Campiello), da Marsilio nel 1984 e ora riedito da Guanda.
“Avvicinarsi realmente ad Ottieri è sempre difficile, persino pericoloso. Questo autore sfugge a qualsiasi catalogazione letteraria, sociopsicologica, filosofica”, avvertiva Andrea Zanzotto dandoci una assai preziosa mappatura genetica dello scrittore (Ottieri all’assalto della psiche, “Corriere della Sera”, 24 marzo 1995). E con questa essenziale indicazione è bene affrontare anche Campo di concentrazione. Nel nastro incessante del suo racconto emergono necessariamente, a brani, i diversi momenti della biografia di Ottieri, s’intrecciano la vita dell’impegno, all’Olivetti, quella di Tempi stretti e Donnarumma all’assalto, i libri con cui inaugurò la “letteratura industriale” e quella della insidiosa felicità gaudente dei Divini mondani di “Salottiero Salottieri” (secondo un’autodefinizione), e infine il privato, la famiglia e Silvana, una moglie imprescindibile, nonostante tutto. “Dal fascismo adolescenziale all’antifascismo il più accanito, dall’industria e dall’osservazione complice dell’esperienza operaia, al set, al jet set, alla clinica e all’amore. Voleva essere un sindacalista playboy.”, così si è descritto una volta (Autodizionario degli scrittori italiani di Felice Piemontese, Leonardo, 1989).
Le diverse facce dell’autore nel Campo di concentrazione (le allusioni storiche del titolo sono del tutto inconsistenti) emergono in continuazione quasi come istanze psichiche: il suo disperato ma portante senso della vita sociale, l’attrazione (sessualmente evanescente) per le donne, per l’intrattenimento stupefacente. E la scrittura, che nella sua plasticità è un filo conduttore essenziale: “Sto attaccato allo scrivere astratto come sta attaccato ad un cornicione l’operaio che è scivolato giù dal tetto” (p.43), oppure “Scrivo unicamente per sopravvivere, scrivo per scrivere, per gettare un ponticello sopra l’abisso, per essere nella realtà e nello stesso tempo per estrarmi dalla realtà” (p.46).
Le giornate sono tremendamente pesanti: aspettare una lettera, una telefonata, la risposta alla domanda “Quando finirà?”. Il consumarsi quotidiano: “Sto eseguendo un lavoro di dolore. Il mestiere, qui dentro, è la sofferenza. Sono un impiegato dell’infelicità” (p.41); “Si sta attaccati alle più scarne origini, dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi. Si sta a un centimetro dal suicidio. Sospiro cercando aria come un sommergibile affondato che finisce le sue riserve” (p.49). Gli abitanti della clinica sono un vero bestiario, sempre tuttavia guardato con tanta pietas: “la schizofrenica, che si è buttata dalla finestra, con la faccia scavata dalla pazzia come un torrente; la piccola idiota; la vecchia ottantenne, fantasma diurno senza capelli; l’anoressica; la ragazza grassa come la base di un baobab” (p.166).

C’è una pagina, che più bachtiniana non si può, dedicata alla festa di Carnevale della clinica, con i pazienti tutti mascherati come a esaltare il loro lato freak. “V’è stato un acme della festa in cui tutti ballavano ancora mascherati, che mi è parso lo spettacolo più grandioso della mia vita. Schizofrenici, maniaco-depressivi, depressi, esauriti, si lanciavano palline di carta, stelle filanti, ballavano la polonaise, si divertivano, dimentichi della psichiatria, dietro queste maschere di carta, fatte nell’atelier, che di per se stesse stravolgono la persona di ciascuno. E qui ciascuno ha di per sé una personalità stravolta” (p.199).
Le diramazioni tematiche sono davvero infinite, ma Ottieri non sciala, non esibisce (e potrebbe), non esonda, non ci sono analisi culturali generiche, lui è fisso sul suo tema, davanti c’è sempre il mostro: “La depressione è un oscuramento di tutto il cielo, che va dai bottoni dei pantaloni all’orizzonte, passando per il pasto imminente, per il pomeriggio, per la serata, per l’indomani, avendo quindi le sue tappe ma nello stesso tempo ricoprendo tutto insieme l’intiero mondo. La depressione ha cadenze e nello stesso tempo è priva di storia. Ha la sua cronaca ed è vissuta come eterna. Dilata lo spazio e il tempo.
Dà la paura di vivere, strettamente apparentata con la morte. Tiene l’esistenza in bilico, mettendola continuamente in causa, togliendole valore. Il valore della vita, che dovrebbe essere indiscusso, è discusso” (p.193).
È uno scrittore abituato a manipolare le psicologie nei personaggi di finzione, è un poeta che lavora con le sintesi violente della poesia, è un uomo molto colto, un uomo che ha molto vissuto (vedi qui la biografia scritta dalla figlia Maria Pace Ottieri), non è difficile pensare che anche la sua scrittura nelle intenzioni solo funzionale e denotativa non sia comunque pregna di energia critica e di rinvii al mondo circostante. Quanti rilievi critici alle sue stesse opere, per esempio. Ottieri in Campo di concentrazione sfida il dato di realtà della sua malattia perché ha bisogno di superarlo. E lo fa con tutti i muscoli che ha a disposizione. Ma stavolta il contatto con il dolore è immediato, e il flusso linguistico è quasi sorgivo, non sta scrivendo un romanzo, non ci sono i filtri dell’immaginario artistico-letterario. È un capitolo a sé stante nell’“analisi interminabile” dei trenta libri della sua opera complessiva, un infinito corpo a corpo in cui “il demone della scrittura traduce il caso clinico in caso letterario”, come dice lo psichiatra Vittorio Lingiardi nella sua splendida introduzione.
Quello che a me più interessa in questo libro è il poter osservare la prassi psicoanalitica, vedere il come l’idea psicoanalitica si ipostatizza e lavora nel paziente. È un confronto serrato, in corpore vivo, tra la via freudiana (percorsa da Ottieri in una precedente analisi) e la via junghiana (praticata in quella clinica svizzera). Nella progressione della terapia si coglie bene la prospettiva diversa con cui la psicoanalisi può intervenire, ancorché conservi sempre un suo lato misterioso che salta fuori d’improvviso quando lo scrittore dice all’analista di non capire come conduce l’analisi, e l’analista risponde: “Lei saprebbe spiegarmi come scrive un libro?” (p.263). Per Lingiardi questo è un libro “generoso e remunerativo”, uno straordinario “addestramento clinico per noi psichiatri”, alcune pagine di Ottieri “sono più utili di un trattato di psichiatria o di psicoanalisi”.
Nella realtà molto scossa che stiamo attraversando (un supermercato appena esploso…) Il campo di concentrazione mostra tutta la sua capacità di comunicare ancora oggi, oltre il recinto letterario: perché l’ontologia della sofferenza mentale probabilmente non si è modificata e questa è la materia prima che Ottieri lavora. Lingiardi ricorda come la letteratura dei racconti del dolore psichico sia piuttosto vasta, e che lo stesso Ottieri ha ben presenti i libri degli italiani che su questo hanno riflettuto da Moravia a Volponi, Pavese e Berto. E tuttavia, proprio Zanzotto (autore egli stesso psicoanalizzatissimo nella vita e nell’opera) sottolineava che Ottieri “riusciva a dire anche ciò che per natura si negava ad esser detto, come riuscì a ben pochi autori che si mossero in questo terreno.” Non si può non convenire.