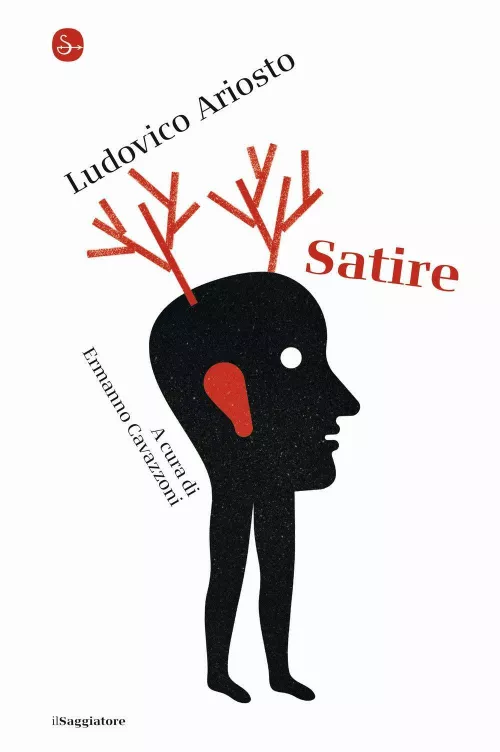Le Satire presentate da Cavazzoni / Il “libro segreto” di Ludovico Ariosto
Ci sono molti modi per avvicinarsi a un testo letterario, soprattutto a uno di quelli che siamo abituati a chiamare “classici”. (Così come ci sono molti modi per iniziare un articolo: in fondo si tratta pur sempre di servirsi di luoghi comuni più o meno collaudati dall'uso).
Prendiamo le Satire di Ludovico Ariosto, per esempio, scritte tra il 1517 e il 1525, quindi dopo le commedie in prosa e la prima stampa del Furioso (1516), ma antecedentemente alla stesura in versi delle commedie stesse e prima dell'allestimento definitivo del poema nella sua terza edizione (1532).
Il metodo prevalente di affrontare questi testi è quello filologico.
Il riferimento quasi ovvio è quello ad alcuni saggi di Gianfranco Contini. Celeberrimi e celebratissimi, avvolti (e a ragione!) da un'aura di sacralità. Come lavorava l'Ariosto che è del 1937 (quando Santorre Debenedetti pubblicò i Frammenti autografi dell'Orlando Furioso) e Come lavorava l'Ariosto nelle Satire, molto più recente, del 1984, per l'edizione curata da Cesare Segre, ma, come si vede anche solo dai titoli, pur a distanza di tanto tempo, ribadendo una evidente continuità d'impostazione.
La poesia per Contini, si sa, non era un fenomeno statico, ma un fenomeno dinamico. Più che un oggetto o un risultato o un valore acquisito – una perenne approssimazione a un valore, tendenzialmente infinita. Considerando l'atto poetico, il critico è fatalmente portato a reperire direzioni (o linee di fuga) piuttosto che contorni fissi.
Alla base di questa teoria stanno, come riconosceva lo stesso Contini, Mallarmé e Valéry.
Io aggiungerei, se possibile, anche un filosofo come Giovanni Gentile, benché sia nota l'osservanza crociana di Contini.
Basti pensare a certi passi della Teoria generale dello spirito come atto puro. Ad esempio questo: “lo spirito non è essere o sostanza, ma processo costruttivo o svolgimento”. E anche quest'altro: “invece di verum et factum convertuntur si dovrebbe dire verum et fieri convertuntur, ovvero: verum est factum quatenus fit”.
Su queste basi Contini, e i suoi numerosi allievi e seguaci con lui e dopo di lui, studiava con acribia infinita e infinita pazienza le varianti dei testi. Scoprendo in quelle del Furioso una generale tendenza all'abbassamento di tono, all'eliminazione dell'alessandrinismo. Un'arte del levare indirizzata verso il tono medio, nemico delle punte espressivamente rilevate.
Quando, nel prologo del canto XII del Furioso, Ariosto passa da “tornando in fretta alla sicania valle” a “tornando in fretta alla solinga valle”, da un lato elimina un elemento inutilmente esornativo, un epitheton ornans e guadagna dall'altro un effetto pianamente patetico. Così come quando, nel canto XLVI (ottava 59), corregge “il nettunio Egeo” in “canuto Egeo”, passa da un'espressione da epillio ovidiano a una ben più visivamente efficace, seppure “spoglia di sontuoso prestigio a priori”.
Analogamente, allorché nella quarta Satira, Ariosto corregge il verso 139 “La nuda Pania tra Favonio e Noto” in “La nuda Pania tra l'Aurora e il Noto”, commettendo con la correzione un errore geografico, perché il monte Pania non è a sud-est, ma a sud-ovest di Castelnuovo, lo fa per il semplice motivo che per lui è più impellente eliminare un tecnicismo alessandrino (favonio) in favore di una parola molto più accessibile e media (aurora), a costo, come visto, di incorrere in una inesattezza contenutistica.
E oggi, nelle edizioni più recenti delle Satire ariostesche e negli studi che le riguardano, si parte ancora naturalmente da Contini e Segre (e Debenedetti) ma per correggerli, integrarli o, com'è giusto che accada, per superarli (o inverarli, alla Hegel).
I nomi degli studiosi odierni sono, che so, Albonico o Campeggiani: l'uno prepara una nuova edizione delle Satire, l'altra ha studiato le varianti dell'edizione Segre trovando che l'ideale dell’“armonia desultoriamente inseguita” (Contini) non è poi così rispondente al vero, essendo il risultato di parecchie correzioni più quello di una certa “ironia ritmica” e dell'ottenimento di una sorta di “parlato disarmonico”, una, orazianamente, “concordia discors”.
Anche certe formule consolidate (e ripetute di anno in anno e decennio in decennio), come l’“armonia” del Furioso (Croce) e il “tono medio” delle Satire (Binni) vengono sottoposte a revisione. Ida Campeggiani ha parlato di “fantasma di tono medio” proprio per le Satire. Vi sarebbero in esse molto più risentimento, acredine, parodia e rispettivi modi espressivi, di quanto non si pensasse fino a ieri. In certe Satire, per esempio la terza, Ariosto, più che alla sua aerea fantasia e a una presunta bonaria mediocrità, si rifarebbe invece addirittura al livore delle Pasquinate romane, in chiave anticlericale e anticuriale e antipapale.
Questo è dunque un modo per accostarsi alle Satire di Ariosto.
Un altro, molto diverso, è quello tenuto da Ermanno Cavazzoni nella sua introduzione all'edizione dell'opera appena uscita per i tipi di Il Saggiatore.
Il testo di Cavazzoni, che in effetti usa la forma desueta e umilmente didattica Avviamento alle Satire, è un brano di sapida prosa paratattica, oraleggiante e popolareggiante, ricca di anacoluti e “che” polivalenti, e che fa piazza pulita di ogni filologismo.
Qui non si fa parola dei manoscritti delle Satire, né di quello F, con le sue due mani, quella del copista e quella dell'autore, con i relativi problemi di attribuzione, né dell'A o del S e nemmeno delle stampe Rosso (1534) o Giolito (1550), con la spinosa questione dell'ordine discordante dei sette componimenti.
Non vi si menzionano né Debenedetti né Contini né Segre né i più recenti Albonico o Campeggiani o D'Orto o altri valenti studiosi.
Al massimo vengono citati certi storici rinascimentali, come Paolo Giovio (magari passato attraverso la mediazione odierna di Dino Baldi) oppure un erudito otto-novecentesco come von Pastor, e sempre per rappresentare vite viziose o efferate di papi, quali Giulio II o Leone X, nei quali ebbe modo di imbattersi, e ne avrebbe volentieri fatto a meno, il nostro Ludovico.
L'unico nome antico che compare in Cavazzoni è Orazio (p.13), e non per caso, si capisce.
Partiamo allora da qui, seguendo questo Avviamento e distaccandocene a volte, per parlare più nel dettaglio delle Satire ariostesche.

Per noi le satire di Orazio sono Satire, ma per Orazio erano in realtà Sermones non Satyrae o Saturae. E rientravano a pieno titolo nel genere sermo anche quelle che noi chiamiamo Epistulae, di Orazio.
Ariosto, fosse o meno consapevole di questa identità di genere, in effetti la mette in pratica, dato che queste sue sette Satire sono in realtà più epistole o epistulae che satyrae. Hanno tutte un destinatario preciso con il quale si svolge un dialogo, o una finzione di dialogo a distanza (in retorica: sermocinatio).
Non staremo a ripercorrere e a riassumere, satira per satira, i sette momenti dell'opera. Seguiremo percorsi trasversali.
Innanzitutto: si tratta davvero di un'opera, un testo unitario, un, come si diceva una volta, “macrotesto”?
Parrebbe di sì.
Anche se l'ordine dei sette testi è diverso da una stampa all'altra, come abbiamo detto, e diverge anche da un manoscritto all'altro, sembrerebbe che la satira prima risponda all'ultima, a chiudere un cerchio (Ringkomposition, come ha notato un filologo classico, Andrea Cucchiarelli). Nella prima l'autore si presenta come un vecchio quarantaquattrenne (la stessa età che aveva Orazio quando chiudeva il primo libro delle Epistole) che si rifiuta di seguire il suo signore, il cardinale Ippolito, in Ungheria, e preferisce passare il suo tempo in luoghi familiari intorno a Ferrara (Filo, Cento, Ariano, Calto).
Nella settima e ultima l'autore fa di nuovo riferimento alla sua età: è passato un po' di tempo, gli anni sono diventati quarantanove, ma la mentalità non è cambiata: non vuole andare a Roma a fare l'ambasciatore ducale presso il Papa, preferisce soggiornare non più in là di Argenta o Bondeno, sempre nei pressi di Ferrara, anche perché è lì, a Ferrara, che vive il suo amore, Alessandra Benucci, e chi lo vuol rimuovere da lei, lo vuol rimuovere da se stesso.
Quando è stato costretto a lasciare la città amata, e dell'amata, mandato come commissario ducale (dal Duca Alfonso) in Garfagnana (febbraio 1522), ha perduto il canto e il riso e il gioco, sepolto tra quei sassi, in un “rincrescevol labirinto”. In mezzo a briganti e liti perenni di tutti gli ottantatré paesi della Garfagnana, ciascuno uno contro l'altro armato, dilaniati dalle interminabili faide e lotte intestine.
Pare che Lenin abbia dichiarato la sua ammirazione per D'Annunzio, l'unico poeta in grado di conquistare in armi una città (Fiume) e di guidarla come governatore (almeno un anno). Ma Ariosto non ama il comando, preferisce essere “contumace” (verso 127 della Satira prima). Sì “poeta contumace”, come si dichiarerà, tre secoli dopo, Tristan Corbière. Singolare coincidenza!
Ma perché accettare la carica in Garfagnana?
Per il più classico dei motivi, il famoso “tengo famiglia” che Longanesi voleva fosse stampato sulla bandiera italiana.
Ariosto era il capofamiglia, dopo la prematura morte del padre, di un'assai numerosa tribù: cinque maschi e cinque femmine, e vi doveva provvedere.
Era povero e servo dei potenti (“son sempre in servitude e in povertade”) eppure era capace di accontentarsi di poco: “in casa mia mi sa meglio una rapa”, cotta sul fuoco e condita con aceto e mosto cotto piuttosto che i manicaretti dei ricchi: tordi, starne e “porco selvaggio”.
L'avversione allo sfarzo, alla magnificenza, al lusso dei potenti attraversa tutte queste satire, ed è espresso, assai significativamente, dalla parola “fumo”: si va dai “fumi” intesi come “onori e titoli vani” della satira prima, alla “Roma fumosa” della satira terza, ai “titoli e fumi” della satira quinta.
È questa esibita distanza dagli eccessi che ha alimentato il mito del “tono medio” delle Satire, che pure così “medie”, come s'è visto non sono.
La satira quinta, per esempio, indirizzata al cugino Annibale Malaguzzi che deve prender moglie, dove pur è detto che “mediocre forma/sempre lodai”, presenta vistosissime punte espressive, oscene e scatologiche: “che le sciorini il cul”, “baciasse un cul marzo di scabbia”, “baciar lor anco a nuova luna il conno”, “lievale ... la occasione/d'esser puttana”, “che 'l dito alla moglier ha ne la fica” eccetera.
Così come a proposito degli “umanisti” (fra l'altro prima attestazione della parola in un testo letterario), tutti o quasi sodomiti, si avverte che “è gran periglio/a dormir seco e volgierli la schiena” (satira sesta indirizzata a Pietro Bembo).
Ariosto non aveva problemi di “political correctness”, all'epoca.
Rimane però da chiarire una questione rilevante, quella della destinazione di queste satire.
Come si sa la loro pubblicazione fu postuma, un anno dopo la morte del poeta (1534) e in una stampa che Segre definisce “clandestina”.
Difficilmente testi come questi, dove i suoi mecenati, cosiddetti, vengono in realtà bollati d'avarizia e indifferenza rispetto alla poesia (trattano meglio chi gli taglia la carne o mette e toglie gli stivali o striglia i loro cavalli), dove preti e papi sono titolati d'asini e ingrati, dimentichi del bene avuto in passato (Leone X), dove i letterati sono descritti come eretici per puro snobismo e viziosi nell'animo, difficilmente, ripetiamo, testi di tal tenore saranno stati destinati al pubblico.
Le Satire di Ludovico Ariosto (come suggerì Segre in uno dei suoi ultimi scritti) sono probabilmente il suo “libro segreto”, dove dire la verità, dove esprimere tutta la sua insofferenza per questo mondo infame, che ai poeti toglie la pace e ai poveri il pane.