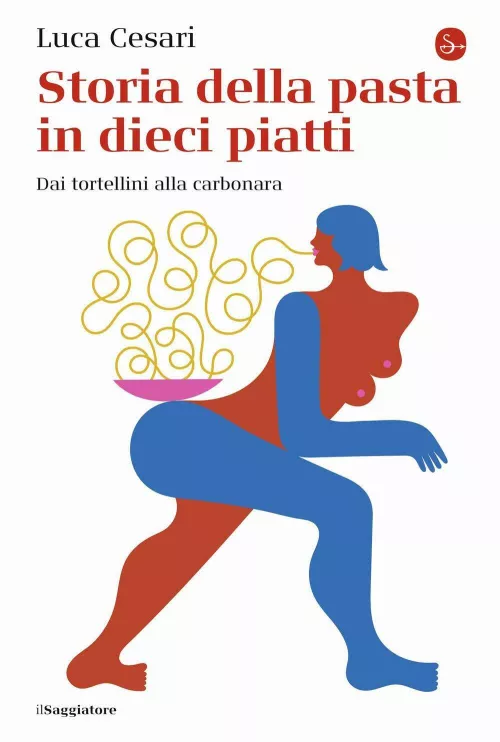Contro il gastropurismo / Politiche della panna
Sta tornando la panna in cucina? Dopo i fasti degli anni Ottanta e le maledizioni dei decenni successivi, non avevamo fatto in tempo a liberarcene del tutto ed ecco che quest’orgogliosa crema iperindustriale e goduriosissima rifà capolino: non solo per facilitare le operazioni ai fornelli ma soprattutto per accontentare i gusti – tanto semplici quanto esigenti – dei gourmet dell’ultimora, affascinati da una gastromania che non cessa di appassionare i palati di grandi e piccini. Se a MasterChef un concorrente aggiunge una spruzzata di panna in una pietanza lo cacciano via in malo modo. Su di lui anatema. Nell’alta ristorazione è bandita per principio. Nelle trattorie la si usa con assoluto riserbo, come se fosse capitata là per caso. E nei ricettari è praticamente sparita. Ben pochi, poi, sono i cucinieri che a casa propria apprestano, poniamo, una carbonara o una scaloppina amalgamandole con questa specie di malin génie dei nostri stomaci traballanti.
Domanda: perché cotanto livore antipannesco? Pura, prevedibile, piccata reazione verso qualcosa che, or sono, aveva avuto il suo momento di gloria, partecipando come soluzione passepartout in tutte quelle preparazioni che, invece, richiederebbero maestria, concentrazione, inventiva, sacro rispetto per le materie prime? O c’è dell’altro? Rifiuto, forse, di quelle piccole, maneggevoli confezioni a forma di parallelepipedo che tanto sanno di congiura globale contro gli antichi sapori? Opposizione ideologica a ogni genere di marketing? Sta di fatto che, dopo anni di fosche censure, parecchi segnali ci dicono che stanno riemergendo qui e là manipoli di bastiancontrari: i quali, per intimo convincimento o desiderio di provocazione, ficcano la panna industrializzata anche nelle pepate di cozze o nei tournedos alla griglia, in barba a ogni perbenismo gastronomico sedicente universale. Sembra d’assistere a una rivoluzione al contrario, all’affermazione definitiva della faciloneria in cucina, del gusto omologato delle masse. Quisquilie, si dirà. E quisquilie sono, senza dubbio. Se non fosse che investono in primo luogo i nostri corpi che, volenti o nolenti, continuano a essere l’esito materiale – e morale – di ciò che vi mettiamo dentro. Se l’uomo è ciò che mangia, stiamo ricominciando a esser sostanza pannosa, inconsciamente cremeggiando nel sistema venoso e nervoso, nello scheletro, nei muscoli e chissà dove ancora. Ne risentirà la nostra vita sessuale?
Ma, in secondo luogo, la delicata questione del ritorno della panna ha una valenza ulteriore, investendo appieno, da un lato, le nostre convinzioni più o meno inesperte circa il senso del cibo e, dall’altro, le ipotesi storiografiche circa le sue origini, le forme della codificazione tradizionale, le dinamiche di trasformazione, le attestazioni in ricettari autoriali, racconti o rumors d’ogni specie e natura. Leggendo il bel libro di Luca Cesari Storia della pasta in dieci piatti (Il Saggiatore, pp. 272, € 22) capiamo subito che le alterne vicende della panna nella cacio e pepe o nella bolognese sono la punta di iceberg di quel che è sempre e comunque, molto semplicemente, la storia dell’alimentazione dans tout ses états: il segnale dei diversi modi di intendere, con il cibo, tutta la cultura che gli sta dietro, con le vessate questioni circa le sue origini sedicenti veritiere, la pretesa autenticità delle tradizioni (gastronomiche e no), le continue rivendicazioni d’identità di soggetti individuali e collettivi, comunità e popoli. La panna negli spaghetti è faccenda politica, non c’è niente da fare.
Bersaglio polemico del libro di Luca Cesari è così quel tipo che lui stesso definisce ‘gastropurista’, “nuovo sacerdote della tradizione culinaria italiana” che non perde occasione, nei social e non solo, per impartire lezioni su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in cucina, ritenendo di conoscere a menadito gli ingredienti unici e insostituibili delle ricette più tipiche. Costui, ricorda Cesari, dimentica che in cucina – e, possiamo aggiungere, in ogni altro aspetto della cultura – non si danno tradizioni definitive ma piuttosto inventate, create ad hoc e spacciate per eterne e immutabili; di modo che quel che riteniamo tipico è l’esito cangiante di molteplici usi e costumi, pratiche locali e invenzioni azzardate.

Inoltre, per quel che riguarda in particolare la pastasciutta italiana, considerata il simbolo più evidente della cucina nostrana, il nostro gastropurista ignora il fatto che essa non si perde affatto nella notte dei tempi, ma appare nei ricettari relativamente da poco. Artusi – la cui autorialità si cita sempre in dispute di questo genere – non la tiene in particolare considerazione. E in La cuciniera bolognese, un celebre ricettario del 1874, non c’è traccia dei piatti che oggi consideriamo icona del capoluogo emiliano: non ci sono né ragù, né lasagne, né tagliatelle, né cannelloni; e vi troviamo invece zuppa alla tedesca, alla portoghese e alla catalana, risotto alla milanese, manzo all’inglese, fegato alla veneziana e piccioni alla marchigiana. Come dire che – ribadirlo non fa mai male – la gastronomia è costitutivamente cosmopolita, interculturale, traduttiva, aperta al dialogo con gastronomie diverse, linguaggi ulteriori, culture lontane. Da cui, appunto, la sua intrinseca politicità.
Ma come s’è costituita questa tradizione inventata? Com’è accaduto che la pasta in generale, e alcune sue forme in particolare (fettuccine Alfredo, amatriciana, carbonara, gnocchi, tortellini, ragù alla bolognese, ragù alla napoletana, lasagne, pesto alla genovese, spaghetti al pomodoro), abbiano acquisito questo statuto di esclusiva tipicità, difesa a spada tratta da pletore di gastropuristi? Dalle variegate storie che Cesari fornisce per ognuno dei dieci piatti in questione emerge una risposta interessante: la tipicità interna si è costituita a partire da uno sguardo esterno, dalla prospettiva di un altro che, puntandoci, ha restituito di noi un’immagine al tempo stesso originale e semplificata, innovativa e riduttiva insieme. E questo altro, nel caso specifico, sta dal lato opposto dell’Atlantico, in quegli Stati Uniti dove si considera la cucina italo-americana fra le migliori di mondo, e non si manca di fare periodiche capatine nella nostra terra alla ricerca di nuove ispirazioni gastronomiche. La tesi è forte: sono stati gli americani che, più di tutti, hanno inventato la nostra tradizione culinaria, adottando alcuni dei nostri piatti magari minori, spesso di nicchia, e facendoli diventare monumenti planetari, tanto possenti quanto rivedibili. Come dire che gli italiani hanno iniziato a cucinare ciò che piace agli americani, e a un certo punto se ne sono talmente innamorati da assumere come proprio ciò che non lo era del tutto.
Prendiamo il caso topico delle fettuccine Alfredo, piatto pressoché sconosciuto in Italia ma assai noto in USA, dove compare in un migliaio di ricettari di cucina italiana, ed è diventato una specie di brand: esiste il Chicken Alfredo, come anche gli Shrimps Alfredo, per non parlare della pizza e dei sughi pronti, immancabilmente a base di sostanze cremose e formaggio, aglio e prezzemolo. Sembra che siano state preparate per la prima volta a Roma nel 1908 da un ristoratore, Alfredo di Lelio, con lo scopo di far tornare in forze la giovane moglie prostrata dal parto. Impastò le fettuccine con il semolino, le condì con burro e parmigiano, mantecò ad arte; poi recitò una preghiera. La moglie gradì e si riprese in fretta. E fu così che il piatto finì nel menu della piccola trattoria, dove, anni dopo, fu scoperto da alcuni turisti americani che, estasiati, ne parlarono come delle migliori fettuccine del mondo, spargendo la voce fra amici e parenti. Di lì a poco il piatto viene nominato in un romanzo di Sinclair Lewis, e il ristorante, trasferitosi in via della Scrofa, viene recensito sul Saturday Evenening Post, dove George Rector, critico gastronomico di punta, descrive entusiasticamente il rito con cui Alfredo in persona, al tavolo, amalgama alla perfezione la pasta prima di servirla caldissima ai commensali. Il fitto pellegrinaggio dei divi di Hollywood in via della Scrofa chiude il cerchio, e Alfredo diviene una specie di chefstar suo malgrado: da Ada Boni a Veronelli lo segnalano nelle loro guide. La fama della sua creazione è ormai consolidata, e nessuno si accorge, nota Cesari, che quel piatto, in fondo, non era altro che la riproposizione del modo medievale, precolombiano, di condire la pasta: lo si trova, fra l’altro, nel Decameron…
Viene da chiedersi: perché l’America adotta giusto questo piatto così banale? Cesari non ha dubbi: proprio per questa sua estrema semplicità. Innanzitutto nella preparazione, che chiunque sarebbe in grado di gestire, anche un dilettante, anche un totale incapace ai fornelli; e in secondo luogo per il suo gusto, democraticissimo nella sua piattezza avvolgente, nella sua cremosità senza incrinature, senza contrasti. Semplicità che, però, quasi si oppone alla teatralità del servizio al tavolo, spettacolino che ben miscela vago esotismo ed estetica circense. A fronte dell’aggressività sciovinista della gastronomia francese, tutta intingoli e stratificazioni, gli americani dai gusti facili scelgono insomma la cucina italiana, o, meglio, quella che loro considerano tale. Toccherà a Julia Child raddrizzare il tiro, importando negli States il boeuf bourgignon e la tarte tatin, mentre i nostri cuochi da trattoria continueranno imperterriti ad accontentare i turisti d’oltreoceano con le loro creazioni tanto elementari quanto saporite. Arrivano così la cacio e pepe e l’amatriciana, la carbonara e la gricia, i maccheroni al sugo di pomodoro e i paccheri al ragù di Napoli. Non tutti questi piatti, naturalmente, hanno la stessa storia, e Cesari si diverte a stilare un lungo elenco di stranezze e spigolature, casualità e causalità che li hanno posti in essere. Mostrando come molti dei luoghi comuni cui spesso si ricorre per narrare la nostra cucina siano da rivedere (basti ad esempio la pretesa indispensabilità del guanciale nella carbonara), ma molti altri possano essere confermati (i tortellini sono torte in miniatura), magari cambiando i contesti o i protagonisti.
Resta la convinzione di fondo secondo la quale più un piatto si istituzionalizza nella sua versione canonica, più si scatena la creazione di varianti. Così i tortellini – audace mimesi dell’ombelico di Venere – saranno pure il simbolo di Bologna, e proprio per questo si inseriscono in una costellazione quasi infinita di suoi cugini e cognati: agnolotti piemontesi, casunziei lombardo-veneti, tortelli cremonesi, anolini parmensi, tortelloni emiliani, agnolini mantovani, cappelletti reggiani, cappellacci ferraresi, pansoti liguri, tordelli toscani, ravioli marchigiani, colurgiones sardi, schluzkrapfen altoatesini, cjarsons friuliani… Tanta ricchezza, ma una stessa domanda: ci starà la panna?