Sul vivere, d’après / François Jullien, aspirare alla felicità?
Gli uomini “tendono alla felicità, vogliono diventare e rimanere felici”: l’incipit del freudiano Disagio della civiltà non sembra sospettare che possa esserci altra soluzione. Certo, possiamo non intenderci sul contenuto della felicità, ma resta scontato, quasi fosse un’idea regolatrice, che tutti gli umani, sotto tutte le latitudini, aspirino senza eccezione a realizzarla nella propria vita. Ogni azione, ogni scelta tende a un fine – ricchezza, successo, piaceri –, così esordisce l’Etica Nicomachea; ma questi fini restano subordinati a un Fine in sé, che non è mai scelto in vista di altro se non di se stesso, a un bene supremo sulla natura del quale tutti concordano. “La felicità sembra essere al più alto grado un fine perfetto”, scrive Aristotele, saldando un legame che resterà indissolubile nelle pieghe del pensare dell’Occidente, quello che connette la felicità alla “finalità”, all’agire orientato verso uno scopo. Non è forse il bene, per definizione, “ciò a cui ogni cosa tende”? François Jullien, in Nutrire la vita. Senza aspirare alla felicità (Cortina, 2006), mostra come sulla dialettica del desiderio che “tende a” si sia radicata la prospettiva drammatica con cui la sensibilità europea pensa l’esistenza: aspirazione infinita a ciò che sempre si sottrae, con l’inevitabile scacco a cui siamo destinati – e a cui solo il sogno dell’Aldilà consentirebbe di sfuggire.
All’edonista Callicle per il quale la felicità consiste nell’avere appetiti di ogni sorta e riuscire a soddisfarli, il Socrate del Gorgia obietta che il piacere starebbe allora solo nell’attimo in cui la mancanza viene colmata, per presto ripresentarsi. La parte licenziosa dell’anima in cui hanno sede gli appetiti è paragonata a un vaso forato nel quale continuiamo a versare senza posa; invano speriamo di annullare il vuoto che agisce come impulso dei nostri bisogni, la sazietà non ci è mai data, l’appagamento non fa che anticipare la delusione e il ciclo ricomincia. La vita dedicata alla soddisfazione degli appetiti carnali è votata all’indigenza e alla ripetitività: coazione a ripetere in cui il corpo, soma, si svela come sepolcro, sema. L’organismo-clessidra obbedisce al tempo reversibile del supplizio infernale, quello a cui vengono sottoposte le figure del mito punite dagli dei (Sisifo, Danaidi, Tantalo). Per Socrate, la felicità consisterà allora nel non abbisognare: il saggio sa controllare i suoi desideri, la sua botte è già colma, non chiede niente di più. Callicle osserva, sprezzante, che di bisogni sono privi solo le pietre e i morti, una vita senza il fluire, senza il mutamento di stato fra mancanza e soddisfazione, non è vita ma morte. Nell’ottica platonica il vivere propugnato da Callicle è invece quello del piviere (l’uccello che si credeva evacuasse immediatamente quel che mangiava), se non dello scabbioso la cui felicità si riduce alla libertà di grattarsi.
Gli appetiti si manifestano come bisogni o mancanze da compensare: si prova piacere a bere solo se e fin tanto che si ha sete. Ci è stato ripetuto fino alla noia: “Piacer figlio d’affanno”, “Uscir di pena è diletto fra noi”, sentenzia il poeta (La quiete dopo la tempesta) nell’esporre la sua teoria del piacere, in cui si avverte l’eco dell’Ecclesiaste. E se invece il fascino della vita stesse proprio nell’essere una botte forata, nel poter versare ancora, nel rinnovarsi continuo della mancanza? Che i nostri bisogni e desideri non siano mai pienamente appagati è proprio quel che mantiene la vita in corso, nella sua vitalità: è la mancanza a tenerla in tensione nel tra che si stende fra desiderio e sazietà, senza sognare uno stato ideale, terminale (come si dice di alcuni malati), di totale appagamento. La pienezza della vita non sta nel porto, nel ritorno a Itaca (lo sa bene l’Ulisse di Kavafis), nel/la fine in cui non dovremmo più proi(g)ettarci in avanti. Platone, rileva Jullien, è preso a tal punto nella trappola per cui il desiderio sorge dalla mancanza e la soddisfazione implica privazione, da non poter pensare che ci possa essere felicità terrena. Eppure, quando la pressione della fame o della sete si riassorbe, si può bere o mangiare non per colmare un vuoto, ma per gustare, per assaporare (un altro modo di immaginare Sisifo felice). Non dando consistenza al tra, cioè al tempo intermedio fra privazione e soddisfazione in cui si dispiega il processo del vivere, Platone non può che aspirare alla “vera vita”, quella che Lassù sarà concessa all’anima liberata; il fine (telos), scopo e perfezione insieme, si compie nell’aldilà dove si sfugge al divenire del mondo sensibile. Non è tanto per disgusto del mondo terreno, osserva Jullien, ma per un’incapacità filosofica a pensare il fra (metaxù), ridotto a inconsistente dileguare (alla vanitas del fumo della candela che si spegne), che Platone ha dovuto costruire l’oltre (meta) della meta-fisica.
Da Aristotele a oggi non si esce da questo luogo comune della saggezza dei popoli, di cui anche la nostra filosofia è rimasta preda: andiamo tutti in cerca della felicità, ma la soddisfazione inseguita non può che sfociare nella delusione. Lo Stagirita concepisce la felicità secondo la funzione propria dell’uomo e dunque in rapporto con la sua capacità più alta, l’anima razionale, che accede alla vita contemplativa (bios theoretikos); ma essa è pienamente accessibile solo all’uomo in grado di eguagliare la condizione divina, “pensiero di pensiero”. Freud la concepisce invece in base al principio di piacere e quindi sul “modello” del godimento sessuale da cui traiamo le soddisfazioni più vive; ma non è semplicemente la civiltà, reprimendo le pulsioni, a lavorare contro il soddisfacimento, osserva Jullien. Noi ci auguriamo una felicità che duri, mentre, in base alla stessa fisiologia freudiana, il nostro gioire più intenso non è avvertito in una condizione stabile, ma solo nel contrasto. Non sarebbe tanto il principio di realtà a rifiutarsi di accogliere il nostro desiderio, ma starebbe proprio nella “costituzione” dell’uomo il fatto che la soddisfazione si disfi nella durata, al punto che la felicità, più che inattingibile, è noiosa. Freud relega in nota, ritendendola “un’esagerazione”, la profonda intuizione di Goethe: “Niente è più difficile da sopportare di una serie di belle giornate”.
Jullien mette così a nudo l’anima pascaliana di Freud: la nostra natura è nel movimento, abbiamo bisogno di variazione e contrasto, siamo sempre in caccia delle cose, per cui l’esistenza non è che tumulto e turbamento. Ma la soddisfazione dei piaceri terreni è solo un inganno, al più fa insorgere la noia. Ponendo come egemonico il fine da cui tutto dipende, Pascal è indotto a dimenticare l’intensità del momento della caccia, della ricerca; resta nel solco della “piega” europea del pensiero che privilegia la stabile consistenza dell’Essere e, di conseguenza, attribuisce alla quiete la felicità piena. Di qui il grande Racconto consolatorio che promette la “vera vita”, quella in cui potremo “finalmente” sfuggire all’agitazione che è il segno della caduta e della nostra natura corrotta. Eppure, già i Padri della Chiesa si erano trovati in difficoltà nel pensare il Paradiso, la condizione delle anime elette, giunte al telos agognato: o la vita beata è soddisfazione piena, priva di desiderio in quanto priva di mancanza, ma allora insorgerà la sazietà della visione divina, dice Origene, oppure anche in quella vita si conserverà la fame di Dio. La soluzione di Agostino non può che ricorrere all’ossimoro, segno qui di un arresto del pensiero che prepara il salto nel mistero: “sazietà insaziabile”, parallela all’invisibile visio di Dio.
Nella grecità arcaica la felicità è affidata all’intervento della fortuna, alla benevolenza divina o al gioco del caso, come attestano i termini eudaimonia e eutichia, buon demone e buona sorte. Già nei Presocratici diviene conquista interiore; è il carattere, l’ethos, a essere per ogni uomo il “demone” che lo rende felice o infelice, suggerisce Eraclito; e Democrito ricorda che la “dimora” della felicità è nell’anima, preparando il terreno alla scelta platonica che, argomenta il Fedone, affida la felicità alla liberazione dell’anima dai vincoli terreni. È vero però che la grecità non equivale – come Jullien tende a pensare – al dualismo che radicalizza il conflitto fra Essere e Divenire, anima immortale e corpo transeunte. Già in Platone, poi in Aristotele e nelle scuole ellenistiche, si esorta a una terrestre saggezza, al buon uso dei piaceri, al controllo delle passioni al fine di promuovere la “cura di sé”.
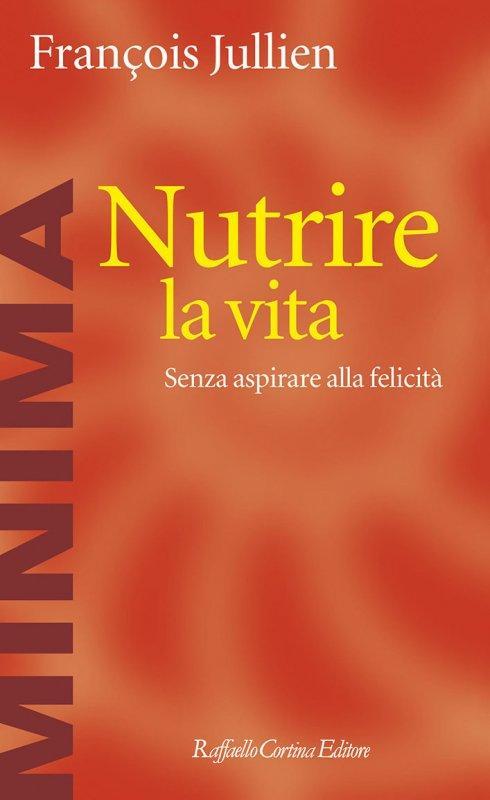
Non si invita alla rinuncia o alla inibizione del desiderio, semmai ad avere “competenza dei propri desideri”, secondo quella prospettiva che Salvatore Natoli, nel confronto serrato con la cultura cristiana e i miti della modernità, ha chiamato “etica del finito”. Se è vero che la felicità rapisce e giunge inattesa, quasi si nutrisse della propria istantaneità, il bene, pur nella sua fragilità, è anche meta perseguibile, frutto di ricerca e di conquista, progetto che non si arresta nell’attimo ma coinvolge la vita intera (La felicità, Feltrinelli, 1994). La felicità è di questa vita, ricorda Natoli, senza illusioni di trascendenza o di illimitato restare: da dono fuggevole può tradursi in virtù in grado di edificare il tempo lungo dell’esistenza, quando si è in grado di dispiegare la vita in tutti gli istanti del nostro transitare; ed è quanto ben sapeva Leopardi, “La felicità non è che la perfezione, il compimento e il proprio stato della vita” (Zibaldone, 1823). Se è vero che l’esperienza della felicità si esprime in una sensazione di pienezza, in un potere illimitato di espansione, tale sensazione non si arresta all’attimo del godimento, meglio si realizza nel distendersi di tutta la vita.
La radice indoeuropea del termine felicità, da cui derivano anche il latino ferax (detto della terra generosa di frutti) e femina, indica in generale una capacità di fecondare, di generare; è l’esperienza di chi si espande, avverte un incremento di sé che lo rende intimo alle cose. La felicità è in tal senso “coestensiva all’insieme di relazioni che abbiamo con il mondo”, scrive Natoli: la tensione verso l’altro di cui facciamo esperienza nella felicità non spinge ad annullarlo ma a lasciarlo esistere nella sua alterità, per stringersi con il prossimo nella “perfezione del legame”. Ed è solo dalla consapevole assunzione della nostra condizione di finitezza che la felicità assume dimensione etica: il sentimento che ogni esistenza si conserva, nel tempo breve che le è affidato, solo nella relazione ad altro, induce a ben amministrare il proprio tempo, senza illusioni ultraterrene e ansie di infinito, e insieme ad annullare ogni ipertrofia del sé. La constatazione dell’inevitabile deperire delle cose non è causa di mestizia ma invito ad apprezzare la vita, a saper godere dell’oggi e avvicinarsi a una buona morte; solo nella “sazietà dei giorni”, dice il testo sacro, si esprime la benedizione divina.
Anche la Cina antica, ricorda Jullien, ha conosciuto l’idea di una buona sorte, prossima all’eudaimonia greca, concessa dalle divinità o dagli antenati, ma è una felicità di natura eminentemente materiale; così negli auguri per l’anno nuovo si formulano auspici di ricchezza e di prole, “molto denaro, molti bambini”. Se il versante greco ha finito per fare dell’anima, psyché, l’autentico supporto della felicità, la Cina, ignorando il dualismo fra psichico e somatico e lo scopo a cui tendere, nemmeno ha elevato la felicità a termine ideale che segni il compimento delle nostre aspirazioni. “Nutrire” si scinde nella nostra cultura secondo la grande distinzione fra materiale e spirituale, due piani fra cui esiste “parentela” (suggeneia), suggerisce Platone: una biforcazione capitale a partire dalla quale, nota Jullien, qualcosa come un destino occidentale dello “spirito” si è definito nel corso della storia.
Come nutro il mio corpo, così la mia anima trova un “cibo benefico”, la pastura della “pianura della verità”, nella contemplazione delle realtà ideali. Esortando a innalzarci dai nutrimenti “carnali” a quelli “celesti”, la tradizione religiosa non farà che restare immersa nella “piega” che oppone il concreto e il simbolico: la “fame” vera è quella della parola di Dio, i misteri ne sono il “nutrimento” e il Signore ha raccolto per noi il “grano delle Scritture” … Il discorso patristico evocherà di volta in volta il “latte” che nutre i neofiti, i “legumi” che curano i malati ancora dubbiosi, o la “carne dell’Agnello” riservata agli eletti, già annunciata dalla manna concessa da Dio al suo popolo peregrino nel deserto. Cristo ci ha dato il pane di vita ed esorta i discepoli ad essere “il sale della terra”. Il saggio confuciano, ricorda Jullien, aspira invece ad essere insapore, a mantenere uno status neutro, indeterminato, fa il vuoto in se stesso, resta cioè disponibile per aderire al meglio all’avvento delle differenze (Elogio dell’insapore, Cortina, 1999).
Nello Zhuangzi ricorre di continuo la formula “nutrire la vita” (un intero capitolo verte “Sul nutrimento vitale”), formula che non separa l’ambito fisico da quello psicologico. Si tratta di prendersi cura e promuovere il potenziale di vita di cui siamo investiti, restaurare le forze man mano che si esauriscono e ravvivare le nostre capacità depurando l’organismo. Quel che suggeriscono i Letterati cinesi in altri termini è mantenersi “evolutivi”, affinando e decantando il vitale in sé, in modo che sia portato al suo pieno regime. La Cina antica, dove ancora agiva lo sfondo sciamanico, ammette che l’anima di un uomo possa lasciare il corpo, mentre ancora è in vita, come pure la possibile separazione, alla morte, di diverse anime: non un’anima unica “che si ritira in se stessa”, ma delle anime più sottili che raggiungono il Cielo e si fondono nei soffi yang, mentre altre, più materiali, tornando alla Terra si mescolano con le energie yin. Ma la Cina non ha comunque pensato ai modi con cui garantire la sopravvivenza dell’anima, e questo perché non ha staccato il principio vitale dal nostro essere organico; non vi è anima (come “sostanza”, per la quale si ponga la questione della sussistenza extracorporea), ma invece un principio di animazione designato come la “quintessenza”, il “fine” o il “sottile” (jing). L’ideogramma designava in origine il chicco di riso brillato, nel senso dunque del “fior fiore di”, la “prima scelta”, come pure lo “spirito” del vino o di un profumo: ogni materia che si è decantata, depurata fino a farsi energia, in opposizione allo stadio del tangibile, dell’opaco e dell’inerte. Non conoscendo Giudizio finale né Resurrezione, non si tratterà dunque di salvarsi l’anima, ma di salva-guardare la propria vitalità, di affinare (jing) la dimensione di spirito (shen); più mi affino – mi “decanto”, mi “sciolgo” – più mi animo e così nutro la mia vita, cioè acuisco le capacità organiche e insieme distendo la “dimensione di spirito”.
Di qui, evidenzia Jullien, la forma particolare che assume in Cina quel che noi chiameremmo la scelta di vita: ci si può lasciare materializzare e opacizzare fino a bloccare la reattività vitale, cadere nel torpore e non partecipare più al processo respiratorio che scandisce il ritmo della vita. E in questo caso la paralisi non origina soltanto la malattia, ma annulla anche il “senso di umanità”, al punto di non reagire più a qualcosa di intollerabile che minacci un altro e non avere più “pietà”. Oppure, liberatisi dalle ostruzioni si torna a vibrare all’unisono con il soffio-energia (qi) che scandisce la regolazione armoniosa del mondo. Il sinogramma qi rappresenta, stando alle grafie antiche, l’elemento vapore che sormonta il riso e richiama la sua funzione nutritiva; oppure che sormonta il fuoco e in questo caso raffigura la capacità di emanazione. Ora, è soltanto a questa condizione che potremo “conservare la nostra persona” e “dispiegare fino al loro termine tutti i nostri anni”.
Non avendo concepito alcuna immortalità né immaginato un paradiso possibile, un grande “Lassù” in cui evadere dal divenire terreno, la Cina antica ci svela la via di un altro Sogno o di un altro “ideale”: non la salvezza attraverso la Vita eterna ma la Lunga vita. Lo Zhuangzi richiama ad esempio i geni del Monte Gushi che si nutrono solo di vento e di rugiada, o la Vegliarda che conserva una pelle “splendida come la neve” e rimane “di una delicatezza e di una freschezza di vergine”. La via (tao) che quest’ultima ha seguito le consente di conservare depurando, cioè di giungere per gradi a trattare come “esterni”, non più d’intralcio alla vitalità, il “mondo intero”, “le cose” e l’assillo stesso del vivere. Così può accedere alla “trasparenza del mattino”, a quell’indipendenza per cui i turbamenti del mondo non ostacolano più la “placidità”: una condizione di “tranquillità-limpidezza” per molti tratti assimilabile alle forme di saggezza delle scuole ellenistiche coeve.
“Scendo con i vortici e risalgo con i gorghi”, dice il vecchio che si lascia trasportare dall’acqua violenta e insidiosa che scorre sotto una cascata. Immerso nel flusso, si limita a seguire il tao dell’acqua, a far sì che l’effetto si produca da sé: “la vita è come fluttuare, la morte come riposare”. Qui “fluttuare”, rileva Jullien, non rimanda al “mondo fluttuante” dell’arte della stampa giapponese, che cattura il fascino fuggevole e doloroso dell’esistenza. Fluttuare dice invece la capacità di non immobilizzarsi in alcuna posizione e al tempo stesso di non tendere verso alcuna direzione; di mantenersi in movimento continuo, trasportati dall’alternanza respiratoria del mondo, e nello stesso tempo di non sprecare energie o incontrare resistenza. Eliminando il pensiero della destinazione e quindi lasciando riassorbire l’idea della finalità, “fluttuare” è il verbo che dice al meglio il nutrimento del vitale e insieme contraddice l’aspirazione alla felicità. Fluttuare è infatti non fissarsi alcun porto, non darsi alcuno scopo, e nello stesso tempo restare sempre attivi, pronti e leggeri. Non è esitare e neppure andare alla deriva per darsi all’ebbrezza dell’avventura; si oppone alla drammaticità della traversata e altrettanto al torpore della fissità. “Fluttuare” non significa avanzare verso e neppure irrigidirsi, ma lasciarsi muovere e rinnovare a seconda dell’incitamento del mondo.
Leggi anche:
Mario Porro, François Jullien, sul vivere







