Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo / Siamo mito
“Come fuori, così dentro” si potrebbe riassumere così, parafrasando la celebre massima alchemica, la tesi dell’ultimo libro di Joseph Campbell, Le distese interiori del cosmo. La metafora nel mito e nella religione, Nottetempo, 2020. Si tratta di una raccolta di saggi che amplificano delle conferenze tenute tra il 1981 e il 1984 nello sforzo, consueto per Campbell, di illuminare la transculturalità, ossia gli elementi costanti, nonostante le variabili etnico-culturali, dei miti. Al cuore di ogni narrazione mitologica, che Campbell ha il merito indiscusso di mostrare ancora viva negli aspetti più comuni delle nostre culture, ci sono temi che Adolf Bastian (1826-1905) chiamava “idee elementari” e Carl Gustav Jung (1875-1961) “archetipi”; si tratta di cristallizzazioni di risposte millenarie che la fantasia e l’immaginazione delle diverse civiltà umane hanno elaborato per affrontare questioni esistenziali che le hanno profondamente interrogate. Naturalmente queste forme archetipiche variano a seconda delle idee etniche che una determinata cultura esprime, ma esiste tra di loro una dialettica che Campbell riassume così: “l’idea elementare è radicata nella psiche; l’idea etnica attraverso cui si manifesta è radicata nella geografia, nella storia e nella società” (p. 145); si accede al punto di vista del mito quando “nelle forme di un ambiente traspare la trascendenza” (p. 28).
Il suo lavoro più celebre sull’universalità del mito è sicuramente quello relativo a L’eroe dai mille volti (1949, tr. it. Lindau, Torino, 2012) figura che, nelle più disparate e diversificate espressioni culturali, lontanissime tra loro nello spazio e nel tempo, passa comunque sempre attraverso i seguenti snodi esistenziali: una nascita misteriosa, una relazione complicata con il padre, ad un certo momento della sua vita sente l’esigenza di ritirarsi dalla società e, in questa condizione, apprende una lezione, o elabora un sapere, che orienterà diversamente la sua vita, poi ritorna alla società per mettere al suo servizio la lezione che ha appreso, molte volte (ma non necessariamente) grazie ad un’arma che solo lui può usare.
In questo libro, invece, l’attenzione si rivolge alle diverse cosmologie e ai miti soteriologici elaborati nel corso dei millenni dalle differenti culture che si sono susseguite, e affiancate, nel nostro pianeta, comprese le attuali, e si organizza intorno alla felice intuizione kantiana che spazio e tempo siano categorie interiori della psiche che vengono applicate alla realtà esterna. Citando Novalis Campbell scrive: “La sede dell’anima è laddove il mondo esterno e il mondo interno s’incontrano”, e aggiunge, “è questo il paese delle meraviglie del mito” (p. 43). Non si equivochi: il paese delle meraviglie, non è un mondo fantastico, illusorio, ma lo spazio nel quale apprendere a ridestare la meraviglia, ad attivare l’intero psichismo dell’uomo, a sviluppare una particolare capacità di attenzione che, facilitata dalla forma narrativa del mito, insegna ad aprirsi alla trascendenza, ossia all’eccedenza di senso e significato che incarna ogni simbolo, mai riducibile a una perfetta equazione con quanto rappresenterebbe. Ed è qui che Campbell ci regala una delle sue pagine più interessanti:
“Le figurazioni mitiche sono metaforiche (…) in due sensi contemporaneamente: in quanto portatrici di connotazioni psicologiche e, allo stesso tempo, metafisiche. Attraverso questa doppia messa a fuoco, le caratteristiche psicologicamente interessanti di ogni ordine sociale locale, di ogni ambiente o di ogni ipotetica storia, possono venire trasformate attraverso il mito in trasparenze rivelatrici di trascendenza.
Immanuel Kant ci ha fornito una formula straordinariamente semplice per interpretare queste due connotazioni. Compare nei Prologomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza ai paragrafi 57-58. Ci viene offerta una proporzione a quattro termini (a sta a b come c sta a x) che punta non tanto a porre un’imperfetta somiglianza tra due cose, ma definire un’identità perfetta di due rapporti tra cose del tutto dissimili (…). Non “a in qualche modo assomiglia a b”, ma il rapporto tra a e b è perfettamente identico a quello tra c e x, dove x rappresenta una quantità che non è soltanto sconosciuta, ma assolutamente inconoscibile, metafisica” (p. 80).
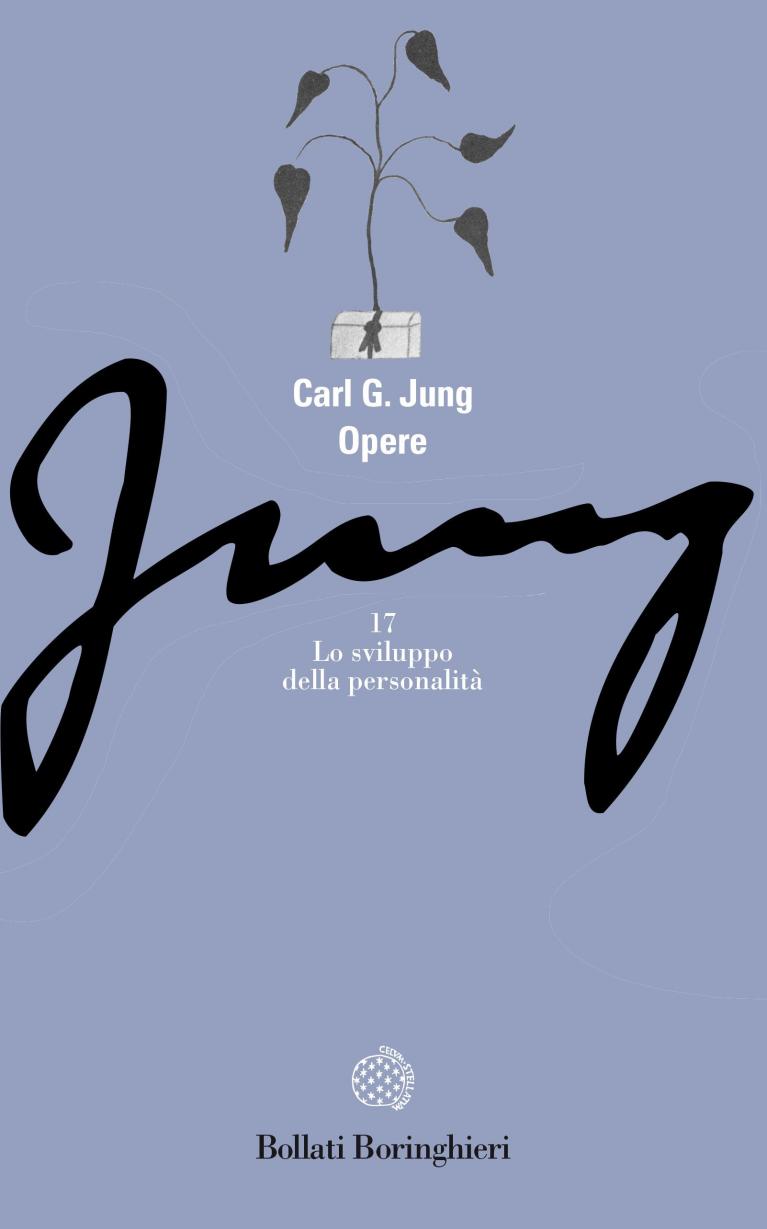
Mi sembra un esempio realmente illuminante per comprendere il senso di ogni comparazione e di ogni ermeneutica simbolica. Lo ha spiegato bene Jung: il simbolo, centrale in ogni mito, non rimanda a una realtà significata, è esso stesso realtà operante, costituisce la specifica capacità umana di “orientare la coscienza verso ulteriori possibilità di senso”, poiché non è mai del tutto riconducibile ad un significato univoco e definitivo; per questo non può essere ridotto alla semiotica perché la sua funzione è piuttosto psicagogica, vale cioè per gli effetti che produce nella psiche, per le energie, le immagini, le interpretazioni, i processi psichici che sa evocare, promuovere, mettere in gioco (C. G. Jung, Tipi psicologici, 1921; tr. it. Bollati Boringhieri, 1977 e sgg, p. 527). Ecco perché il ricorso a Kant, a quell’x che resta inconoscibile e che apre alla metafisica, a ciò che trascende ogni possibilità di possesso e de-finizione del senso ultimo, appare particolarmente pertinente.
I rapporti che vengono suggestivamente indagati da Campbell, dicevamo, sono quelli che comparano lo spazio interiore e quello esteriore, secondo la celebre analogia tra macrocosmo e microcosmo:
“la profondità e la sublime maestà della mitologia soppressa può essere apprezzata al meglio attraverso due movimenti a orologeria apparentemente irrelati; l’uno è il più grande orologio dello spazio esteriore, l’altro appartiene allo spazio interiore. Sono rispettivamente la precessione astronomica degli equinozi e il battito fisiologico del cuore umano” (p. 54).
Attraverso un nutrito numero di calcoli e dati ricavati dagli studi di astronomia, i calendari ideati dalle diverse culture a partire dagli antichi babilonesi, le fonti bibliche, le arcaiche Upanisad induiste e i più remoti testi taoisti, Campbell giunge ad analizzare suggestivi – per un certo tipo di lettore – consonanze tra i cicli biologici del sistema solare (macrocosmo) e quelli dell’individuo (microcosmo). Ma non mi sembra questo il punto cruciale dei suoi sforzi, che consiste piuttosto nel promuovere una diversa prospettiva sul mondo e sulla vita, non più incentrata sulle nostre idee etniche, sui limiti delle nostre culture, ma aperta al riconoscimento di un’unica realtà “il cui centro è ovunque”, della quale dovremmo finalmente farci carico in maniera universale (si pensi agli assurdi sforzi dei singoli stati, in questi difficili giorni, di arginare il coronavirus secondo strategie nazionali, anziché comprenderne la portata globale che richiederebbe interventi condivisi, in tutti i sensi, su scala mondiale e non, addirittura, regionale – per non parlare delle differenti valutazioni a seconda delle fasce di età).
Dopo aver preso in esame i miti cosmologici e soteriologici delle diverse religioni delle nostre principali culture, Campbell giunge a questa conclusione:
“Il primo passo per partecipare al destino dell’umanità, che non è quello di questo o di quel popolo, ma quello dell’intera popolazione del globo, è riconoscere che ogni immagine locale di un dio non è che una delle molte migliaia, dei milioni, forse anche miliardi di simbolizzazioni limitate di un mistero al di là della vista e del pensiero” (p. 63).
Il pensiero mitologico, quando non viene letteralizzato, promuove dunque un’apertura alla transculturalità, alla trascendenza di ogni appartenenza storico-culturale e si propone, in maniera apparentemente contro intuitiva, come strumento di laicità. Qui incontra l’arte, per la sua capacità di trasformare la coscienza e la visione abitudinarie della realtà in favore di un punto di vista nel quale, “la mente viene fermata e innalzata al di sopra del desiderio e dell’odio”; sono parole di Joyce che Campbell fa sue e che trova affini all’esperienza ascetica che dovette compiere il Buddha prima di raggiungere l’illuminazione: vincere i tre demoni del desiderio (Kāma), della paura della morte (Māra) e l’identificazione con i vincoli sociali (Dharma), per accedere a una condizione che li sappia trascendere (pp. 201-201).

Un percorso e un’opportunità che, in chiave individuativa, sono poste al centro del lavoro di Giovanna Morelli nel suo Poetica dell’incarnazione. Prospettive mitobiografiche nell’analisi filosofica (Mimesis, 2020). In questo libro – uscito per la collana di Mimesis “Philo-pratiche filosofiche” curata da Claudia Baracchi – l’arte appare lo sfondo dal quale può emergere una rappresentazione mitobiografica della vita di ciascuno di noi, ossia, secondo la lezione di Ernst Bernhard, il modo di riconoscere come ogni singola esistenza si apra, o meglio si riconosca, in alcuni mitologemi (singoli aspetti di un mito) che si prestano a leggerne alcune gesta. Lo sguardo mitobiografico con il quale Morelli invita a osservare la vita, a partire dal racconto della propria, permette di “scoprire e amare l’universale attraverso il particolare, preservando entrambe le dimensioni”, di “narrare la propria vita secondo il disegno di senso che la illumina, la magnifica, la collega a figure universali e pertanto la rende epica, emblematica” (p. 127).
L’arte che indaga l’analista filosofo è dunque quella incarnata, ossia, consapevole che la vita di ciascuno di noi accede al simbolico grazie e attraverso quelle che James Hillman chiamava “metafore radicali” offerte dall’inconscio collettivo, ossia le strutture percettive, gli archetipi, che organizzano l’esperienza umana come già da sempre sovrapersonale.
Lo specifico di ogni vicenda biografica non viene meno se riconosce nel suo sviluppo echi, modalità e variazioni di temi ricorrenti nella storia dell’umanità - di cui la psiche mantiene una traccia in forma, appunto, archetipica – ma procede al contrario verso la sua individuazione, la possibilità di autenticare in modo esclusivo la propria esistenza, “se comunica con se stessa alle più diverse latitudini spazio-temporali, attraverso le tante narrazioni-quadro che si sono avvicendate nella storia” (pp. 38-39).
L’arte è qui poiesis, anzi, mitopoiesi e la vita, vista dall’osservatorio privilegiato della stanza d’analisi, ne costituisce il principale teatro (Giovanna Morelli è anche regista d’opera e critica teatrale), lo spazio in cui s’incontrano e si scontrano le nostre maschere sociali e i nostri doppi impresentabili, ma anche dove si facilita una più profonda espressione di sé che, in una vicenda personale, sa scorgere tracce di qualcosa di universale – il che, osserva Jung, è già di per sé terapeutico:
“Il mito ha bisogno d’una nuova veste in ogni nuova era, se non vuol perdere la sua virtù terapeutica. (…) gli archetipi inconoscibili sono vivi (…) cambiano nome e veste in una successione infinita, e proprio attraverso questi mutamenti esprimono la loro imperscrutabile essenza” (C. G. Jung, Aion, Ricerche sul simbolismo del Sé, Bollati Boringhieri, Torino, p. 170, cit. in G. Morelli, op.cit., p. 45).
Un’operazione che, in modo diverso, sia Campbell che Morelli, ci invitano a fare per riconoscere nei miti la via maestra alla coltivazione di quella trascendenza che non rimanda a mondi altri e paralleli ma anima l’immanenza, qui ed ora, da sempre.







