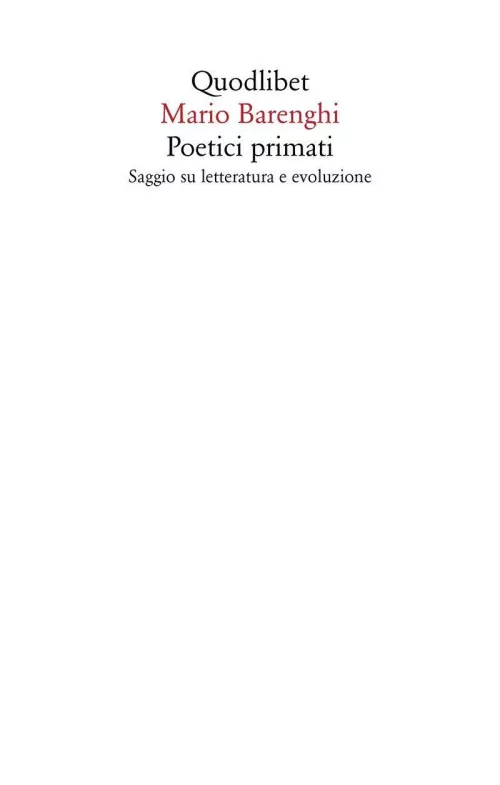Mario Barenghi / Poetici primati. Saggio su letteratura e evoluzione
Letteratura e evoluzione: è lecito un accostamento tra questi due termini?
Se intendiamo l’evoluzione non in senso storico, non come il progredire nel tempo delle vicende umane, ma in senso darwiniano, ossia come la vita si evolve sulla Terra è possibile un confronto tra questo paradigma e la letteratura?
Queste domande non sono nuove, per quanto possano apparire ancora oggi paradossali a tutti coloro che si sono formati alla scuola della storiografia letteraria tradizionale, che in Italia e in molti altri paesi è quella che si basa sui principi dello storicismo. Vale a dire sull’idea che l’avvicendarsi degli eventi del mondo e insieme ad essi delle forme simboliche, tra cui quelle artistiche, segua una traiettoria riconoscibile, una direzione determinata.
Il modello storicistico ha sostituito a fine Settecento in campo artistico e in particolare in ambito letterario quello classicistico che per secoli ha inteso l’arte come una pratica basata su un fascio di valori estetici immutabili: la costruzione armonica, lo stile elevato, la simmetria delle parti, la compiutezza del tutto. Essi erano la marca identificativa del valore delle opere d’arte, fossero esse figurative, architettoniche, letterarie. Un modello di rappresentazione dell’essenza artistica che presupponeva una fede nell’eternità dei valori formali e sottendeva un’idea della storia come eterno ritorno dell’identico.
L’ingresso nella discussione estetica del paradigma darwiniano è un fatto recente, risale agli ultimi trent’anni e ha interessato alcuni settori della teoria letteraria, soprattutto americana, provocando un movimento tellurico la cui portata è ancora tutta da scoprire.
A questo filone degli studi letterari si rifà il ricchissimo libro di Mario Barenghi che sceglie come titolo un divertente calembour: Poetici primati. Lo stupore del titolo si stempera poi subito nella dizione esplicita del sottotitolo: Saggio su letteratura e evoluzione (Ed. Quodlibet, 2020).
Dunque letteratura e evoluzione sono pensabili insieme. E i poetici primati? Non sono i traguardi di eccellenza raggiunti dall’ars poetica ma gli uomini la cui evoluzione di specie ha consentito loro di impadronirsi di questa peculiare abilità che ad altre specie animali è preclusa, appunto l’abilità poetica.
Ma cos’è questa abilità e su cosa si basa? Ora, è bene ricordare che tra le domande a cui da sempre si cerca una risposta senza trovarla c’è quella che Jean-Paul Sarte ha enunciato nel celebre titolo di un suo libro: “Che cos’è la letteratura?” Per quanto possa sembrare strano, la risposta più persuasiva a questa domanda l’ha data Aristotele venticinque secoli fa nel suo aureo libretto sulla Poetica. I numerosi tentativi di definire l’essenza della letteratura, la differenza tra testi letterari e testi comuni, tra narrazioni letterarie e narrazioni di cronaca, tra linguaggio poetico e linguaggio ordinario sono naufragati sugli scogli delle eccezioni, delle affermazioni del tipo: “questa definizione vale per molti testi ma non per tutti”.
Non passerò qui in rassegna la quantità di tentativi che l’ostinazione definitoria dei teorici e critici della letteratura ha prodotto soprattutto nel Novecento, nelle diverse scuole e fedi che si sono alternate fino alla fine degli anni Settanta.
Mi limito a constatare che di fronte alla vanità degli sforzi intrapresi nell’ambito di quelle che un tempo si chiamavano le “Geisteswissenschaften”, le scienze dello spirito, c’è stata una reazione di segno contrario: dall’esplorazione delle regioni dello spirito si è passati all’indagine sui fondamenti naturali dei comportamenti umani e segnatamente della scrittura letteraria. Facendo così rientrare il gesto del comporre poesia, in particolare il narrare storie, tra i comportamenti di homo sapiens (o forse dell’intero genere homo) e come tale spiegabile in termini evolutivi. Come dichiara Barenghi: “…gli usi poetici del linguaggio sono connaturati alla nostra specie. Le radici e le pratiche discorsive incluse più tardi nel campo della letteratura si intrecciano con la storia dei nostri più remoti progenitori” (p.21).
È interessante osservare come le scienze della natura – biologia, cognitivismo, paleontologia, teoria evolutiva – mentre forniscono oggi i paradigmi di una nuova esplorazione delle pratiche letterarie, abbiano offerto in passato – per intenderci a partire da Galileo – gli strumenti che hanno permesso di stabilire la fondamentale differenza tra verità e finzione relegando l’universo letterario all’ambito dell’immaginazione o, per usare un termine che ha avuto corso nella metafisica classica, nel regno dei phantasmata, di ciò che non esiste – così per Platone nel Fedro – un’immagine senza consistenza, destinata a evaporare, a dileguarsi.
Ma prima ancora di chiederci se sia legittima la letteratura, se abbia qualche relazione plausibile con il mondo in cui viviamo, se ci aiuti a vivere meglio, a capire la genesi dei nostri comportamenti, delle nostre emozioni, dobbiamo convenire sul fatto che letteratura è anzitutto uso della lingua. Non si darebbe letteratura senza il linguaggio. Quindi ogni ragionamento sulla letteratura non può prescindere da questo dato di fatto: capire il senso della letteratura non è possibile senza un’intelligenza del linguaggio, del suo funzionamento e, come vedremo, soprattutto della sua origine.
L’importanza del libro di Barenghi dipende soprattutto dalla tematizzazione di questa imprescindibile relazione e dall’efficacia con cui l’autore ricostruisce l’iter evolutivo che ha portato alla nascita della lingua negli umani e alla sbalorditiva adattabilità della lingua alle esigenze dell’ideazione poetica.
La letteratura teorica che si è occupata di questo tema è oggi sterminata. Ne aveva fornito una puntuale rassegna ragionata Michele Cometa in un libro intitolato significativamente Perché le storie ci aiutano a vivere. La letteratura necessaria (2017).
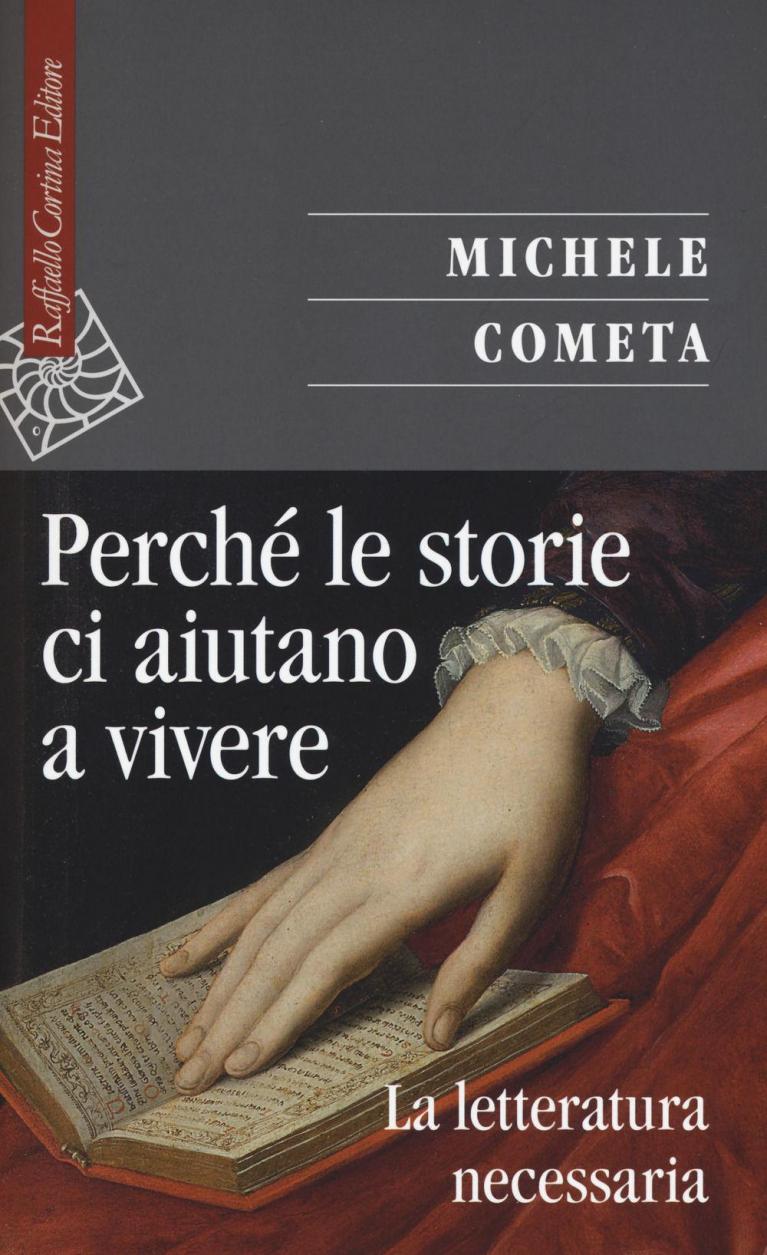
Poetici primati coglie e analizza alcune questioni centrali che riguardano l’evoluzione del comportamento linguistico umano, anzitutto quella che definirei la ‘naturalizzazione della cultura’. Vale a dire il fatto che la cultura non debba essere intesa come una sorta di culmine di un processo di progressivo congedo dalla natura, come abitualmente si è creduto, ma come un requisito primario della natura stessa dell’uomo. La cultura è principalmente relazione tra umani sia nel perimetro parentale sia nei nuclei sociali in cui ogni individuo è inserito.
Di qui l’importanza della capacità di esprimere intesa come un insieme di modi di relazionarci con i nostri simili: attraverso il corpo, la postura, la gestualità, l’atteggiarsi del viso e non da ultimo la voce. Ecco dunque che l’uso del linguaggio, osservato dalla specola di questa strategia relazionale multipla, si situa nel perimetro di una socialità biologica che riguarda la vita e la sopravvivenza degli umani.
Chi ha passato in rassegna la mole di studi settoriali usciti negli ultimi anni sotto le rubriche dell’ecocritica, del darwinismo letterario, della biopoetica, del cognitivismo letterario, per citarne alcune, trova finalmente nel libro di Barenghi una serena e rassicurante prospettiva fondativa che supera le visioni settoriali per interrogarsi appunto sui fondamenti delle numerose teorie che legano la letteratura alla biologia umana. Fra questi un’osservazione estremamente perspicua, mai sufficientemente sottolineata negli studi che conosco: i comportamenti umani volti all’espressione e alla relazione con il prossimo tra cui l’uso della lingua per tutte le sue finalità, ivi compresa quella cosiddetta letteraria, possono essere adeguatamente intese solo dalla prospettiva antropologica, ossia di quel sapere che nel Settecento era definito come scienza del commercium mentis et corporis: la relazione che lega la dimensione sensibile dell’uomo – percezione e emozioni – a quella cognitiva.
Una scienza, l’antropologia, a cui, ad esempio in Germania, si alimentano non solo Herder, autore di un fondamentale saggio sull’origine naturale del linguaggio (1772) ma fior di narratori e poeti come Wieland, Moritz e Schiller. Un genere letterario, il Bildungsroman, il romanzo di formazione, diventa addirittura in alcuni casi, per esempio nel romanzo di Moritz Anton Reiser, una sorta di traduzione mitopietica delle acquisizioni dell’antropologia. Il celebre dramma schilleriano I masnadieri, che sarà poi letto tutto in chiave romantica, vuole essere anche la rappresentazione degli effetti perversi che una cattiva relazione tra corpo e mente può provocare.
Se la funzione principale del linguaggio è “rendere umano il mondo”, come afferma Barenghi, la letteratura, vista da questa prospettiva, può essere intesa come una umanizzazione elevata a potenza. Il suo sostrato antropologico sarebbe allora un’intelligenza delle relazioni umane, un’esplorazione , attraverso il medio della narrazione, della diversità degli altri individui, anche di coloro che ci sono più vicini. Le loro emozioni, le asimmetrie del loro comportamento, le loro qualità morali sono rappresentabili attraverso l’esemplarità di una storia, di un personaggio o di una comunità di persone.
E qui si ritorna necessariamente alla Poetica di Aristotele che individuava nella capacità mimetica dell’uomo non solo il fondamento della poesia ma anche la possibilità di acquisire una superiore intelligenza del mondo unita al sentimento di piacere che l’osservazione della mimesis procura.
Poetici primati è un libro che sollecita di continuo confronti non solo e non tanto con la tradizione poetica, anche se non mancano i riferimenti letterari, ma con i significati spesso irriflessi che sono in gioco nel leggere e scrivere letteratura. In questo stimolo alla riflessione sul fondamento naturale della poiesis si disegna un quadro motivazionale che annovera le più diverse attitudini umane come ad esempio quella del desiderio di superare i confini della contingenza spaziale e temporale. Gli uomini vogliono superare i limiti che la vita impone non per hybris, come afferma una lunga tradizione morale e religiosa, ma per il gusto dell’esplorazione fantastica, del vedere al di là della siepe di leopardiana memoria, e al di là del nostro tempo: nel passato e nel futuro.
A questo proposito mi pare interessante notare come in una delle prime significative giustificazioni del romanzo come genere letterario composta in forma epistolare nel 1670, il Trattato sull’origine del romanzo del vescovo francese Pierre Daniel Huet, compaia una motivazione del tutto analoga. Cosa vogliono i lettori di romanzi, si chiede il vescovo di Avranches, cosa li attira delle favole e risponde così:
“questa propensione alle favole, comune a tutti gli uomini, non viene dal ragionamento, dall’imitazione, o dalla consuetudine: è naturale in loro, e innescata nella disposizione stessa del loro spirito e della loro anima; perché il desiderio di apprendere e di sapere è proprio dell’uomo e non meno della ragione lo distingue dagli altri animali. Anche in certi animali si trovano scintille di una ragione imperfetta e appena abbozzata, ma il desiderio di conoscere, voglio dire il desiderio di portare le proprie conoscenze al di là degli oggetti presenti, si nota soltanto nell’uomo.
La qual cosa sono convinto derivi da questo, che essendo le facoltà dell’anima nostra dotate di una troppo grande estensione, e di una troppo ampia capacità, perché possano riempirle gli oggetti presenti, l’anima cerca nel passato e nell’avvenire, nella verità e nella menzogna, negli spazi immaginari, e fino nell’impossibile, di che occuparle e esercitarle”.
L’erudito vescovo francese ha colto una caratteristica squisitamente antropologica che spiega ‘il piacere della lettura’ dei romanzi. Non si tratta bene inteso di una chiave che spieghi la qualità letteraria di un’opera narrativa ma di una prospettiva appunto fondativa senza la quale anche le più squisite eccellenze dell’arte poetica appaiono come algide presenze in un museo dei capolavori prive di una ratio che le giustifichi e soprattutto spogliate della loro relazione empatica con il lettore.
Uno studio come quello offerto da Barenghi ha il merito non secondario di riportare in primo piano l’esigenza ormai sempre più avvertita di una ‘de-estetizzazione’ dell’arte – il discorso vale anche per le arti figurative –, ossia del rovesciamento della visione museale delle opere, così da permettere di coglierne il potenziale comunicativo e in definitiva la loro collocazione nel mondo concreto e reale in cui viviamo.