L’atelier d’artista come dispositivo
Lo studio visit, l’invito cioè da parte dell’artista stesso a visitare il suo atelier, è ormai diventato un fenomeno diffuso per quanto piuttosto problematico. Se da un lato esso segnala una certa crisi della galleria privata in particolare che ha saputo rinnovarsi ben poco come luogo di esposizione e cultura, dall’altro è una ritirata sì nel luogo della creazione ma secondo una sua concezione piuttosto privata. D’altro canto, così come nella migliore delle ipotesi, quando l’atelier è lasciato “vivente”, come lo vive l’artista, non ripulito e sistemato a white cube, come si suol dire, e dunque trasformato in galleria, è anche la ricontestualizzazione dell’opera, delle opere, come operazioni creative, culturali, esistenziali. Ci sta anche un poco di feticismo, ma quel tanto che è giusto.
Chi non desidera conoscere l’artista che ama, sapere della sua vita, delle sue letture, frequentazioni, entrare nel suo mondo? L’atelier è una sorta di rappresentazione, magari anche in senso teatrale, della mente e della vita di un artista. Ricordo da questo punto di vista un dossier di doppiozero dedicato ai tavoli degli intellettuali e artisti. E, se posso, mi ci metto anch’io in questa scia, con una mia curiosità coltivata negli anni di fotografare gli studi che visito, alcuni dei quali ho raccolto scrivendoci le mie considerazioni in una piccola pubblicazione che si può scaricare in formato pdf qui.
Epperò l’arte nel frattempo è – o era? – uscita dagli atelier, nel senso in cui fin dalla progettazione l’artista la prevedeva fuori dal suo studio. Da questo punto di vista lo studio visit è forse anche un poco la reazione all’arte fatta per i musei, per i nonluoghi internazionali, per le biennali di ogni luogo. E ancora: mentre molta arte si fa da una stanza che non ha più niente dell’atelier dell’artigiano, o addirittura ci sono artisti che vivono spostandosi da un luogo all’altro, senza studio se non quello di volta in volta della “residenza”, chi non ha mai visto quei documentari alla televisione con l’apologia degli studi di artisti di successo come Jeff Koons, Takashi Murakami o Damien Hirst, organizzati come una catena di montaggio, una stanza dopo l’altra corrispondenti alle fasi di lavorazione, con decine di esecutori del progetto dell’artista? Che differenza dai leggendari atelier di artisti come Brancusi, Giacometti, Matisse, Bacon…
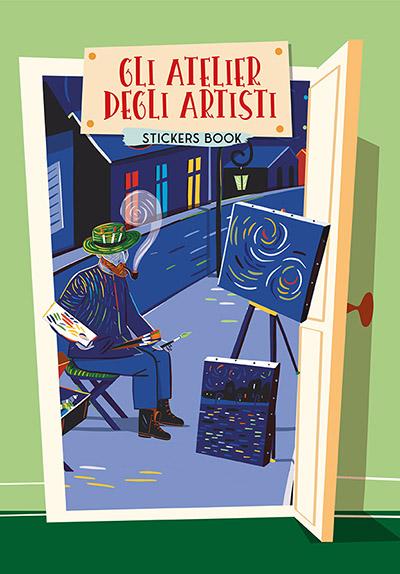
A proposito, quali sono gli atelier più famosi? A livello ultrapopolare ce lo dicono alcune piccole gustose pubblicazioni recenti. Ne prendo due significativamente diverse. Una è edita da 24ore cultura, intitolata Gli atelier degli artisti. Immagino che si rivolga a un pubblico di bambini e ragazzi, i testi, che sono di Marina Scognamiglio, sono molto semplici e introduttivi – con il classico retorico inizio: “Questo libro è un viaggio, Un entusiasmante viaggio nel tempo…” ecc. – con illustrazioni, di Silvia Marinelli, a loro volta molto schematiche. Quello che è divertente è che è fornito di stickers che vanno a completare, coinvolgendo il lettore, le immagini. A parte questo, gli artisti scelti sono sette, eletti evidentemente a più famosi: Leonardo, Michelangelo, Rembrandt, Monet, Van Gogh, Mondrian, Pollock. La scelta non sembra dettata dalla “storia” dell’atelier, ma esclusivamente dal desiderio di stuzzicare la curiosità del lettore attraverso comunque degli atelier molto diversi tra loro: pittore-scienziato, scultore, la bottega, l’en plein air, l’atelier sotto le stelle, l’astratto geometrico, la pittura in orizzontale. Non andiamo oltre, per carità, i ragazzi non capirebbero. Facciamo il primo passo.

Il secondo è molto più aperto e sofisticato addirittura. Si intitola I grandi atelier d’artista, scritto e illustrato da Les canailles, edito da Fatatrac. Le illustrazioni a me sembrano bellissime, piene di forme e di colori, senza dettagli e chiaroscuri, ma con quell’efficacia sintetica che ti fa riconoscere tutto e tutti. I testi sono efficaci, informano ma anche stimolano. Le immagini sono legate tra di loro con una serie di possibilità di gioco: “Osserva bene, perché 8 elementi di ogni inventario [degli oggetti, strumenti, opere] si nascondono nell’atelier seguente. Cerca di trovarli tutti!” e poi: “Guarda guarda… In ogni atelier si è intrufolato un intruso [un cagnolino]. Aiutaci a ritrovarlo prima che ne combini di tutti i colori!” Ruffiano, con il cagnolino, ma coinvolgente a vari livelli.
Gli artisti scelti? Intanto non solo e non tanto artisti famosissimi, ma una scansione storica: si parte dai “costruttori di piramidi”, si passa ai ceramisti, poi “gli artisti nella Chiesa”, Leonardo dichiaratamente artista scienziato, Dürer incisore, poi c’è Artemisia Gentileschi – che non tutti i ragazzi conoscono e che le ragazze è bene che conoscano –, Hokusai “l’artista delle 30.000 stampe” (con l’attenzione dunque non solo all’Oriente ma anche alla quantità), non può mancare Van Gogh, ma subito dopo c’è Méliès, e non c’è Rodin (peraltro dal mitico atelier) ma la sua “allieva” Camille Claudel; poi, udite udite, la coppia Jean Arp e Sophie Taeuber-Arp, una scelta davvero illuminata e illuminante; viene poi Man Ray, il fotografo; poi addirittura non un artista ma la scuola del Bauhaus all’insegna dell’“artista totale”; ultimi tre: Louise Bourgeois, lo stilista Saint Laurent e si chiude con Basquiat. Scelta interessante, attenta a molti aspetti, non scontata, aperta alla storia e alla varietà. Intellettualismo francese? Ma no, sono delle “canailles”!
Gli inglesi, si sa, sono di tutt’altra pasta. Esce per Einaudi Lo studio d’artista di James Hall, che è un inglese a tutto tondo. Il sottotitolo è “Una storia culturale” e lo è veramente, almeno in un senso determinato, cioè dipende da che cosa si intende per “cultura”. Di fatto il libro rifà la storia dell’atelier dall’antica Grecia alla contemporaneità, ripercorrendo le testimonianze, visive e letterarie e storiche, in maniera dettagliatissima. Hall è uno storico scrupolosissimo e un erudito, niente gli sfugge, di qualsiasi dettaglio ricostruisce almeno in sintesi quando è stato inventato o è apparso, che sia lo strumento per disegnare o dipingere, o la finestra di un certo tipo, il tal capo di vestiario, l’uso della modella, i comportamenti non solo degli artisti ma anche dei modelli, dei visitatori, della differenza tra uomini e donne, del nudo, dello specchio, del cavalletto, e la loro sparizione, gli studi pieni e quelli vuoti, le mode, le necessità.
La storia dell’atelier dell’artista è un vero specchio della storia stessa, appunto della storia della cultura – credo che intenda questo il sottotitolo –, i suoi sviluppi la rispecchiano: dall’atelier dell’artista artigiano alla bottega, dallo scriptorium ai laboratorio delle arti applicate, dallo studio dell’artista protagonista a quello dell’artista isolato, dall’atelier allestito per le visite e fin per lo spettacolo all’atelier di notte, a quello all’aperto, senza trascurare l’atelier delle artiste donne, dallo studio pieno di ogni cosa a quello più minimalista, dallo studio negli spazi ex industriali allo studio più concentrato, fino allo “studio opera” – per la verità Hall non arriva a chiamarlo così – da quello di Brancusi a quello di Kiefer. Il libro è illustrato benissimo, con immagini che da sole sono spesso delle scoperte.
Hall è il tipo di storico appunto che dà ad intendere di non trascurare niente e di sapere tutto. È un “archivio”, pieno di informazioni e anche di aneddoti. Il fatto è che quello che manca, che Hall sembra addirittura aborrire, sono le “idee”. Hall si limita strettamente ai fatti, al dato, e le idee non ne fanno parte, né quelle degli autori di cui parla, né le sue: se ne guarda bene dall’esprimerne una qualsiasi. È un vero storico e basta, non si lascia fuorviare da azzardi, deduzioni, commenti. Tutt’al più, poiché sa di star facendo un lavoro di divulgazione, vuole essere anche leggero, leggibile, e spiritoso – humour inglese naturalmente.
Allora non raramente conclude dei paragrafi o momenti di passaggio con delle battute, soprattutto come collegamento con il contemporaneo. Alla fine di un perfetto excursus su velocità e lentezza, ovvero sul senso del tempo nell’esecuzione: “La slow art ‘non commerciale’, in cui l’artista conosce piuttosto bene il soggetto, spesso viene venduta a prezzi stratosferici. La lentezza è diventata un marchio” (p. 78). “Il suo [di Whistler] unico lusso – a parte i vestiti da dandy – era la preziosa collezione di porcellana orientale bianca e blu. Quindi non gli sarà mancato un vaso da notte” (p. 213). “I ritratti femminili di Brancusi sono proprio fiale di energia sessuale sublimata: sembrano dei sex toys” (p. 220). Ma perché?! Anzi, non troppo stranamente le battute aumentano quando si tratta del contemporaneo stesso, non senza semplificazioni ingiuste se non addirittura scorrette. Per esempio, parlando del Bauhaus scrive: “Al termine del 1922 Itten, più interessato alla propria realizzazione che ai prodotti finiti, diede le dimissioni”. Non mi pare che sia andata così, che sia stato quello il motivo. (Penso sempre in questi casi: Se io che conosco abbastanza bene la storia dell’arte contemporanea noto questi pasticci, specialisti di altri periodi ne noteranno nel loro ambito? Speriamo di no, comunque sono i limiti dell’erudizione, e dello humour inglese.) D’altro canto altre aprono delle prospettive curiose a cui un contemporaneista non penserebbe. Per esempio: “È più facile capire Warhol se lo si considera più un incisore come Rembrandt, che creava multipli in molti stati diversi, che come un pittore. Tuttavia Rembrandt non lavorava sul pavimento e non aveva un Malanga”.
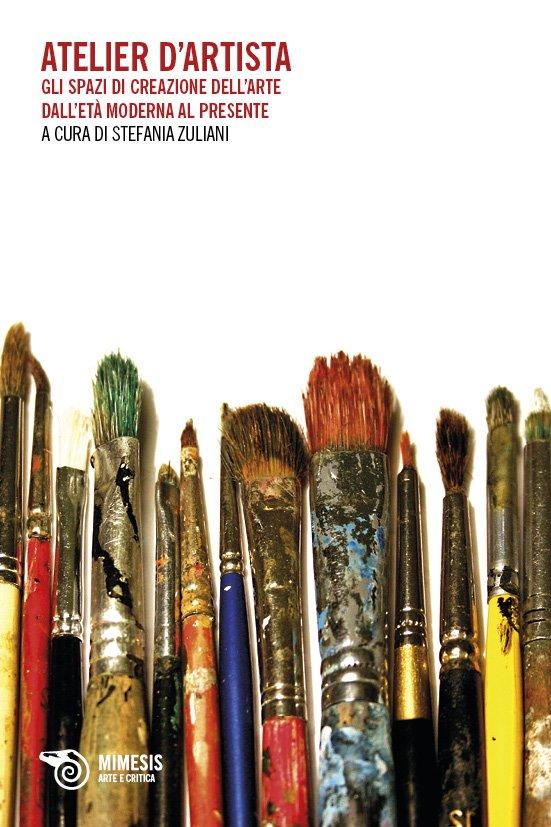
Quello che manca in questo libro consiglio allora di cercarlo in Atelier d’artista, curato anni fa da Stefania Zuliani (Mimesis 2013). Il volume nasce da un seminario dell’Università di Salerno e copre un arco temporale meno vasto del libro di Hall, quello della modernità e contemporaneità, dal XVI secolo al presente. Anche qui si parla naturalmente di maestri e botteghe del Rinascimento (Donato Salvatore), di dimore d’artista nel Seicento (Loredana Lorizzo), di origini dell’insegnamento (Mario Alberto Pavone, Simona Carotenuto), delle dislocazioni centro/periferia (Manuela D’Angelo), della casa d’artista (Antonella Trotta) per poi entrare nel contemporaneo (Angelo Trimarco) con casi studio come l’Omega Workshop (Salvatore Bizzarro), Mondrian (Rossana Fusco), Giacometti e Morandi nelle fotografie di Brassaï e Ghirri (Massimo Maiorino), Richter (Maria Passaro), Pistoletto (Maria De Vivo), Group Material e K.O.S. (Maria Giovanna Mancini).
Una raccolta ricca, come si vede, ma soprattutto ben coordinata dalla curatrice la quale imposta la questione, nella Premessa, nella giusta maniera: “Spazio di vita e di creazione, archivio denso di materie e di pensiero, laboratorio ed esclusiva vetrina ma anche luogo segreto di intimità privilegiate e di serrate contrattazioni, l’atelier è da sempre figura cruciale”, affermazione, a me pare, che in realtà viene significativamente dall’oggi, non “da sempre”, e questo ne dà il senso. Così il suo, di Zuliani, intervento specifico è incentrato nientemeno che sul “post studio”, sulle ultime trasformazioni dell’atelier in un mondo di “produzione ed esposizione nel Global Art World”. Non è per fare i “contemporaneisti” a tutti i costi o addirittura gli “attualisti”, ma è sicuro che un conto è porsi rispetto alle questioni da questa prospettiva retrovisiva e un altro da quello di un’idea di storia che finisce sempre con il suggerire che una volta sì che le cose erano migliori e in realtà c’era già tutto e non c’è niente di nuovo. Significa, per esempio, intendere l’atelier non come un luogo ma come un “dispositivo” o come un “testo, rivelatore, a suo modo, quanto le opere”, secondo la citazione da Brian O’ Doherty posta opportunamente in quarta di copertina; significa interpretarlo e non solo descriverlo e raccontarlo, ovvero davvero, a me, pare farne un oggetto “culturale” in un’idea di cultura che mette in gioco cultura materiale ma anche storia delle idee e perfino delle intenzioni e degli slanci. Gli atelier sono cambiati come l’arte e la cultura contemporanea – contemporanea agli atelier di cui si sta parlando, in questo caso, ma che è solo un modo di dire per ribadire che “siamo sempre stati contemporanei”. Lo sono anche gli storici, lo so, e il mondo è bello perché è vario, ne sono pienamente convinto.
Aggiungo un’ultima osservazione: in fondo, come per gli album per bambini con cui ho iniziato, anche qui è interessante notare la scelta degli “esempi” selezionati, a sua volta indicativa sia dell’impostazione dei due libri, sia di come sono cambiate le attenzioni negli ultimi anni-decenni. Come immaginate l’atelier di un artista “concettuale”? Ricordate le opere “minimaliste” che assomigliano a mobili? E gli artisti tedeschi che trasformano il loro studio in labirinti, in luoghi espositivi sui generis, o propriamente in “opera” essi stessi, come abbiamo visto in più di una Biennale di Venezia passata? Voi quali scegliereste?







