Speciale
Altri fiumi d'Italia
Il fiume era esile e chiaro
è diventato enorme e fugge
come un animale ferito
Così Lalla Romano (Demonte, 1906 – Milano, 2001), più di cinquant’anni fa, e come sempre in modo magistrale.
Tutti hanno letto I fiumi di Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto, 1888 – Milano, 1970): la poesia de Il porto sepolto (1916) in cui il soldato che si tiene “a quest’albero / mutilato / abbandonato in questa dolina / che ha il languore di un circo / prima o dopo lo spettacolo” guarda “il passaggio quieto / delle nuvole sulla luna” e ricorda che quella mattina si è “disteso / in un’urna d’acqua”:
L’Isonzo scorrendo
mi levigava
come un suo sasso
Ho tirato su
le mie quattr’ossa
e me ne sono andato
come un acrobata
sull’acqua
Mi sono accoccolato
vicino ai miei panni
sudici di guerra
e come un beduino
mi sono chinato a ricevere
il sole
Questo è l’Isonzo
e qui meglio
mi sono riconosciuto
una docile fibra
dell’universo
Il mio supplizio
è quando
non mi credo
in armonia
Ma quelle occulte
mani
che m’intridono
mi regalano
la rara
felicità
Ho ripassato
le epoche
della mia vita
Questi sono
i miei fiumi
Questo è il Serchio
al quale hanno attinto
duemil’anni forse
di gente mia campagnola
e mio padre e mia madre
Questo è il Nilo
che mi ha visto
nascere e crescere
e ardere d’inconsapevolezza
nelle estese pianure
Questa è la Senna
e in quel torbido
mi sono rimescolato
e mi sono conosciuto
Questi sono i miei fiumi
contati nell’Isonzo
Questa è la mia nostalgia
che in ognuno
mi traspare
ora ch’è notte
che la mia vita mi pare
una corolla
di tenebre
Cotici, il 16 agosto 1916

Quanti fiumi si contano nel Po, nell’Arno, nel Tevere, nei nostri botri o i disseccati / ruscelli pirenaici di Montale, oppure nell’Ofanto di Orazio e di Raffaele Nigro? Cosa può significare anche il più piccolo corso d’acqua, per sé stesso, per il pianeta, per ciascuno di noi? Per Umberto Saba (Trieste 1883 – Gorizia, 1957), più di cent’anni fa, è stata la scoperta di un fratello (Trieste e una donna, 1910-12):
IL TORRENTE
Tu così avventuroso nel mio mito,
così povero sei fra le tue sponde.
Non hai, ch’io veda, margine fiorito.
Dove ristagni scopri cose immonde.
Pur, se ti guardo, il cor d’ansia mi stringi,
o torrentello.
Tutto il tuo corso è quello
del mio pensiero, che tu risospingi
alle origini, a tutto il forte e il bello
che in te ammiravo; e se ripenso i grossi
fiumi, l’incontro con l’avverso mare,
quest’acqua onde tu appena i piedi arrossi
nudi a una lavandaia,
la più pericolosa e la più gaia,
con isole e cascate, ancor m’appare;
e il poggio da cui scendi è una montagna.
Sulla tua sponda lastricata l’erba
cresceva, e cresce nel ricordo sempre;
sempre è d’intorno a te sabato sera;
sempre ad un bimbo la sua madre austera
rammenta che quest’acqua è fuggitiva,
che non ritrova più la sua sorgente,
né la sua riva; sempre l’ancor bella
donna si attrista, e cerca la sua mano
il fanciulletto, che ascoltò uno strano
confronto tra la vita nostra e quella
della corrente.
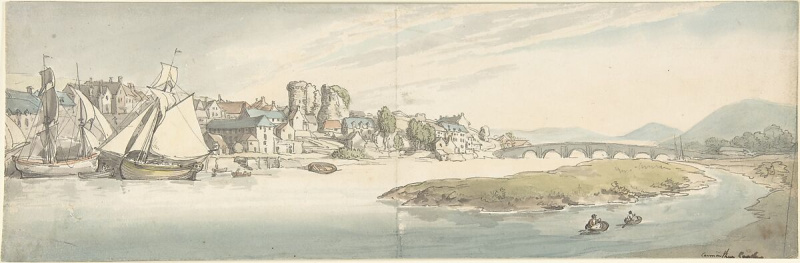
Ma un fiume non è solo un mito personale; è anche un grande generatore di vita, un ambiente primario ricchissimo, la condizione necessaria perché molto altro esista. Così il Piave – “Sacro alla Patria” – di Giovanni Comisso (Treviso, 1895 – 1969), per esempio, se osservato con pazienza e amore:
“La landa del Piave interrotta dai corsi limpidissimi delle acque à una sua vita estiva, che solo si scopre persistendo per giorni dall’alba al tramonto. Crescono tra le isole ghiaiose cespugli di salice che all’improvviso formarsi dei temporali ondeggiano cinerei al vento e in queste isole spuntano capanni di frasche dove uomini seminudi sbucciano i virgulti dei salici che tramutano in cesti. Altri uomini lenti cercano tra le distese di sassi verdastri, rossastri, ferrosi, marmorei quelli bianchi di calce da portare alle fornaci. Si ode nel silenzio il tocco del sasso scelto e gettato sul mucchio, che poi il carro col suo stridere delle ruote passerà a raccogliere indicando prossimo il tramonto. Qualche vecchio vagante con un sacco sulle spalle guada cauto le acque e raccoglie lungo le rive sabbiose i pezzi di legno levigati nel lungo rotolare dalle lontane valli del Cadore o pezzi di ferro che la guerra combattuta tra queste sponde à disseminato. Sono elmetti foracchiati, lamiere divelte dagli appostamenti, borracce e schegge di granata. Inesauribile giacimento perché, sepolto dalle sabbie, riaffiora e si risommerge secondo il corso mutevole delle acque, talvolta assieme alle ossa disseminate dei combattenti uccisi.
Nell’alta ora meridiana gridano gioiosi i ragazzi che si slanciano al nuoto e i neri corvi si elevano dai cespugli in volo pesante verso le isole deserte. Dalle tane nascoste fuggono le lepri come rimbalzanti palle di velluto verso altri luoghi dove il silenzio si compone col tremolio del calore cocente sassi e sabbie. Ma non crescono solo i salici tra le isole, le acque portano semi e radici di tutte le piante delle valli da cui scendono: i tamerici, i noccioli, i pinastri, i platani, il muschio, il rovo, le fragole, i lamponi, i roseti selvatici, i garofolini di montagna, le felci che in questo nuovo clima, a giorni simile a quello dei deserti equatoriali e in altri rappreso mite, si trasformano diversi. Vi sono piante di ombrellifere che sorgono legnose negli stocchi come arbusti e genziane azzurre grandi come gigli. I sassi comprimono le radici penetranti verso l’umore latente e ogni branchia, se si scopre dal suolo, appare appiattita come un nastro. La gramigna forma talvolta lunghissime trame di radici, nitide come d’avorio, serpeggianti fuori dalle sabbie verso la solitaria sorgente, dove sull’umida arena sono segnate le impronte delle zampe degli uccelli andati a dissetarsi. Altre piante tramutano i loro fiori rosei in bioccoli setosi di semente che questi stessi uccelli sostituiscono al proprio piumaggio nella costruzione del nido.
Piccoli ragni si nascondono al centro di brevi imbuti di sabbia, formati da loro, invece di stendere la rete, dove insidiano le formiche, scese dentro, che non riescono più a salire tra gli sdrucciolevoli granellini. I ragni, le formiche, le mosche sono i soli insetti, qualche rara farfalla passa al tempo dei fiori. [...] Appena si affondano i piedi nelle acque chiare, fuori dall’impeto della corrente, piccoli pesci del colore dei sassi accorrono attratti dal biancheggiare delle dita, osservano e si scagliano come frecce a sbocconcellare ingenui, ma se si getta uno sputo subito si affollano all’esca galleggiante portandosi via le bolle d’aria che sanno della nostra bocca, simili a ragazzini giocanti con un palloncino. [...]
Non si guarda più dentro le acque, la prima freschezza dell’aria avverte che il sole si avvicina al Grappa per scomparire dietro. La luce rasenta i castagni del Monfenera. Splendono i pendii erbosi interposti. L’Endimione arso accoglie il roseo dell’ultimo sole che nella stretta di Quero si taglia a raggere. Il cercatore di legna e di pezzi di ferro passa a guado l’ultimo filone d’acqua curvo sotto il sacco. I carri dei cercatori di sassi stridono sulle ghiaie. I raccoglitori di virgulti ne portano a casa i fasci sbucciati. E i ragazzi che sono stati al nuoto iniziano su uno spiazzo sabbioso il giuoco del tamburello. Risuonano i tonfi secchi della palla lanciata e ributtata come scoppi di fucile che ancora trattengono le lepri dal ritornare alle loro tane e la palla alta o bassa traccia fulminei archi sul paesaggio dei colli e dei monti, accresciuti d’ombra, e giuoca nell’aria come una morta pupilla.”

Sotto il segno dell’acqua si può esistere, lavorare, amare e anche nascere e morire, come racconta Massimo Bontempelli (Como, 1978 – Roma, 1960) intorno alla metà del secolo scorso:
“Madina era nata sotto il segno dell’acqua. Sua madre ancora la portava in seno quando la cacciò di casa una inondazione, corse molte ore di notte in mezzo a gente impazzita. Di mano in mano intorno a lei la gente cadeva esausta, ma la donna continuava a trascinarsi, inciampava, si rialzava, fin che si trovò sola. Non sentiva più urlare. Avvertì il rombo remoto del fiume che aveva rotto la diga e travolto i campi e le case. Con l’alba si trovò in un breve spazio deserto ai piedi d’una roccia: non c’era un segno di vita sopra la terra, anche dall’aria ogni creatura vivente era scomparsa; durava ancora lontanissimo quel rombo, ma forse non era che una eco rimasta in lei della paurosa notte. Il ventre le pesava orribilmente. Ora sentì vicino un piccolo canto frantumato e limpido, vide che dall’alto della roccia balzava uno zampillo, scendeva diritto, pareva d’argento, il primo raggio del sole venne a rifrangersi in quello suscitando un barbàglio. Presso la pozza che il getto aveva scavata nel terriccio, la donna s’accasciò sull’erba e svenne.
La svegliò un dolore acutissimo. Quando fu passato, sgomenta si guardò intorno. Il sole la accecava, ma come ella tentava di voltarsi, un’altra fitta più straziante l’inchiodò, le strappò il grido orrendo: udendolo si spaventò. Una vampa le avvolse il capo. La donna riuscì a chinarlo da un lato e gli spruzzi dello zampillo le arrivavano sul viso e le dettero un breve refrigerio; un nuovo spasimo più dal profondo parve squarciarla.
In questo modo era nata Madina sotto il segno dell’acqua terribile e dell’acqua innocente.
Quando il sole fu a picco sulla radura, un boscaiolo passando trovò la donna morta e la creatura che brancolava in mezzo al sangue. Andò a chiamar gente, le trasportarono a una casa al principio d’un gran bosco. La donna fu seppellita, la bambina rimase coi boscaioli.
Vi rimase per quindici anni”.

Oppure un fiume può prestarsi a un gioco ancora più azzardato, in cui lo scorrere e il suo contrario sono ugualmente possibili, come il reale e l’irreale, ciò che è esistito e ciò che no. Lo ricorda Mario Luzi (Castello di Sesto Fiorentino, 1914 – Firenze, 2005):
Il fiume fermo nella sua pelle luminosa
aggricciata dal controvento, un’ultima
ritrosia del fiume poco prima dei ponti –
chi sa come mi lascia il suo silenzio
all’interno balenio di quel ricordo
d’una sosta d’altri tempi, e in esso
sfolgora la città disfatta in acqua,
ne brucia di felicità la mente quasi possano
un attimo, uno solo
accaduto e inaccaduto rifondersi,
finché insensibilmente non c’è altro,
quel fuoco, quell’acqua, quegli elementi.
Qui Firenze “sfolgora [...] disfatta in acqua” perché è un puro riflesso, tremolante nell’Arno; ma è successo anche, purtroppo, che quella e molte altre città siano state davvero disfatte dalle acque, durante le alluvioni, perché un fiume, un torrente o un canale può significare anche annientamento e distruzione. Da sempre, anche da prima che se ne conservasse memoria scritta, e ovunque sulla terra, l’uomo ha cercato di governarli: deviandone il corso, alzando nuovi argini, costruendo navigli, rogge, fossi, scolmi, bacini, progettando imponenti opere d’ingegneria idraulica, prosciugando le terre troppo intrise d’acqua, paludose e malsane. A volte sbagliando, a volte no. Mario Tobino(Viareggio, 1910 – Agrigento, 1991) ripercorre la storia della sua città natale:
“Eccole lì, le cataratte, un gioco di bambino povero, una favola che salvò Viareggio, la fece sana, ubertosa, popolata, estinse la malaria.
Alle spalle di Viareggio c’era il lago di Massaciuccoli, che comunicava col mare per mezzo del canale Burlamacca. Intorno al lago, per chilometri, si stendevano pozze, fosse, canaletti dai bordi fangosi. Sulla terra che affiorava si contorcevano arbusti, sterpi, alberi nani; da un lato si infittiva la selva. Era un luogo disabitato e selvaggio, una palude dove imperava la malaria; nel folto del bosco fiutava setoloso il cinghiale.
Sulla costa, i quattrocento viareggini vivevano circondati dall’acquitrino. [...]
Più volte si era sperato di disciplinare la palude, liberarla dalla malaria e avere così in Viareggio il proprio porto.
Per questo scopo si era creata la compagnia della Maona che aveva provato, tentato, consumato denari; perfino si era fatto venire dall’Olanda un ingegnere di sonante nome, il Raet di Bolduc in Brabante. Lavori ne erano stati fatti, si erano puliti i vecchi canali, scavati di nuovi, convogliate le acque verso il canale Burlamacca, quello che comunicava col mare. Ogni volta tutto era finito nella delusione, nella sfiducia. Nella palude continuava a regnare la febbre.
Finalmente nel 1740 l’Ufficio della Foce – che aveva sostituito la vecchia Maona – ebbe l’idea di chiamare il matematico Bernardino Zendrini della serenissima repubblica di Venezia.
Lo Zendrini arrivò, meditò sul luogo, tradusse in disegno le sue idee e ordinò le cataratte a bilico, quegli sportelli, quelle porte che si chiudono e aprono secondo il bisogno come nel loro interno si muovesse un gentile e diabolico folletto.
Il lago di Massaciuccoli, quando cascano le piogge, si gonfia, si alza di livello e tenta di scaricare nel mare la sua abbondanza per la via del canale Burlamacca.
Accade però che contemporaneamente il mare è agitato, gonfio d’ira, alte le onde, più alte del lago. E allora non solo le acque dolci non trovano sfocio, ma le salate si immettono prepotenti nel canale, sovrastano, si riversano nel lago, costretto ancora di più a gonfiarsi, già le sue fosse tutte cariche.
Infine succede fatale lo straripamento, le acque si versano in ogni tratto di terra, si creano altre pozze, nuovi stagni, anche nella fitta selva. Le zanzare avranno le migliori condizioni per moltiplicarsi.
Lo Zendrini foderò per diversi metri il canale Burlamacca in prossimità del mare; irrobustì di pietra e calce il fondo e le sponde. Lì infisse le due porte, le cataratte a bilico. [...]
Lo Zendrini non si limitò a questo, dette anche ordine di tagliare tutte le piante, mettere a nudo la terra, estirpare la selva, far chiaro, visibile, che ogni pozza e stagno fossero in luce in modo che tutto sicuramente scolasse nei fossi, i quali a loro volta si sarebbero versati nel canale Burlamacca. Questo nel mare.
Lo Zendrini inoltre raccomandò di prolungare le braccia del canale. Il mare aveva disposizione a ritirarsi, lasciando al suo posto la sabbia. Per contrastare la natura, i moli ogni anno dovevano spingersi verso il mare alto, fronteggiare l’avanzata della rena.
E lo Zendrini ripartì per la serenissima repubblica.
La terra fiorì, la malaria fu soffiata via. Viareggio cominciò a popolarsi.
Vi arrivarono gli inquieti, gli irrequieti, gli insoddisfatti, gli insofferenti di tutti i nuovi vicini. [...]
Un giorno ci venne anche mio padre; il luogo gli parve allegro di libertà e futuro. Si trasferì a Viareggio e ci rimase tutta la vita. [...]
Vennero dalle campagne lucchesi, molti da Massarosa, da paesini sparsi per i colli, per i monti, nelle valli, da Massa, qualcuno da Spezia e da più lontano. Non ebbero nostalgie per il passato”.

Nei fiumi sono scritti il passato, il presente e il futuro: le loro acque sono carte d’identità che mutano nel corso del tempo, insieme a noi. Il poeta Marco Munaro (Castelmassa, 1960), che vive tra l’Adige e il Po, lo testimonia in questo modo:
ADIGE (OVEST, EST, NORD, SUD)
Sono nato sulla riva sinistra del Po, ai piedi di un ponte in chiatte, ho lo sguardo della corrente, il sentire tenero e forte della Natura.
Vivo da anni sulla sponda destra dell’Adige, a pochi chilometri da quella favolosa dell’infanzia e dell’adolescenza, dove ho imparato a nuotare. L’acqua dei fiumi dei navigli dei canali dei fossi è entrata in me nel mio fluire e insabbiarmi, nella mia musica segreta e nei miei silenzi.
L’Adige era il fiume che raggiungevo da ragazzo andando a La Tureta, a San Pietro Polesine, verso Legnago e il Tartaro pieno di pescegatti e tinche, nelle grandi valli; o che attraversavo per andare alla casa dei nonni, dopo Badia: un paesaggio di altre valli e paludi nel movimento irrequieto del fiume che aveva lambito, un tempo, i Colli di Este: Villa d’Adige, Piacenza d’Adige, Arquà, case sorte su una delle sponde del fiume e dei suoi alvei, che avevano cambiato corso con le piene e le rotte. Prima del Mille, da una di quelle rotte, si era formato a sud il ramo del fiume che solcava e cingeva Rovigo, quando si apriva alla meraviglia incantata di chi vi arrivava in battello.
Vedo il groviglio delle acque separate, sento
il labirinto dei loro vasi comunicanti.
Dietro corre l’acqua gelida dell’Adige, nella sua corsa porta la memoria non del tutto cancellata della rupe, gli orti e i mulini scomparsi, la barca su cui sognavo di arrivare al mare. Ma a piedi vado verso Verona, sull’argine tagliato dall’autostrada. Il letto pensile del fiume scorre sotto il cuscino, le capre risalgono le rive erbose controcorrente mentre intorno infuria la guerra.
Il bosco nasconde e poi inghiotte la casa.

Nel romanzo Il piccolo naviglio di Antonio Tabucchi (Pisa, 1943 – Lisbona, 2012), uscito nel 1978 con l’avallo di Vittorio Sereni, il protagonista Sesto Degli Angeli ha un fiuto speciale per l’acqua. A un certo punto, Sesto comincia a scrivere “brevi poesie intense e indecifrabili, vergate con una calligrafia minuscola su fogli di quaderno, dalle quali ricavava poi leggeri aeroplani di carta che faceva planare sull’Arno dai ponti di Firenze. [...] Ma un giorno che Sesto, con la sua bicicletta per mano, attraversava un ponte sull’Arno, frugandosi in tasca si accorse che non aveva aeroplani di carta da buttare nel fiume. Era il giorno di un mese estivo, con una luce sfavillante come c’è d’estate a Firenze; Sesto appoggiò la bicicletta al marciapiede, appoggiò il mento alle braccia incrociate sulla balaustra e si mise a guardare l’acqua del fiume. L’acqua dei fiumi ha sempre avuto suggerimenti per i filosofi che la osservano; e anche se Sesto non era un filosofo, ma un correttore di bozze momentaneamente rimasto senza poesie, l’acqua del fiume ebbe suggerimenti anche per lui. Perché l’acqua scorreva tranquilla e andava solo in un verso. «Perché non va mai in senso opposto?», si chiese Sesto Degli Angeli; e da questa domanda il silenzioso Sesto, correttore di bozze e poeta senza poesia, cominciò a pensare al tempo che scorreva: e all’universo che in esso scorreva, e al mondo che su di esso scorreva, e in esso a un piccolo, minuscolo, insignificante granello chiomato di rosso appoggiato col mento a una balaustra di marmo, che scorreva anch’egli. E all’improvviso il mondo che fino allora era stato fermo accanto a lui si scatenò e si mise a scorrere. Come quando l’udito si libera in una discesa, le orecchie di Sesto si stapparono ed egli cominciò a sentire il brusio del mondo che scorreva. Sentiva la voce interna delle cose: e in mezzo al flusso delle cose vedeva se stesso, col mento appoggiato a una balaustra di pietra, accanto alla sua bicicletta dal sellino di cuoio, che scorreva. E capì anche all’improvviso, con un senso di panico e di meraviglia come si addice a un poeta senza poesia, di essere il punto di un tempo in progressione, risultato e inizio, addendo e somma; ed ebbe voglia di allungare la mano verso il fiume delle cose per pescarsi, per afferrare il piccolo naviglio detto Sesto Degli Angeli: tenersi sul palmo della mano, guardarsi, decifrarsi, dare un senso al suo scorrere, determinare la rotta da seguire nel grande fiume dello scorrimento”.
Tutto scorre e tutto è, dunque, in modo simultaneo? Anche noi che leggiamo, o scriviamo? Per Sesto Degli Angeli, forse sì. Ma per l’occhio di Tonino Guerra (Sant’Arcangelo di Romagna, 1920 – 2012) un fiume è anche un albero d’acqua:
L’ÈLBAR D’AQUA
S’e’ va un’isteda chèlda
ch’la póiga al fòi a testa d’inzò,
e’ Marèccia l’è un èlbar d’aqua
si rèm ch’i sguélla tra la sasèra.
U n’éva tórt e’ poeta se da d’in èlt
u i pareva che dróinta la vala
u i fóss agli òsi biènchi d’animèli mórt.
(L’ALBERO DELL’ACQUA. Se va un’estate calda / che piega le foglie a testa in giù, / il Marecchia è un albero d’acqua / coi rami che scivolano tra la sassaia. / Non aveva torto il poeta / se gli pareva che dentro la valle / ci fossero gli ossi d’animali morti).

E per Lalla Romano, riattingendo alla polla iniziale di questo fluire, felicemente:
Nessuno può derubarci della gioia
la nostra gioia sotterranea
come tenera acqua
come vena di roccia
Fonti:
L. Romano, I flauti acerbi, in Giovane è il tempo, Einaudi, Torino 1974, p. 11;
G. Comisso, Gente del Piave, in Veneto felice. Itinerari e racconti, a cura di N. Naldini, Longanesi, Milano 1984, pp. 223-5;
M. Bontempelli, L’acqua, in L’amante fedele, Mondadori, Milano 1968 (ma 1953), pp. 183-4;
M. Luzi, Tutte le poesie. 2 – Nell’opera del mondo, Garzanti, Milano 1979, p. 216;
M. Tobino, Sia benedetto lo Zendrini, in Sulla spiaggia e di là dal molo, Mondadori, Milano 1978 (ma 1966), pp. 27-9;
M. Munaro, Ruggine e oro, Il Ponte del Sale, Rovigo 2020, p. 27;
A. Tabucchi, Il piccolo naviglio, Feltrinelli, Milano 2011 (ma 1978), pp. 158-60;
T. Guerra, L’albero dell’acqua (dedicato soprattutto a Ezra Pound), Libri Scheiwiller, Milano 1992, pp. 32-3;
L. Romano, Il caro odore del corpo, in Giovane è il tempo, cit., p. 25.
Leggi anche:
Stefano Strazzabosco | Venezia e la sua laguna
Stefano Strazzabosco | Trieste, l’Istria, la laguna di Grado
Stefano Strazzabosco | Il delta del Po
Stefano Strazzabosco | Vicenza e i suoi fiumi







