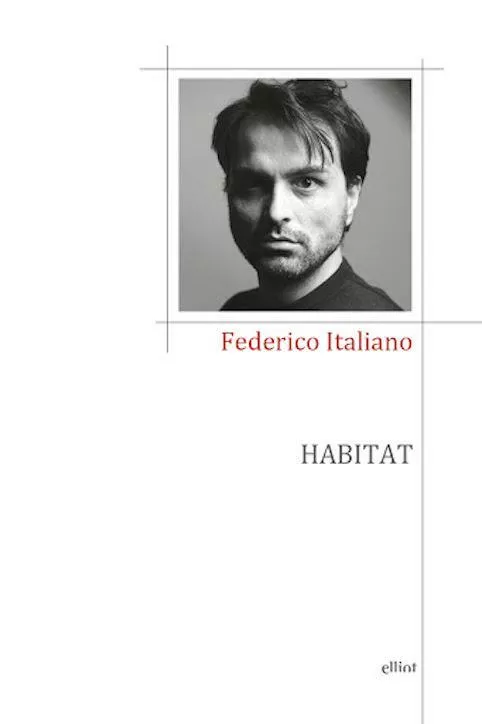Poesia / Nanni Cagnone e Federico Italiano: due generazioni
Due autori, due generazioni diverse. Nanni Cagnone è del 1939 e ha debuttato nel 1954 come autore; è stato redattore di una delle riviste da cui nasce la neoavanguardia la genovese “Marcatré” di Eugenio Battisti; la sua è una lunga carriera di saggista e narratore. Federico Italiano è del 1976; ha vissuto a lungo nell’area di lingua tedesca; saggista, narratore, traduttore e poeta, ha esordito nel 2003 come poeta e appartiene alla nuova leva dei poeti in lingua italiana. Entrambi sono nutriti da letture filosofiche e da un’attenzione alla cultura non strettamente italiana. Un accostamento che li mette a confronto nella giusta distanza di una differente esperienza generazionale, ma li avvicina per una devozione poetica comune.
Nanni Cagnone, A ritroso. 2020-1975, nottetempo.
In A ritroso. 2020-1975 Nanni Cagnone selezione e raccoglie (talvolta con qualche variante rispetto alle precedenti stesure) testi appartenenti a molte delle sue precedenti opere, escludendo dalla scelta alcuni dei libri nati in forma di poema, quindi più organici e perciò difficilmente antologizzabili. Difficile dire se questo “autoritratto per lampeggiamenti”, come bene lo definisce la scheda dell’editore, sia un bilancio o semplicemente una forma di un “canzoniere” che, per essere tuttora in progress, non può che essere felicemente provvisoria, come il pensiero che lo anima.
E tuttavia, per la sua stessa natura di scelta diacronica d’autore, A ritroso ci restituisce quelli che l’autore stesso ritiene siano, oggi, i lineamenti di un autoritratto plausibile, e al tempo stesso un diagramma delle linee di forza e delle costanti oggi avvertite come più vitali nel suo itinerario creativo.
Sembra perciò significativo che la scelta delle poesie si concluda con la riproposizione anche dei Cattivi consigli, un testo molto importante di autoriflessione sul fare e sul farsi della propria poesia, dall’andamento sapienziale e spiazzante, come i testi buddisti del Canone P¯ali esplicitamente richiamato dall’autore.
E quindi, è giusto che il lettore si ponga alla ricerca dei lineamenti dell’autoritratto o delle linee del diagramma. Con l’avvertenza che una poesia come quella di Cagnone, raffinatamente elusiva, intellettualmente impegnativa e qualche volta sfuggente, richiede la capacità di formulare ipotesi interpretative che non potranno mai essere “parole d’ordine” o sintesi schematiche, bensì un aderire a un “pensiero in poesia” continuamente variabile (Cattivi consigli: «Non si tratta di mettere in versi pensieri precedenti, ma di trovare un pensiero ‘in poesia’.»)
Il più evidente campo di forza che caratterizza la poesia di Cagnone è proprio quello della relazione problematica tra realtà e lingua, tra “cose” e parole (Cattivi consigli: «Poesia è questo intervallo tra noi e le cose. Potremo mai riunirci?»; «Né esperienza del mondo né esperienza del linguaggio preesistono alla loro relazione. Allora, perché il sentore d’un reciproco abbandono?»).
“Lingua” e “parole” sono termini che ricorrono spesso nelle poesie della raccolta, anche se tra i due termini rivelano nell’uso una differenza (e vedremo quale).
La lingua può essere “ariosamente al di sopra” (p. 11); alla lingua certe cose non si devono porre («cose che non si deve /porre alla lingua. senso / per somiglianza incustodito», p.12); la lingua può essere “scalmata” (ovvero inquieta) (p. 35); la “lingua del presente” è “forma che manca / dopo tutte le forme” (p. 65); può infine essere “rivale” ma al tempo stesso “sposa”, come si dice in uno dei testi (p.81) che vale la pena riportare:
Non so d’un urto
che trattenga.
So di molto cadere,
e falso abitare
dove il ciglio;
più facile l’abisso,
fossa comune
di sprofondati cieli.
Qui
addolorato sànguine,
sollecito colpire
o screziate stoffe
deposte sopra stracci.
E lingua rivale
avuta come sposa.
È significativo che in alcuni testi la “lingua” – facoltà, potenzialità, possibilità sollecitata di dire/fare/pensare – si trovi associata a contesti di movimento (il “molto cadere” nel testo sopra riportato, il salire e scendere: «Sale e diventa / scende e diventa, / si oscura. / È questa la forza / che volle lentamente / non agire? / Lingua del presente, / forma che manca / dopo tutte le forme.», p. 65).
Alle “parole”, che della lingua sarebbero la traduzione in atto, spetta la confidenzialità che si accorda alle cose di tutti i giorni: possono essere “segrete” (p. 55), “fedeli” e “astruse” (p.62), “dolenti [e] stridule” (p.94), “amorose” (p. 99), “acerbe” (p. 157); possono avere “debolezze” e abitare “nella culla di un silenzio” (p. 129); possono essere “nutrite” (p. 119) e anche inevitabilmente degradarsi, nel tentativo di colmare lo iato tra le “cose” e il “desiderio delle cose”: diventare “balbettìo” (p. 88), “abiti in guardaroba” (p. 69) e perfino “stracci” (p. 69 e p. 155).
Un altro elemento che è possibile cogliere diacronicamente nella raccolta è l’evoluzione della forma. I testi più lontani nel tempo sono anche i più espressionisticamente caricati (p. 10: “madornale fruscìo”, p. 11: “curvi paraggi”, p.12: “enorme compimento”, p. 24: “armi … lontanate”) e i più “oscuri”, come segnalavano G. Ridinger e G.P. Renello che – alle prese con il difficile compito di tradurre questo autore in inglese – («Italian Poetry», 1996) parlavano di testi “misteriously open-ended”, anche per via di “anacolutha and ambiguous shift in references”. Dal punto di vista sintattico, ciò vuol dire, per esempio, l’ellissi del verbo («Non in queste parole / ma nelle nascite seguenti.», p. 38) o subordinate che giudicano superflua la frase principale («Ma il puntiglio del fiore / stanco di floridezza / quando scende / stretto a tutte le età.», p. 28) un uso molto libero e fluido del gerundio, il modo verbale che non esige né la persona né un’assoluta precisione dei rapporti temporali.
Caratteristiche che in effetti si attenuano via via, per giungere (secondo una strada comune a molti autori formatisi negli anni dello sperimentalismo) a una tonalità meditativa e “contemplante”. In Cattivi consigli si legge: «A volte, ho nostalgia d’una poesia più semplice. Mi piacerebbe dire senza pretendere. Mi piacerebbe mostrare – dentro il mostrare c’è tutto.» (p.171).
Un’aspirazione a cui Cagnone ha voluto tener fede. Nei testi più recenti (e spesso bellissimi) il pensiero-poesia rinuncia, o quasi, alle forzature semantiche, ai cortocircuiti sintattici e si dispone a seguire il grande flusso dell’esistenza, i piccoli-grandi spettacoli delle piante, degli animali, dell’acqua e del cielo, sempre interrogandosi sul posto che ci tocca occupare in questo continuo scorrere delle cose, che è uno scorrere silenzioso, perché prima, senza (o al di là) del linguaggio:
Ignoro se – qualora
aridi – i torrenti
attendano colmarsi;
coscienti del ritmo
di pienezza e povertà,
non dubiteranno
delle ripide acque
avvenire, che ora
non si mostrano.
Diversamente da noi
non hanno sorgente,
non devono tornarvi,
come noi, dal mare.
Ma,
qual alveo di torrente,
pazientemente
si consuma l’origine. (p.168)

Federico Italiano, Habitat, Elliot 2020
Se nella poesia italiana ci sono davvero due linee, una plurilingue e aperta agli oggetti, e una “petrarchesca”, fatta di una accurata selezione di “sostantivi generali” (Contini) e rarefatti, in cui un usignolo sarebbe ammesso al “Jockey club lessicale” (sempre Contini) ma non una rondine (a meno di non chiamarla “Progne”), di certo Federico Italiano non appartiene a quest’ultima. E se lo stesso Petrarca poteva scrivere quasi due quartine fatte tutte di nomi di fiumi e piante («Non Tesin, Po, Varo, Arno, Adige et Tebro, / Eufrate, Tigre, Nilo, Hermo, Indo et Gange, / Tana, Histro, Alpheo, Garona, e ’l mar che frange, / Rodano, Hibero, Ren, Sena, Albia, Era, Hebro; // non edra, abete, pin, faggio, o genebro, / poria ’l foco allentar che ’l cor tristo ange, / quant’un bel rio ch’ad ognor meco piange, / co l’arboscel che ’n rime orno et celebro.»), è solo perché alla fine quelle precise piante e quei precisi fiumi li scarta tutti, e ritorna al solo “bel rio” e al solo “arboscel” che gli interessa, e in verità nemmeno in quanto “arboscel”, ma in quanto senhal di Laura.
A Federico Italiano invece, gli oggetti, accuratamente nominati, interessano tutti, e così anche geografie cartografie e mappe. Queste ultime, oggetto di alcuni suoi affascinanti studi di letteratura comparata, sono anche un frequente innesco della sua sorprendente poesia, perché una mappa – come ha scritto in un articolo di questa stessa rivista – «può generare connessioni imprevedibili, percorsi inaspettati e quindi storie e narrazioni» e anche «[è] lo strumento più prezioso per la più quotidiana delle nostre negoziazioni – quella tra l’essere dove siamo e lo spazio ulteriore».
Gli oggetti stessi si dispongono “cartograficamente” e diventano “presagio di avventure future” e anche, nella dimensione del tempo (chi non ha fatto questa medesima esperienza?), misteriosi revenant:
Non avevo paura delle case degli altri.
La porta semiaperta
di un bagno, la penombra
di un tinello, gli odori imprevedibili
di cucine in stand-by pomeridiano,
gli strapiombi di luce,
i tranelli dei vestiti dismessi,
o le sagome ambigue delle piante –
tutto si disponeva
cartograficamente nel presagio
di avventure future, tutto entrava
nella mappa dei tesori sepolti.
Non avevo paura delle case degli altri
da bambino, ma adesso
sono i loro fantasmi a farmi visita:
le ciabattine rosa,
che guadavano attente
le sconnesse distrazioni del gioco,
la curva parabolica
di una pista Polistil, nera
regolatrice di affetti e tensione
o il buio di un armadio,
nel fondo d’indumenti sconosciuti. (Le case degli altri, pp.11-12)
Questo legame tra geografie e oggetti e fra entrambi e “lo spazio ulteriore” delle persone, che è uno spazio in movimento, oscillante tra “futuri” da collaudare e ricordi, si coglie bene in quest’altra poesia:
A oriente, Monaco si raggomitola
alla destra dell’Isar,
si rannicchia ai piedi del Nockherberg,
l’ultima lingua di ghiaccio pleistocenico.
Proprio sotto a quel declivio alberato,
tra il nord meditabondo
della cucina e l’acquario radioso
della sala, collaudammo futuri,
in mezzo a libri, xilofoni
e alle carte del Memory.
Non era grande l’appartamento,
ma ti ci potevi perdere e riabbracciare. (Congedo da Monaco, I, p.21)
Non si può che consentire con quanto scrive Alessandro Mantovani (in La Balena Bianca) a proposito di questo libro: «Tramite tale dimensione “territoriale” (…) nei testi il presente convive con gli altri tempi; il qui, con l’altrove. Una convivenza contraddittoria eppure congruente. La possibilità di accedere ad una totalità geografica e temporale produce un principio di non-località in base al quale vengono demoliti i concetti di presente e di presenza. È possibile insomma introdursi in ogni tempo e ogni luogo grazie a una poesia che si fa “mappa”».
E possiamo aggiungere che le mappe – nella variante della guida, del baedeker con le sue tassonomie e nomenclature di bestiario – non sono soltanto meccanismi generativi di avventure e scoperte, ma anche garanzia di permanenza dei nostri stessi atti (di noi stessi): i nomina che restano quando il tempo contromano ci ha scavalcato:
Astore, nibbio, poiana o sparviero,
eccoli, tutti insieme,
nella guida agli uccelli della Foresta Nera,
che sfogliamo al tramonto,
di ritorno alla baita,
passandocela tra noi,
come fosse una bibbia,
quando ormai i boschi sono un episodio,
e si è persa ogni traccia
di sparvieri e poiane, dell’astore e del nibbio. (La guida agli uccelli della Foresta Nera I, p.31)
In poeti del passato, pure attratti dalle mappe e amanti dell’oggettivazione dei sentimenti, il flusso del cambiamento generava angoscia (Sereni si duole perché «Dovr[à] cambiare geografie e topografie.»; Baudelaire dice “hélas” se «Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville / Change plus vite, hélas! que le coeur d'un mortel)».)
Si direbbe invece che Italiano – generazionalmente forse abituato alla “liquidità” del mondo contemporaneo – accetti la situazione come ormai connaturata al nostro modo di stare al mondo.