Ismail Kadare e la magia della letteratura
Ismail Kadare non aveva paura del Grande Fratello. Perché lo scrittore albanese di Argirocastro poteva scatenare contro l’ottusità del Potere un incantesimo potente: quello legato al libero arbitrio, tutto umano, del fantasticare. Ed è proprio la magia della letteratura, la capacità di librarsi in volo oltre gli angusti confini della dittatura, la capacità di spezzare le catene del controllo inventando storie e metafore, che hanno fatto di lui una delle voci più originali, libere e complesse della narrativa europea.
Non aveva paura del Grande Fratello, Ismail Kadare, perché a differenza di George Orwell, che quella tenebrosa distopia l’aveva creata nel 1949, era costantemente “vissuto sotto il suo sguardo”, come ha scritto Claudio Magris. Anzi, si era spinto molto più in là: era entrato nelle stanze del dittatore. Si era soffermato a chiacchierare con Enver Hoxha, che aveva imprigionato l’Albania dentro uno dei modelli più claustrofobici e polizieschi della galassia comunista. Si era sentito rinfacciare la colpa di scrivere sempre romanzi “così tristi”, che non esaltavano le “magnifiche sorti e progressive” decantate dal regime.
Lui, insomma, per lunghi anni è stato accusato di non voler celebrare i risultati straordinari ottenuti da quello che per l’ottusa propaganda era dipinto come “l’eroico partito albanese”.

Kadare non si era piegato subito. Ma le censure e le umiliazioni, dopo il mellifluo e sgradevole faccia a faccia con Hoxha, erano andate aumentando. Fino a stringerlo dentro un cerchio sempre più stretto. Alla fine, lo scrittore si era dovuto inchinare a quel Piccolo Padre albanese, nato pure lui ad Argirocastro, sottoscrivendo un’umiliante autocritica. Come veniva richiesto anche agli intellettuali dei Paesi sotto il controllo sovietico.
Nel testo, quasi un’abiura, ammetteva di avere “scritto cose contrarie al bene del popolo”. E di essersi atteggiato come “un nemico del comunismo”. Da allora, gli zelanti e occhiuti sgherri di Hoxha avrebbero chiuso un occhio. Anzi, uno e mezzo. Perché lui, Kadare, non avrebbe mai smesso di sbeffeggiare il regime. Proiettando le sue storie in un tempo lontano. Quando ancora esisteva l’Impero Ottomano, come nel Palazzo dei sogni, tradotto da Liljana Cuka nel 2023 per La nave di Teseo. O come in un altro libro, Quando un dittatore chiama, l’ultimo suo romanzo tradotto da Cettina Caliò per La nave di Teseo, che lo distribuirà nelle librerie a ottobre. In cui racconta la telefonata intercorsa tra Josif Stalin e il romanziere Boris Pasternak nel 1934, per discutere dell’arresto del grande poeta Osip Mandel'štam. Che sarebbe poi morto nel gulag di Vtoraja rečka, vicino a Vladivostok, sul finire di dicembre del 1938.
Ma sta proprio lì, dentro la magia della letteratura, il segreto di uno scrittore come Ismail Kadare, morto a Tirana il primo luglio del 2024. Perché lui, già da ragazzo, aveva capito che il fantasticare, l’immaginare storie diverse da quelle che si vivono ogni giorno, poteva diventare il suo luogo segreto da cui osservare con sguardo lucido e impietoso le inquietanti contraddizioni di un mondo che inneggia alla libertà, mentre fa di tutto per esercitare un controllo spietato sulle persone.
Kadare era nato in una grande casa di Argirocastro il 28 gennaio del 1936. E non ha hai cercato di millantare un’adolescenza infelice. Anzi, al giornalista e scrittore Eric Faye aveva confessato in una lunga serie di interviste (poi raccolte nel volume Conversazioni con Kadare, Guanda 1991): “Tutte le storie secondo le quali l’origine della creatività è legata a un’infanzia infelice dello scrittore sono false. Si insiste molto sul fatto che un’infanzia infelice dia origine a della buona letteratura: forse è vero proprio il contrario. Sebbene la mia infanzia risalga a un periodo piuttosto turbinoso, io ricordo d’essere stato molto felice. C’erano, è vero, delle difficoltà, ma quel periodo della mia vita è stato pieno di colori, di curiosità, di imprevisti”.
Vedere aeroplani che solcavano i cieli, soldati stranieri che pattugliavano le strade dell’Albania, assistere ogni giorno a cambiamenti, era strano ed elettrizzante al tempo stesso. “Era la lotta. Per alcuni si trattava di un momento triste, per i bambini non lo era affatto”. E poi, come dimenticare quella grande casa in cui la famiglia abitava ad Argirocastro: “Era piena di misteri e di cose inspiegabili, d’angoscia. Era una casa di tre piani, e vivevamo d’inverno in uno e d’estate in un altro. Anche l’interno della casa subiva dei cambiamenti a seconda del mutare delle stagioni. C’erano grandi cantine buie che durante la guerra sono state trasformate in rifugio antiaereo. Una grande casa dà sempre una grande dimensione ai pensieri”.
Pensieri, quelli del bambino Kadare, che i primi libri letti catapultavano sull’autostrada della fantasia, facendo correre a perdifiato la sua voglia di sognare. A 11anni, infatti, Ismail si era imbattuto in una copia del Macbeth di William Shakespeare. Leggere quella storia avrebbe cambiato per sempre il suo sguardo sul mondo. “Perché l’ho letto? – si chiedeva molti anni dopo –. Scorrendo le prime pagine mi sono reso conto che il testo parlava di fantasmi, di streghe. Mi piacevano le cose misteriose, e così ho cominciato subito a leggerlo. Mi faceva soffrire, e tuttavia non avrei trovato la forza di staccarmi. Ne ho letto metà e mi è piaciuto molto. Dato che il libro non era mio, ho preso dei fogli e ho cominciato a copiarlo”.
Avere per amici immaginari Macbeth, e poi Don Chisciotte, il Conte di Montecristo ma anche Guglielmo Tell, i personaggi di L’Iliade, L’isola del tesoro, Le anime morte, non era poi così scontato. Facile immaginare che, esaltato dalla lettura di simili capolavori, il piccolo Ismail sentisse il desiderio di misurarsi pure lui con la scrittura. “Ho scritto il mio primo romanzo proprio allora, a 11 anni – raccontava a Eric Faye –. Conservo ancora il manoscritto. Ne ho accennato anche in un racconto, si intitola Il tempo dei primi scritti. Il periodo narrativo, però, non è durato molto. Perché poi ho scoperto la poesia”.
Sarebbe passato un bel po’ di tempo, prima che Kadare decidesse di ritornare alla narrativa. Finite le scuole superiori, si era laureato a Tirana alla facoltà di Storia e Filologia. Poi, a Mosca, aveva proseguito gli studi all’Istituto Gor’kij, in letteratura. Dopo due anni, però, era stato richiamato a casa a causa dei rapporti diplomatici sempre più difficili tra l’Unione Sovietica e l’Albania, accusata di essere molto più in sintonia con la Cina (dalla quale si sarebbe, comunque, allontanata tra il 1972 e il 1978). Crisi insanabile destinata a culminare in una clamorosa rottura tra i due Paesi comunisti, accompagnata da una reciproca e interminabile litania di scomuniche intercorse tra Mosca e Tirana.
Assunto come giornalista dalla rivista “Drita”, in seguito Kadare era stato incaricato della prestigiosa direzione di “Les Lettres Albanaises”, entrando a pieno titolo nell’ambiente degli scrittori del suo Paese.
Ma il grande amore per la letteratura non poteva restarsene a sonnecchiare ancora a lungo. E la poesia non gli bastava più. Così, sedici anni dopo il suo primo, adolescenziale tentativo di mettere assieme un romanzo, nel 1963 Kadare reclamava un posto in prima fila nella letteratura europea esordendo con Il generale dell’armata morta. Libro che l’Italia potrà leggere appena nel 1983, tradotto da Augusto Donaudy per Longanesi basandosi sull’edizione francese, non su quella originale in lingua albanese.
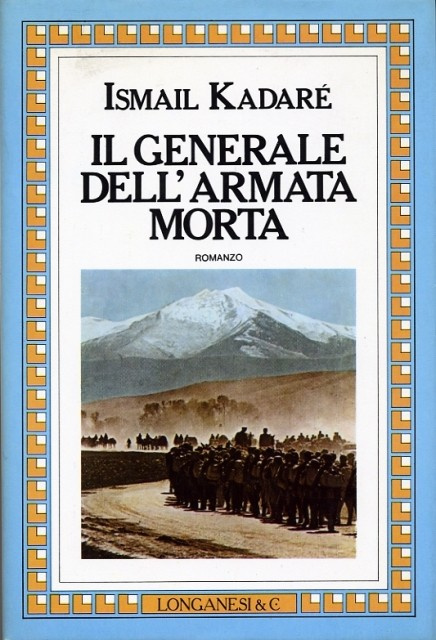
Strana distrazione, quella dell’editoria italiana nei confronti del Generale. Soprattutto perché il romanzo racconta la storia di un ufficiale dell’esercito italiano che, vent’anni dopo la fine della guerra, viene mandato in Albania con un compito molto delicato. Deve, infatti, andare alla ricerca dei resti dei nostri soldati morti in battaglia, per, poi, riportarli in patria. Ad accompagnarlo c’è un cappellano, a cui tocca soprattutto il compito di stabilire un contatto con una popolazione fredda e diffidente in un Paese dal clima sgradevole, dal paesaggio arcigno, schiacciato dal tallone di un Potere onnipresente. Dove, piano piano, emergerà l’enigma della sparizione dei resti del generale Z., un tipaccio che era a capo del famigerato Battaglione Azzurro, preposto alla repressione dei partigiani albanesi.
Da subito, i critici e i lettori avevano riscontrato nelle pagine di Kadare l’affascinante eco della tragedia greca, da lui amatissima, insieme alla dimensione magica di un narrare che non impediva allo scrittore di guardare la realtà con feroce precisione e puntuale lucidità. Ma che, al tempo stesso, si nutriva del gusto dell’invenzione in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. In più, a insaporire la storia era lo sberleffo potente scaricato sugli aspetti grotteschi del vivere.
Nel 1983, lo sceneggiatore Luciano Tovoli firmerà il suo unico film da regista, Il generale dell’armata morta, appunto, scritturando il grande Marcello Mastroianni assieme a Michel Piccoli, e affidando una parte al giovane Sergio Castellitto.
È logico che il regime albanese non potesse accogliere con favore un romanzo come Il generale dell’armata morta. Anche perché, in uno Stato che aveva scelto di azzerare ogni tipo di culto religioso, non poteva non dare fastidio un libro in cui veniva tratteggiata la figura di un sacerdote “come un uomo simpatico”. E poi, in ogni caso, andare a rivangare la storia della presenza italiana in Albania, costellata da episodi di assoluta ferocia, non poteva che riaprire ferite non ancora non del tutto rimarginate.
Quasi vent’anni dopo la pubblicazione del Generale, Giorgio Manganelli avrebbe dedicato a Kadare parole lusinghiere sul “Corriere della Sera”. Sottolineando la sua capacità di fare del grande amore per la letteratura classica, dell’arcaicità insomma, “uno stile, un modo calmo e tragico di essere, di parlare, di celebrare”. Perché quel ricorso a stilemi e rimembranze antiche assume “una precisione e una forza cerimoniale”.
Quanta forza possa avere l’irrompere del mito nella realtà lo dimostra tutta la produzione letteraria di Kadare. Sempre in equilibrio tra la lezione di Eschilo e quella di Shakespeare, senza dimenticare Dante, gli scrittori russi, Cervantes, Balzac, ovviamente Kafka, ma anche Buzzati e Beckett. Lo si può riscontrare nel suo lungo percorso narrativo: da I tamburi della pioggia (1970), ambientato all’epoca delle guerre contro i dominatori turchi, a La città di pietra (1971), dal Ponte a tre archi (1978) a Aprile spezzato (1980) e Chi ha riportato Doruntina? (1980). In particolare, un romanzo poco ricordato come Il mostro (pubblicato da Fandango nel 2010), trasfigura l’Albania in una moderna Troia minacciata da un Cavallo che vuole entrare dentro le mura con l’inganno o con la forza, a seconda della situazione che si andrà creando, mentre uno studente rapisce la giovane Lena, innescando un meccanismo di rivendicazioni incrociate simile a quello di Elena, la moglie di Menelao, rapita dal principe troiano Paride.
Spesso, Kadare è stato attaccato per non avere rinnegato completamente l’idea che il comunismo possa creare una via al Potere diversa da quella sperimentata nel corso del ‘900. Senza capire che la critica dello scrittore albanese era rivolta, in maniera molto più ampia e complessa, all’intera macchina repressiva del Potere, che si è andata perfezionando nel corso dei secoli. Mutando forma, cambiando colore politico, ma non perdendo mai quei tenebrosi e sfuggenti connotati che lo scrittore albanese ha descritto nel suo romanzo forse più profetico e inquietante: Il Palazzo dei Sogni. Dove dal misterioso Tabir Sarraj si controlla e cataloga l’intera produzione onirica della nazione, riuscendo a vaticinare il futuro del Paese e a prevenire possibili moti di ribellione.
Del resto, non era accaduto lo stesso al matematico ucraino Leonid Pljušč, internato in manicomio con l’accusa di delirio messianico e di schizofrenia ai tempi dell’Urss, che venne rilasciato dopo quattro anni, il 10 gennaio del 1976, grazie alle pressioni dei dissidenti sovietici guidati da Andrej Sacharov e dell’Occidente? Da uomo libero, lui non rinnegò mai il suo credo socialista.
Per descrivere bene il lungo viaggio compiuto da Kadare all’interno dell’esercizio del Potere nel corso della Storia non si può non ricordare un romanzo come La piramide (Longanesi 1993). Dove il giovane faraone Cheope viene convinto che costruire la sua gigantesca piramide è sicuramente un atto stupido e velleitario. Però quel monumento all’inutile finirà per rafforzare e ribadire l’assolutismo del Potere. Metafora potente della Ragion di Stato fondata sulla violenza e la prevaricazione.
Nel 1990, Kadare, più volte candidato al Nobel per la Letteratura, ha deciso di lasciare l’Albania, scatenando commenti non molto lusinghieri sul suo conto. Visto che molti intellettuali gli contestavano di non essersi mosso fino alla morte di Hoxha e di avere abbandonato il Paese proprio mentre era in corso una faticosa, accidentata necessaria trasformazione del regime sotto la guida di Ramiz Alia.
Lui, in realtà, non ha mai cercato di trasformare la sua richiesta di asilo politico in Francia in un atto di eroismo. “Non posso dire che è stato difficile rispetto alle fughe drammatiche, o anche tragiche, di chi tentava di passare la frontiera. Io sono partito con l’aereo munito di passaporto. Mi sono fermato a Parigi e non sono più ritornato”. Molti anni dopo racconterà lo strazio di aver lasciato la vecchia madre in Albania in un bellissimo romanzo, tradotto da Liljana Cuka per la Nave di Teseo nel 2017: La bambola.
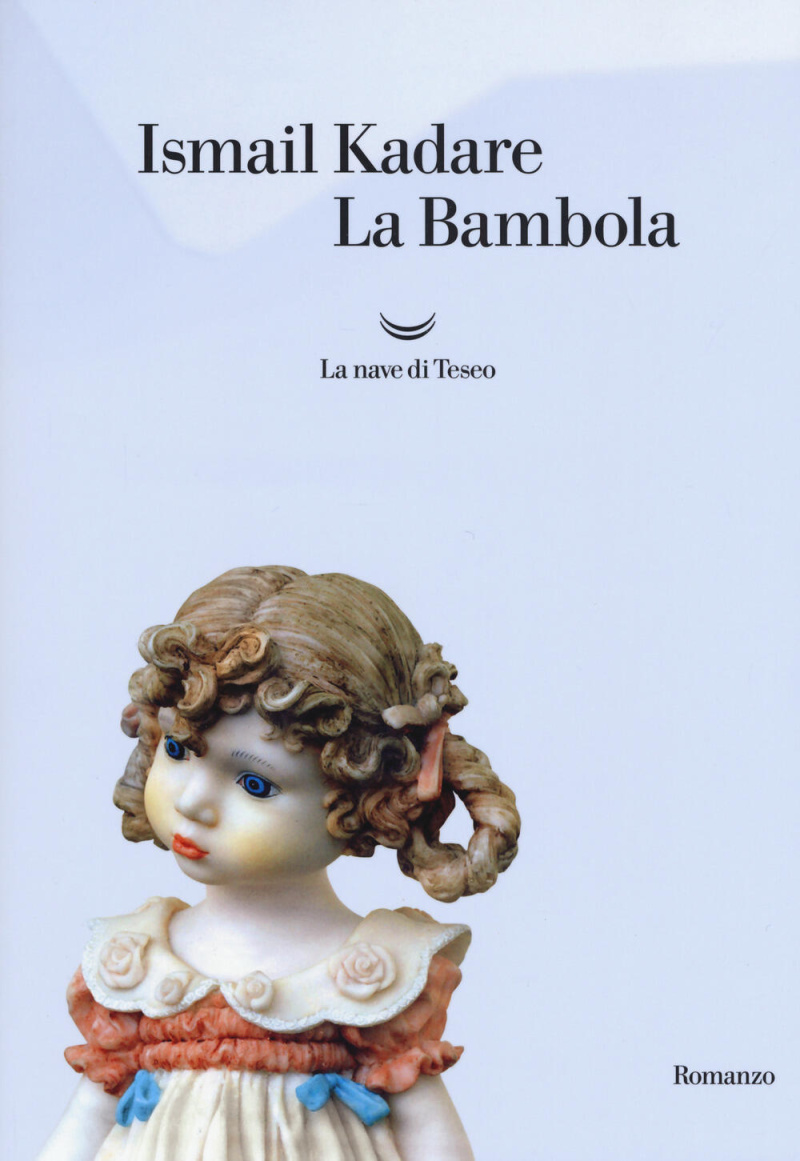
Sui cambiamenti del regime, invece, non ha mai avuto parole tenere: “Ho sperato come gran parte del popolo albanese e degli intellettuali. Ho sperato, ma poi mi sono pentito di averlo fatto, niente era vero, era tutto una grande menzogna. Ribadisco, la mia fuga fu obbligata. Bisognava porre fine a quella fiducia faziosa perché lo stato albanese mentiva in modo spudorato. È senza precedenti e raro in tutta la storia dell’umanità un simile cinismo”.
Il collegamento di Kadare con la cultura italiana è sempre stato forte. Non bisogna scordare, ad esempio, il lucido e personalissimo saggio dedicato dallo scrittore albanese all’Alighieri: Dante o l’inevitabile (Fandango 2008). In cui non soltanto scandagliava la complessa struttura visionaria della Divina Commedia, ma metteva in luce il legame forte tra due mondi come l’Italia e l’Albania. Che troppo spesso, da parte nostra, hanno lasciato spazio a violenti sogni di dominio, seguiti da lunghi periodi di colpevole oblio.
Oggi che Kadare non c’è più, rimane la forza delle sue storie, premiate con il Man Booker Prize nel 2005, il Principe delle Asturie nel 2009, il Nonino nel 2018. Quella voglia inestinguibile di ribellarsi al Potere, qualunque forma assuma. E il suo amore sconfinato per la letteratura, vissuta come un destino predefinito da qualche misteriosa entità: “Io appartengo alla razza degli scrittori – ripeteva spesso –. Che è stata creata per scrivere. E io non posso che obbedire a questo istinto”.
Ismail Kadare era nato per inventare storie, per immaginarle e raccontarle. Lo ha fatto per tutta la vita, ascoltando il sussurro potente del suo daimon. Un codice dell’anima, come lo chiamava James Hillman, che lo obbligava a essere libero. Se non altro dentro i confini delle pagine scritte.







