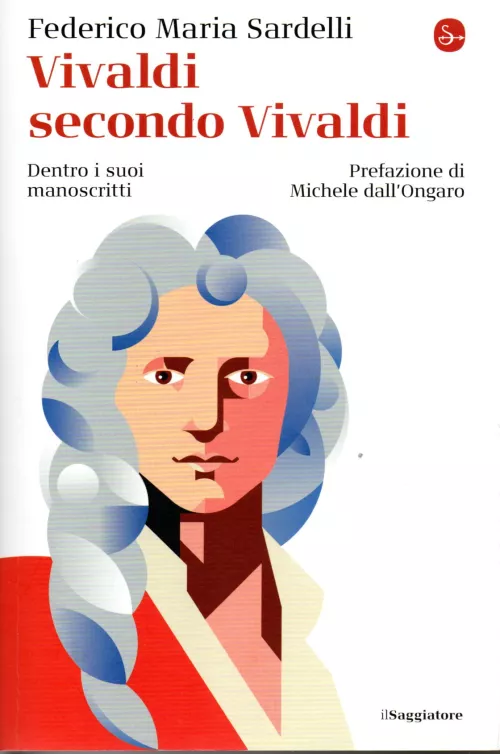Vivaldi secondo Vivaldi
Oggi è nella ristretta cerchia dei compositori classici davvero popolari, sempre più spesso eseguito nelle sale da concerto, rappresentato nei teatri, consegnato a una discografia imponente. La sua musica – come inevitabilmente accade in questi casi e di questi tempi – oltre a essere ormai largamente nel repertorio è utilizzata nelle maniere più divaganti e spesso banali, ridotta a sottofondo ambientale o ad accompagnamento della pubblicità, ma anche “rielaborata” da autori significativi, come Max Richter, che hanno riflettuto sulla sua arte in chiave post-moderna (“Vivaldi recomposed”, secondo la sua definizione).
Si tratta di un fenomeno relativamente recente: ancora negli Anni Cinquanta del secolo scorso, Antonio Vivaldi (nato a Venezia il 4 marzo 1678 e morto il 28 luglio 1741 a Vienna, dove fu sepolto in una fossa comune dopo un “funerale dei poveri”) era noto solo a una ristretta cerchia di appassionati, grazie specialmente all’attività di alcuni complessi strumentali che avevano adottato la sua musica per quasi due secoli rimasta nell’oblio, proponendola nei loro concerti, non senza un certo sprezzo del rischio per l’originalità delle loro scelte. Si chiamavano “I Musici”, “I Virtuosi di Roma”, “I Solisti Veneti”. La loro fondamentale iniziativa discendeva dalla riscoperta esecutiva iniziata poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nell’ambito del festival voluto a Siena dal conte Guido Chigi Saracini per le attività concertistiche dell’Accademia che porta il suo nome e che aveva fondato nel 1932. Fu quello il capitolo decisivo di una storia che non si può non definire romanzesca. Perché solo da pochi anni era stata avventurosamente quanto sapientemente recuperata una vasta porzione dell’immenso giacimento delle musiche del cosiddetto “prete rosso”, fino a quel momento note solo agli allora rari cultori della musica barocca e solo per le composizioni che erano state pubblicate durante la sua vita: una quarantina di Sonate per lo più a violino solo e basso continuo, riunite in cinque raccolte, e un’ottantina di Concerti per archi e strumenti solisti (soprattutto violino, ma anche flauto), riuniti in nove raccolte. Quasi tutti stampati ad Amsterdam, fra i primi anni Dieci e la fine degli anni Venti del Settecento.
Queste edizioni erano solo la punta dell’iceberg di una produzione vastissima, che supera le 800 composizioni, fra cui circa 500 Concerti, una cinquantina di opere, molta musica sacra. La parte quantitativamente più cospicua di tale produzione – gli autografi e i manoscritti dell’archivio personale del musicista, rimasto a Venezia in occasione del suo ultimo viaggio – prese la strada di Genova alcuni decenni dopo la sua morte, per iniziativa di un importante uomo di musica, il conte Giacomo Durazzo. Fra il 1764 e il 1784 questi era l’ambasciatore della Repubblica ligure presso la Serenissima, dopo essere stato per un decennio, alla metà del XVIII secolo, “Generalmusikdirektor” a Vienna. Qui aveva avuto un ruolo decisivo nella cosiddetta riforma del melodramma incarnata da Orfeo e Euridice di Gluck. Insomma, era la persona giusta per capire il valore di quella montagna di carte pentagrammate.

Lo straordinario giacimento fu custodito nella biblioteca del palazzo dei Durazzo a Genova per oltre un secolo, intatto fra un passaggio ereditario e l’altro, e solo alla fine dell’Ottocento fu diviso in due. Una parte rimase a Genova, l’altra prese la via del Monferrato e del castello del conte Marcello Durazzo. Il quale a sua volta decise di lasciare le partiture in suo possesso ai salesiani del collegio San Carlo a Borgo San Martino. Gli era stato assicurato che avrebbero tenuto le carte “religiosamente”: in realtà dopo averle trascurate e mal conservate le misero in vendita – e siamo ormai alla metà degli anni Venti del Novecento – per finanziare le loro attività.
A questo punto entrarono in scena i due protagonisti principali della storia, entrambi torinesi: il musicologo Alberto Gentili, creatore della prima cattedra di Storia della musica in un’università italiana e il direttore della Biblioteca Nazionale di Torino, Luigi Torri. Al primo va il merito di avere identificato e capito il valore di quella musica, il secondo riuscì a trovare il finanziamento necessario ad assicurare le carte alla sua Biblioteca, perché lo Stato non assicurava alcun sostegno economico all’operazione. La prima acquisizione andò in porto grazie alla sponsorizzazione di un agente di cambio ebreo, Roberto Foà, che intendeva in questo modo onorare la memoria del figlioletto morto, al cui nome il fondo doveva essere intitolato. Pochi anni e molte complicate e ingegnose ricerche più tardi, l’altra metà dell’archivio, scoperta a Genova, fu riunita alla prima. L’operazione avvenne nello stesso modo, con il decisivo apporto finanziario di Filippo Giordano, industriale pure di ascendenza ebraica. Anch’egli fornì il suo contributo – singolare coincidenza – per mantenere la memoria di un figlio morto in tenera età. E così la collezione della maggior parte delle musiche di Antonio Vivaldi, finalmente riunita, prese il nome, ora alla storia, di Fondo Foà-Giordano.

Fino a quel momento il regime fascista era stato a guardare. La situazione cambiò nel 1938, dopo la promulgazione delle nefaste leggi razziali: ebrei i finanziatori dell’acquisizione del fondo, ebreo il musicologo che ne aveva rivelato l’importanza. Troppo per gli zelanti gerarchi mussoliniani. Mentre Gentili veniva brutalmente epurato dall’università di Torino e costretto ad emigrare in Svizzera, iniziò l’operazione di appropriazione ideale e di restituzione pratica “del Vivaldi”, a quel punto proclamato “compositore italianissimo”. Protagonisti di primo piano, oltre al conte Chigi, ne furono il compositore Alfredo Casella e in qualche misura perfino il grande poeta americano Ezra Pound, sostenitore del regime e da esso benvoluto, desideroso di far suonare Vivaldi alla sua amante Olga Rudge, violinista.
Questa storia complicata e appassionante è stata raccontata una decina di anni fa in un libro di notevole successo. Il suo autore, Federico Maria Sardelli, 61 anni, livornese doc (e non per caso fin dall’adolescenza collaboratore del Vernacoliere), è uno dei personaggi più singolari ed eclettici dello spettacolo e della cultura non solo musicale in Italia. Flautista e direttore d’orchestra, oltre che interprete di primo piano, egli è anche uno dei più accreditati musicologi vivaldiani internazionali. Responsabile del catalogo del “prete rosso” (i cui aggiornamenti sono pubblicati sulla rivista Studi vivaldiani dell’Istituto dedicato al musicista, costituito alla Fondazione Cini di Venezia), è di fatto lo studioso al quale spetta l’ultima parola sull’autenticità dei ritrovamenti che ancora si verificano in Europa e sull’attribuzione delle musiche al “prete rosso”.
Intitolato L’affare Vivaldi, come un giallo, quel libro (Sellerio 2015, pagg. 304, € 14,00, Premio Comisso Narrativa e Prix Pelléas) ha segnato il brillante debutto di Sardelli come scrittore: una narrazione coinvolgente, non priva di suspence, a piani cronologici sovrapposti e intersecati fra la Venezia della metà del Settecento e la Torino degli anni Trenta del Novecento, nella quale una dose controllata di fiction (inevitabile in una vicenda che conta una cinquantina di personaggi) si inserisce con naturalezza nello schema documentato degli eventi, fino al salvataggio e alla riunione dei manoscritti e alla nascita della figura di Vivaldi così come oggi la conosciamo.

Da allora, Sardelli ha continuato a scrivere, finora senza mai uscire dal mondo vivaldiano, che appare in effetti una miniera pressoché inesauribile di spunti e racconti. Si è occupato del Volto di Vivaldi (Sellerio 2021, pagg. 304, € 24,00), ricostruendo l’immagine di un compositore notissimo ai suoi tempi e caduto rapidamente nell’oblio dopo la morte, analizzando ritratti veri e presunti, svelando apocrifi e falsi, disegnando le vicende degli artisti che si cimentarono nei ritratti dell’autore delle Quattro Stagioni. Un percorso – anche questo – compiuto con la sensibilità di chi è del mestiere, visto che fra le sue molteplici attività Sardelli ama sottolineare quelle di pittore e disegnatore. In seguito, ha pubblicato una fascinosa narrazione biografica fra romanzesco e documentario, intitolata Lucietta. Organista di Vivaldi (Sellerio 2023, pagg. 328, € 15,00). Si tratta di una singolare proposta di “vite parallele”, di un racconto nel quale le vicende del compositore si intersecano con quelle di una delle “putte della Pietà”, le fanciulle orfane che erano le allieve e le prime esecutrici dei lavori del “prete rosso”. Come sempre, quando scrive Sardelli, supportando tutto quello che pertiene all’invenzione con la plausibilità del contesto disegnato dalla perfetta conoscenza dei documenti e delle cronache dell’epoca.
E si arriva così al lavoro più recente, Vivaldi secondo Vivaldi (Il Saggiatore 2024 pagg. 326, € 26,00, con una prefazione del compositore Michele Dall’Ongaro, presidente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia). In questo caso, il romanziere si fa da parte e lascia tutta la scena allo storico e al musicologo. Ma non cessa la chiarezza che costituisce il tratto saliente della scrittura di Federico Maria Sardelli. Esattamente come è all’insegna della chiarezza il suo multiforme impegno come direttore d’orchestra.

Il lavoro è collegato al più recente seminario annuale tenuto alla Fondazione Cini, ma non è cosa solo da specialisti. Lo chiarisce all’inizio lo stesso Sardelli: «Questo libro si rivolge a tutti coloro che eseguono, trascrivono, pubblicano o semplicemente amano la musica di Vivaldi». L’ultima categoria, quella dei “semplici appassionati” è la più numerosa, naturalmente. Ma è anche, forse, quella che può trovare le suggestioni più stimolanti nel percorso qui delineato dal musicologo livornese. Si tratta di un viaggio dentro ai manoscritti originali – i cui dettagli decorano, verrebbe da dire infiorano riccamente tutto il volume – alla ricerca e alla definizione delle più adeguate e fedeli condizioni esecutive, sulla base di quanto il musicista aveva scritto o aveva fatto scrivere ai suoi fidi copisti, il principale dei quali era il cognato, marito dell’amata sorella. E si parla delle note, naturalmente, con tutti i segni aggiuntivi che le riguardano, ma anche delle diciture, più o meno astrusamente abbreviate, che compaiono sulle partiture. Che erano e sono altrettante istruzioni rivolte a chi deve dare vita sonora a quei pentagrammi.
Per esempio: si fa presto a dire “Allegro”, l’aggettivo che definisce il tempo (riguardo alla velocità di esecuzione) della maggiore parte dei movimenti delle Sonate e dei Concerti vivaldiani (e un po’ di tutti i musicisti dal Barocco al Novecento avanzato, viene da aggiungere). Ma qual è la velocità giusta? Ed esiste, soprattutto, la velocità giusta nell’esecuzione di un “Allegro” vivaldiano? Perché intanto, come solo il “custode” del catalogo vivaldiano poteva fare, Sardelli ci spiega che nei manoscritti, oltre al termine puro e semplice, Vivaldi adotta qualcosa come 26 “declinazioni” per attenuare (soprattutto) o accentuare. Ovvero termini aggiuntivi in virtù dei quali la gamma esecutiva va da “Allegro molto più che si può” a “Allegro mà poco poco”. Un multiforme universo espressivo, evidentemente. Per orientarsi nel quale è indispensabile sapere che nella maggior parte dei casi Vivaldi intendeva rallentare il tempo “Allegro”, non accelerarlo.
Lo stesso discorso lo studioso affronta per tutto il complesso edificio delle coordinate interpretative, dal colore del suono grazie alla gamma delle dinamiche (da “pianissimo” a “fortissimo” lungo una serie assai sfumata di mezze misure) all’articolazione del fraseggio, dalle caratteristiche degli ornamenti e relativo modo di realizzarli (fra solisti e orchestra) agli “effetti speciali”, come l’autore chiama i pizzicati o l’uso delle sordine. Tutto sempre basandosi su quello che sta scritto negli originali.
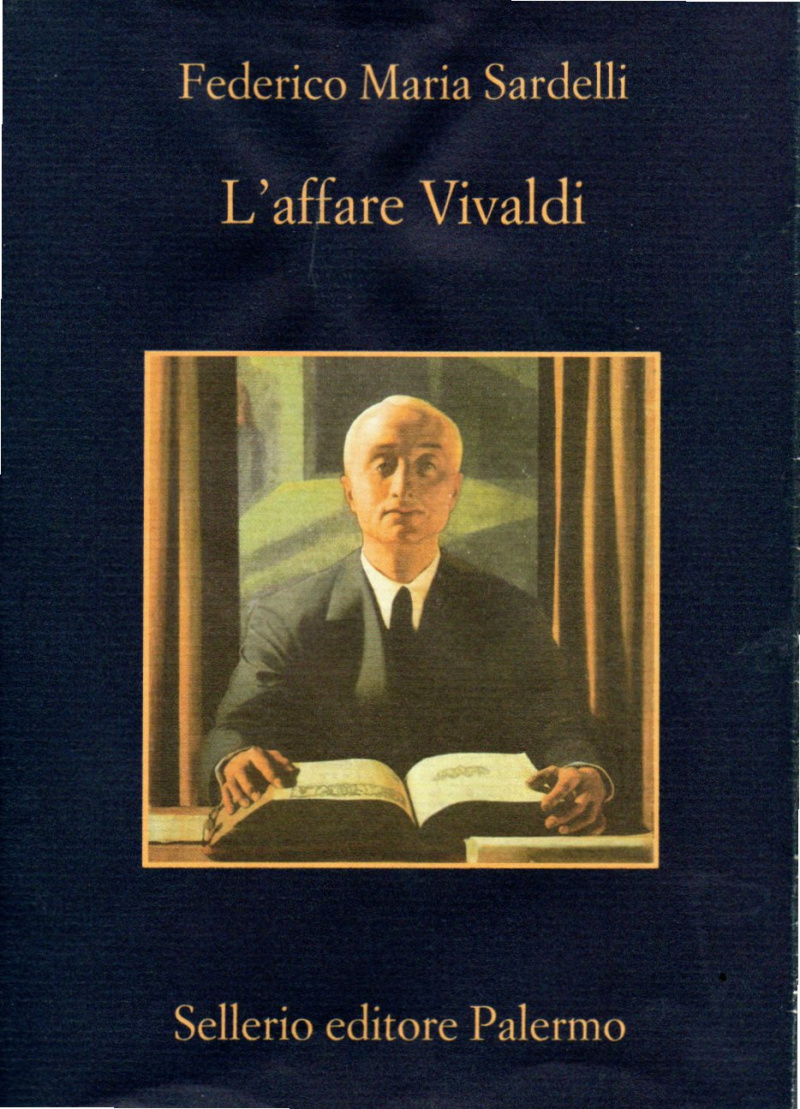
E qui si arriva al punto centrale del discorso di Sardelli. Che percorre trasversalmente l’intero libro: la questione delle esecuzioni secondo prassi esecutiva filologica, o come si preferisce dire oggi, “storicamente informate”. Una consuetudine che si è affermata sempre più impetuosamente a partire dagli anni Settanta del secolo scorso e che appare oggi imprescindibile: uso di strumenti antichi o di copie di quelli, esecuzioni volte idealmente a ricostruire quelle dell’epoca di composizione. La posizione dello studioso, lucidamente consapevole delle esasperazioni e degli errori della “nuova pratica”, è chiara: «Nessuno può credere alla ricreazione esatta dei fenomeni musicali del passato; ma una ricostruzione seria, attendibile, che si avvicini sempre più all’originale quanto più venga approfondito lo studio delle fonti storiche, quella sì è ben credibile e realizzabile». E dunque, i documenti come punto di partenza ma anche come traguardo per la definizione del gusto e del gesto esecutivo.
Così la lettura di questo interessante saggio specialistico può regalare anche al “semplice appassionato” un’esperienza nuova. Per esempio, ascoltare le Quattro Stagioni con orecchio diverso. E scoprire quanto la grandezza di questi Concerti vada oltre la maniera delle loro innumerevoli e non sempre convincenti interpretazioni.