Paul Bley, per l’impossibile ci vorrà del tempo
La Red Records, etichetta jazz fondata a Milano nel 1976 su iniziativa di Sergio Veschi e tutt’ora in attività, ha ristampato da poco il disco Blues for Red del pianista canadese Paul Bley, disco registrato in perfetta solitudine nello studio di Giancarlo Barigozzi nel maggio del 1989. Si tratta di un disco singolare nella discografia di Bley, ma di assoluto rilievo. Ci offre infatti un Bley che esplora con originalità le diverse forme della musica di matrice afroamericana, il blues, il gospel, il boogie, fino ad arrivare, per assurdo che possa sembrare, a farsi imprevedibile anello della scuola pianistica di New Orleans che da Jelly Roll Morton passa per Professor Longhair e James Booker arrivando a Dr. John, allargando inoltre lo sguardo alla dimensione latina grazie allo squisito bozzetto di Latin Thing, che consente a noi di collegare, via New Orleans, le diverse tradizioni musicali afrocaraibiche alla tradizione nera così come si è sviluppata negli Stati Uniti.
È anche un disco che a fianco dei tanti lavori più noti aiuta a capire perché Paul Bley sia considerato da musicisti e addetti ai lavori uno dei più grandi pianisti della storia del jazz moderno, e perché Keith Jarrett, padrone incontrastato del pianoforte jazz nell’ultimo mezzo secolo, ne sia rimasto così fortemente influenzato in gioventù (Jarrett dichiarò di aver ascoltato Footlose!, il disco registrato in trio da Bley ad inizio anni ‘60, migliaia di volte). Fin dalle prime tracce di Blues for Red – il brano omonimo ma ancor più Rear Projection, che con le sue armonie liberate dalla gabbia del blues ci proietta nella dimensione gospel tanto amata ed esplorata anche da Keith Jarrett – siamo immersi in un che di famigliare, quanto meno per chi ama il Jarrett delle escursioni solistiche. Se Jarrett trovò in Bley una guida e un’ispirazione in inizio di carriera, ascoltando queste tracce viene spontaneo chiedersi quanto Bley abbia ascoltato Jarrett dopo la sua fulminante ascesa, in particolare il Jarrett dei dischi in solo, dal Köln Concert in poi, in un gustoso quanto inevitabile confronto fra i due. Consegniamo questo possibile raffronto agli specialisti notando invece una differenza non di natura musicale, quanto piuttosto caratteriale. Se c’è infatti una cosa che Keith Jarrett a differenza di Paul Bley non avrebbe mai fatto, sarebbe stato di intitolare un brano di pianoforte solo registrato in Italia, Solo mio. Ciò che ci suggerisce, ed è un dettaglio solo in parte aneddotico, come Paul Bley fosse dotato di ironia e di un notevole senso dell’umorismo, imparentandolo in questo a jazzisti come Paul Desmond – come scordare il suo Bossa Antigua nel pieno del boom della bossa nova a inizio anni ’60 – o Mose Allison – citiamone una soltanto, manifesto del politicamente scorretto, Ever since I stole the blues – per non parlare di Dave Frishberg – I’m hip, anche qui, fra le tante – tutti jazzisti che non avrebbero sfigurato in un copione di Woody Allen.
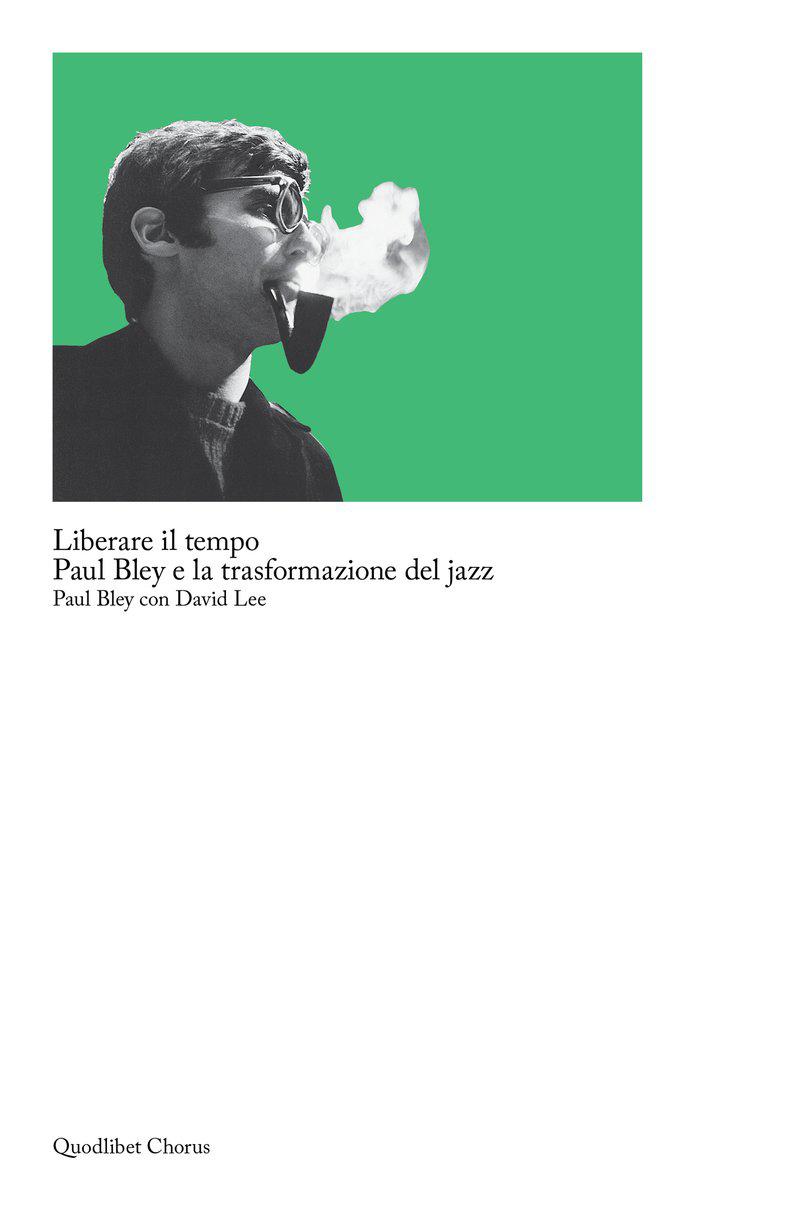
Il fatto che Paul Bley fosse dotato di un invidiabile senso dell’umorismo emerge a più riprese nel libro Liberare il tempo. Paul Bley e la trasformazione del jazz (ed. Quodlibet, nella collana Chorus) pubblicato di recente. Un esempio su tutti: quando Bley racconta di come, nel 1958, alla testa di un quintetto costituito da quello che sarebbe poi diventato il quartetto di Ornette Coleman (con Don Cherry, Charlie Haden e Billy Higgins), realizzò che quel gruppo avrebbe condotto il jazz “fuori dalle secche del be-bop”. Questa era una delle due cose che Paul Bley realizzò in quei giorni. L’altra è che quando transitavi in macchina davanti all’Hillcrest Club, il locale di Los Angeles dove il quintetto si esibiva, capivi facilmente se la band era sul palco o meno: “se la strada di fronte al locale era piena di gente con il bicchiere in mano, voleva dire che stavamo suonando. Se invece la gente era dentro, c’era un intervallo”.
Stiamo parlando di un gruppo di musicisti e di una stagione che ha letteralmente rivoluzionato il jazz, oltre che di un momento chiave nella carriera di Paul Bley. Bley da un lato trova modo di riderci su (non dimentichiamo che era cresciuto con il be-bop – suonò fra gli altri con Charlie Parker nel 1953 – il jazz più serio che fosse mai stato suonato fino ad allora), ben consapevole che nessuno all’epoca era pronto per quel salto in avanti, e dall’altro colloca quella rivoluzione nel regno di un impossibile che avrebbe faticato a imporsi: il difficile lo farò adesso, per l’impossibile ci vorrà del tempo, dice citando due versi della canzone Crazy he calls me incisa da Billie Holiday nel 1949.
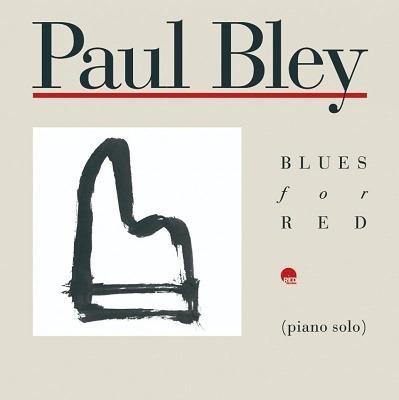
La storia del jazz non è in fondo diversa da tutte le altre. Vive di colpi di scena, personaggi principali, eroi, antagonisti, figure minori, primedonne, caratteri eccentrici, alti e bassi, incidenti di percorso, inattesi balzi nel vuoto. Nell’introduzione al libro Liberare il tempo il prefatore Stefano Zenni definisce Bley “un irregolare, uno di quegli artisti inclassificabili, che sfugge alle categorizzazioni”. In copertina una fotografia di Bley scattata a Lugano nell’agosto del 1966, dov’era sbarcato col suo trio – Mark Levinson al contrabbasso e Barry Altschul alla batteria – per esibirsi nell’ambito dell’allora Festival Internazionale del Jazz che avrebbe ospitato anche Keith Jarrett nel 1969 – un mese dopo l’incisione del disco Ramblin’ negli studi della RCA a Roma. È un Bley colto con l’inseparabile pipa in bocca, una pipa a forma di sassofono che gli conferisce un’indiscutibile aria da intellettuale. Paul Bley: un irregolare in un ambito, quello del jazz di ricerca, dove di regolare, a rigor di logica, non dovrebbe esserci granché, ma dove in verità, come in ogni altro ambito, vigono se non proprio delle regole, delle categorie di pensiero e delle classificazioni che a loro volta possono farsi principio, se non proprio canone. Essere un irregolare fra gli irregolari può voler dire che quando il proprietario di un locale ti mette in cartellone prima del gruppo di Louis Armstrong e tu chiedi a quel proprietario perché ti abbia fatto un dono del genere, quello, come se niente fosse, ti risponda: “avevamo bisogno di qualcuno che svuotasse il locale tra un set e l’altro”.
Il titolo originale del libro recita Stopping Time, che i curatori dell’edizione italiana hanno tradotto in Liberare il tempo. Vale la pena soffermarsi non tanto sulla scelta del verbo liberare, assolutamente condivisibile, ma su quel che Bley intendeva quando parlava di fermare il tempo, proprio perché è uno degli aspetti chiave della sua visione musicale, un concetto che illustra bene il ruolo avuto dal pianista canadese nella rivoluzione del jazz a cavallo fra anni ’50 e ’60. Per farlo è però necessario fare un passo indietro, a quel fatidico 1958, quando la sua strada incrociò quella di Ornette Coleman. Paul Bley era un pianista. Suonava, dunque, uno strumento che nel jazz aveva fin lì svolto la funzione di occupare e definire lo spazio armonico. Paul Bley fu probabilmente il primo musicista di jazz, prima di Ornette, prima di chiunque altro, che cercò di scardinare lo schema canzone e il sacro principio che pretende sia sempre l’armonia a dettare le regole del gioco. E fece questo, oibò, da pianista. La cosa è non solo rilevante, ma per molti versi sconcertante, perché l’ambizione d’un tratto diventa non solo quella di rivoluzionare il jazz, ma di trasformare la funzione stessa di uno strumento che era sempre stato pensato su altri principi e suonato con ben altre finalità.
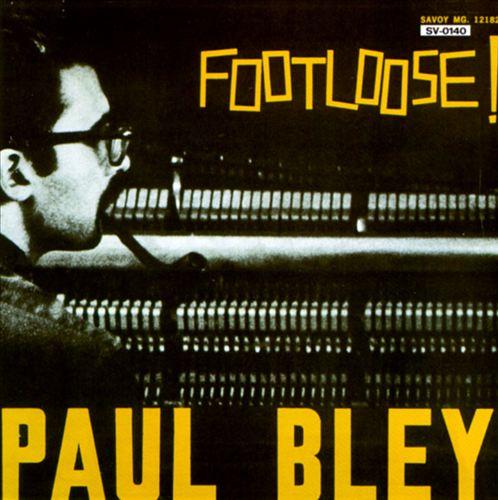
Se già questa rivoluzione risultò indigesta a molti (“gli strumenti ora non avevano più un ruolo chiaro e stabilito” scrive Bley. “Chitarra e pianoforte risultavano pericolosamente obsoleti”), figuriamoci la successiva, quella cioè che ambiva a fermare il tempo. Paul Bley chiarisce bene le sue intenzioni in questo passo: “con Ornette il contrabbasso si era buttato nella mischia, ma la batteria continuava a scandire il tempo metronomico: non per forza ogni quarto della battuta, ma teneva comunque una pulsazione regolare. Con l’avvento di Sunny Murray, Paul Motian e Milford Graves” (tutti batteristi coi quali Bley aveva collaborato, ndr) “anche la batteria si unì al contrappunto del basso. In tanti erano riusciti a gestire la mancanza di progressioni armoniche, anche se per molti di loro fu piuttosto traumatico e continua a esserlo tuttora. Per quanto mi riguarda, quando la batteria smise di tenere il tempo, la musica assunse un aspetto completamente diverso rispetto a una settimana prima. Per molti musicisti, invece, senza contare buona parte del pubblico, perse completamente di significato”. Credo sia difficile inquadrare meglio il senso della rivoluzione abbracciata da molto jazz fra anni ’50 e ’60: quando la batteria smise di tenere il tempo. In ambito musicale un atto del genere non è soltanto innovativo; significa mandare all’aria tutto quanto. Senza la misura del tempo la musica smarrisce probabilmente qualcosa di ancor più importante del battito metronomico; resta orfana di una pulsazione che abbiamo in noi, qualcosa che ci imparenta a quanto ci circonda. Cercare di infrangere questa barriera è sì un atto liberatorio ma è al tempo stesso disorientante e per molti versi sconvolgente, proprio perché la musica, d’un tratto, chiede a noi di orientarci su di un tempo tutto da inventare, un tempo scansionato lì per lì, un tempo di cui siamo infine demiurghi e padroni.
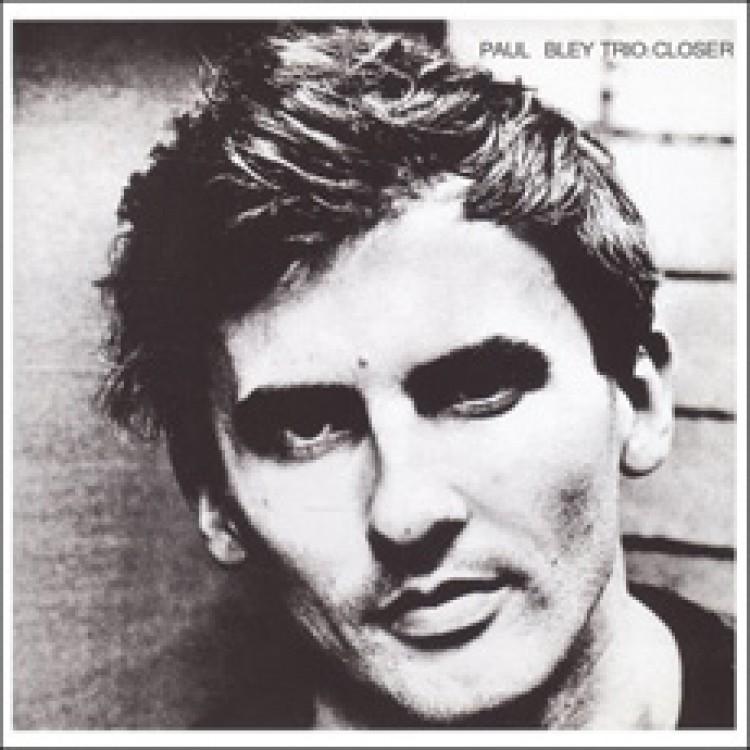
La questione qui si fa particolarmente complessa, oltre che affascinante. Come rileva lo storico della musica Ted Gioia, fin dagli anni ’60 le neuroscienze hanno evidenziato come le onde cerebrali misurate in soggetti che stanno ascoltando della musica tendono a sincronizzarsi col ritmo ascoltato. In tutte le tradizioni del pianeta, in particolare laddove la musica svolge una funzione di tramite, di veicolo verso uno stato di trascendenza, l’ascolto di un ritmo regolare per un certo lasso di tempo induce uno stato di trance. Rompere quella regolarità potrebbe insomma comportare una perdita di sincronia che va ben oltre il mero impulso a battere il piede per mettersi a ballare al ritmo della rumba o del mambo. Non è forse un caso che proprio quando il jazz ambiva a fermare il tempo, il rock prese per molti versi il testimone ritmico del pianeta, accentuando ancor più il beat, e ponendosi di fatto come l’erede naturale del Fascinatin’ rhythm o dell’I got rhythm di gershwiniana memoria (un titolo su tutti: Get rhythm che Ry Cooder riprese da Johnny Cash; da notare il pubblico dello studio televisivo che batte le mani all’unisono).
L’impossibilità di cui si fece carico quella generazione di musicisti e di cui Paul Bley fu uno dei protagonisti, sta al cuore stesso del ribaltamento che portò il jazz a esplorare nuove forme, collocandosi gioco forza in un avamposto che ancor oggi appare come un luogo estremo, quando non sommamente inaccessibile. È certo che quella rivoluzione radicale non fu soltanto estetica, ma comportava una totale rimessa in gioco del nostro rapporto col mondo. Sun Ra invitava a orientarsi fiduciosi verso altre galassie, ma l’indugio di tanti fu ed è ancora comprensibile. Ordine armonico e scansione ritmica sono ancore che non tutti sono disposti ad abbandonare, ma un libro come questo, che documenta brillantemente la vicenda umana e artistica di Paul Bley, illustrando altresì come per lui, al pari di molti musicisti del periodo, fra la ricerca musicale e l’avventura dello stare al mondo non vi fosse frattura alcuna, arte e vita coincidevano al più alto grado, un libro come questo, dicevo, può essere prezioso non solo per l’appassionato di jazz ma anche per chi guarda al jazz, e in particolare al jazz di ricerca, al jazz libero, da lontano, magari con diffidenza e con un certo qual timore (non sono solo le donne che odiavano il jazz e non se ne capisce il motivo, come canta Paolo Conte, diciamo pure che il jazz, quando si fa tanto astratto, può indurre reticenza in molti). È anzitutto importante, qui come altrove, cogliere le intenzioni e capire quel che sta succedendo. Questo libro spiega mirabilmente le intenzioni, dando conto di tutto il percorso di Bley, compreso il capitolo non meno rilevante legato alla sperimentazione con i sintetizzatori e la videoarte, liberando un po’ il jazz dalla fama di genere per intellettuali fumatori di pipa a cui è sovente consegnato (oltre che capire quel che succede sul piano teorico, si ride anche molto, e di gusto, leggendo il libro). Una buona idea potrebbe essere quella di accompagnare la lettura di questo agile volume all’ascolto del disco Blues for Red appena ristampato. Non è detto che l’abbinamento si trasformi in un trampolino di lancio verso altre registrazioni di Bley e, perché no, verso le lontane galassie evocate, fra gli altri, da Sun Ra e la sua Arkestra in Space is the place: consider time as officialy ended (considerate il tempo come ufficialmente finito).







