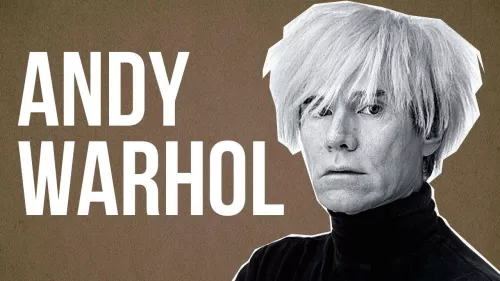Cosa ricorderemo? / La fine della memoria
Nel 1968 Andy Warhol pronunciò la celebre frase: “In futuro tutti saranno famosi per 15 minuti”. Era una profezia, e come tale non bisognava prenderla alla lettera. Non è vero che tutti sono diventati famosi; ma è evidente che la sostanza e le motivazioni della fama sono cambiate radicalmente, nella seconda metà del ‘900. Prima di allora si diventava famosi per azioni meritorie o malvagie; oggi i media confezionano celebrità il più delle volte immotivate e dalla consistenza esilissima. Spesso si gode di popolarità mondiale senza una ragione, come suggerisce una folgorante battuta che gira sul web: “Paris Hilton è famosa perché è famosa”.
Warhol non conosceva ancora internet e la sua bulimia comunicativa. Viveva in un mondo in cui le comunicazioni di massa erano un sistema gerarchico e verticale, lontano dall’orizzontalità (democratica o populista, a seconda delle opinioni) della rete. Perciò credo che oggi Warhol completerebbe la sua frase più o meno così: “Tutti saranno famosi per 15 minuti; ma nessuno, dopo, si ricorderà di loro”.
Io sono un autore e il tema della memoria mi angustia. Mi chiedo, per esempio, se altri registi, scrittori, artisti, compositori si fanno la domanda che io mi pongo da tempo: per chi stiamo lavorando? La risposta è sempre stata naturale. Si scrive, si dipinge, si fanno film per esprimersi testimoniando il proprio tempo. Se si è fortunati, saranno gli stessi contemporanei a riconoscere il nostro talento. In caso contrario, possiamo sempre contare sui posteri. Il tempo dell’arte può non corrispondere al tempo della vita: la storia è piena di autori incompresi che hanno avuto riconoscimento e onore postumi. Un processo sintetizzato dal consolante detto: “Il tempo è galantuomo”. Ma è ancora così? Possiamo ancora credere che, sotto ogni forma, l’arte, nell’era digitale, abbia una seconda chance?

Pensiamo a cosa ha consentito nei secoli la selezione “darwiniana” che ci ha portato al corpus di opere e di autori che oggi celebriamo. Si è trattato di un processo quantitativo e qualitativo insieme. Innanzitutto, il numero delle opere e degli autori. In un’era pre-digitale (e ancora in quella che Benjamin definiva l’epoca della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte), gli artisti, in tutti i campi, erano una nicchia e competevano in un mercato in cui le condizioni materiali avevano un’importanza determinante. Non si trattava solo di essere bravi (o quantomeno ritenuti tali): c’era un “costo”, nel lavoro dell’arte, che definiva la possibilità di circolazione di un’opera. Anche l’attività più economica – scrivere – non poteva prescindere dai costi di pubblicazione. La selezione naturale si applicava in modo diretto: andava avanti innanzitutto chi aveva la possibilità materiale di farlo (anche immeritatamente, talvolta).
Questo, però non garantiva automaticamente la fama. Che è sempre stata di due tipi: di pubblico e/o di “critica”, dove con questo termine si definisce un sistema di addetti ai lavori (e ai valori) che non erano costretti a misurare l’importanza di un’opera sulla sua attualità. Studiosi, insegnanti o – come si dice oggi – trend setters che, molto spesso, facevano di questa attività la loro professione. Imprescindibile, in questo ruolo, era possedere – da un Giorgio Vasari nel Cinquecento a un Gianfranco Contini nel Novecento – qualche forma di autorevolezza morale e intellettuale. Poteva succedere che i due tipi di successo coincidessero, oppure no. L’importante è che l’effetto combinato di tutto questo ha prodotto la memoria dell’arte in ogni forma di espressione, il senso generale di una storia a cui facciamo riferimento nei libri, nelle scuole o semplicemente nella quotidianità.
Quel che si è ricordato ha avuto una ragione per essere ricordato.
Provate adesso a seguire cos’è successo rispetto a questo schema, solo negli ultimi vent’anni, nel mio campo creativo: il cinema. Dal punto di vista del corpus siamo di fronte a una specie di big bang cosmico. Più o meno fino all’inizio del secolo scorso, il formato dell’opera cinematografica era uno: il film. Poteva essere lungo, medio, corto, di fiction o documentario, ma era facilmente riconoscibile. La digitalizzazione ha allargato il campo in modo illimitato. Intanto, da un punto di vista pratico. Fare cinema costava, e molto. C’era una forma di “selezione naturale” già lì, tra chi arrivava a fare un film e chi no. Ma fare cinema è cominciato a costare, grazie all’elettronica, molto meno, con un processo ben noto a chi è passato da una macchina fotografica a pellicola a uno smartphone. Per dirla con Warhol, tutti hanno potuto essere registi per 15 minuti.
Ma la digitalizzazione ha avuto una ricaduta ancora più importante: una volta che ogni immagine è stata riducibile a bit, questo processo ha ibridato tutto l’audiovisivo. Il film ha smesso di essere l’archetipo dell’opus cinematografico: oggi le sovrapposizioni con televisione, rete, arte, reality show, serialità sono tali da mettere in questione la natura stessa del cinema: come infatti riflettono i programmi dei festival più importanti, che ormai propongono film che non sono film, o film che nemmeno usciranno in sala. Dal punto di vista dei registi, che solo negli anni sessanta erano stati sdoganati come autori, il fenomeno è inverso: tendono a confondersi dentro meccanismi nuovi. Chi è l’“autore” di Fargo, la serie tv? I fratelli Coen che l’ispirano? Noah Hawley, che l’ha concepita? I registi che girano gli episodi che – come quasi tutti i registi tv – sono sconosciuti al pubblico?
In poche parole: non c’è più né un sistema univoco di opere né di autori. Certo, ci sono registi che sono famosi in quanto tali: ma la loro popolarità assomiglia più a quella di un brand (i film alla Tarantino, alla Almodovar…) che a quella tradizionale, costruita sulla qualità.
Ma la cosa più sorprendente è la rivoluzione, in soli vent’anni, del ruolo della critica cinematografica. Ancora una generazione fa esprimeva intellettuali che non erano solo recensori, ma alfieri di un’idea di cinema (dal nostro Tullio Kezich a Vincent Canby del New York Times, per fare un esempio). Da giovane cineasta io sono cresciuto dentro una dialettica che non significava solo parlar bene o male di un film: dietro un certo modo di concepire il cinema – e di scriverne – c’era un certo modo di concepire la vita e la società. Tutto questo è scomparso. Certo, sui grandi quotidiani scrivono ancora firme serie e riconoscibili: ma con sempre meno influenza. Come sanno bene gli addetti stampa, oggi conta più l’intervista in esclusiva o il reportage dal set che non la recensione vera e propria. Che invece continua a essere praticata in rete da una miriade di “critici” – autonominatisi tali – che non esprimono nient’altro che se stessi; per non parlare della totale mancanza di autorevolezza morale di siti e blog. Forse, mettendo tutto insieme, si raggiunge un sentiment: ma certo non l’organica comprensione di un fenomeno, che da sempre è stato il tentativo degli intellettuali. È un fenomeno non dissimile dal meccanismo delle fake news. Non importa chi lo dice, basta che un’opinione esista.
Ricapitolando: il campo da studiare è sterminato e troppo intricato; gli strumenti tradizionali inadeguati; e non c’è nessuno in grado di dominare anche solo la pura estensione fisica del corpus delle opere. In questo contesto sperare oggi che un film “incompreso” alla sua uscita possa essere prima o poi rivalutato è del tutto improbabile. Ci sarà sempre talmente tanta roba, e tutta insieme, da non lasciare spazio al passato; e per converso non ci sarà nessuno con una motivazione abbastanza forte (culturale o anche solo professionale) che ritenga utile voltarsi indietro piuttosto che stare al passo coi tempi.
Il conflitto che sta alla base di questo processo è chiaro: la memoria umana è selettiva, quella digitale no. Più ci troviamo di fronte ad archivi globali che non dimenticano nulla, più ci troviamo spiazzati nella nostra capacità di dominare certi processi mentali, di trasformare in narrazione quello che ci succede intorno, di intervenire in modo personale sui processi culturali.
La selezione effettuata dalla memoria non è casuale, è basata sull’esperienza esistenziale collegata in noi a quel ricordo. Ti resta in testa un libro per le emozioni che hai avuto leggendolo, o per il contesto in cui l’hai fatto. Crei una gerarchia, intellettuale o anche solo emotiva. Ma per un database, uno vale uno: La Divina Commedia è uguale a Cinquanta sfumature di grigio. Qualche settimana fa è comparso su La Lettura un affascinante contributo di Claudio Tuniz e Patrizia Tiberi Vipraio a proposito delle domesticazioni: la prima delle quali fu quella degli animali da parte dell’uomo; l’ultima, attualmente in corso, quella dell’uomo da parte delle macchine digitali. Fornisco anch’io una piccola testimonianza personale in proposito.
Da ragazzo, negli anni settanta, quando uscirono i primi combo che accoppiavano giradischi e registratore a cassette, presi – come tanti – non solo a copiare i dischi per ragioni economiche, ma anche a produrre compilation personali. Era una maniera di “impossessarsi” della musica che ascoltavi, per farla più tua. Un’attività che si raffinò negli anni novanta, con la comparsa dei computer e dei CD.
La chiave di questa pratica stava nel limite di capacità: prima delle audiocassette, poi dei CD. Oltre un certo numero di canzoni o pezzi (che azzarderei a definire “umano”), non si poteva andare. Quando con gli I-pod comparvero le prime memorie digitali ad alta capacità il processo si ribaltò. All’improvviso si poteva disporre di centinaia, migliaia di pezzi su un oggetto fisico dall’ingombro minimale. Il problema è che quando un archivio è troppo grande, smetti di gestirlo tu ed è lui a gestire te. La fatica (il piacere) di scegliere, di costruire un percorso è sostituita dal relax di affidare le scelte di ascolto alla macchina: attraverso i comandi random, o attraverso la profilazione dei tuoi gusti. Io resto sempre sorpreso quando vedo come Spotify gratifica la mia compagna di una sua “radio” personale, costruita da un algoritmo che si basa sulle sue scelte precedenti. Non è lei che sceglie cosa ascoltare, è Spotify che pensa che lei voglia ascoltare quello.
Per tornare al punto di partenza: date queste condizioni oggettive, è veramente difficile pensare che qualcuno (inteso come essere umano) possa un giorno trovare il tempo e la motivazione di interrogarsi su un’opera del passato. Non potendo selezionare nulla sotto forma di ricordo, che implica esperienza, ci sarà sempre più informazione da gestire e per di più tutta insieme. Memoria, tempo, esperienza: senza queste coordinate ogni forma espressiva sarà condannata a vivere in un eterno presente che durerà i 15 minuti preconizzati da Warhol, o forse meno. E poi, il sipario. Certo, un caso come quello di Vivian Maier, la street photographer “scoperta” dopo la sua morte, ci induce a sperare che una seconda chance, per un artista, sia ancora possibile. Ma non perché il tempo è galantuomo, bensì come puro fatto casuale. Anzi, randomico.
Questo articolo è stato pubblicato si La Lettura del Corriere della Sera (24/9/2017) che ringraziamo.